|
|
Sei
qui:
Biografie
>
Emilio Salgari, viaggiare con fantasia
Di Massimo
Serra
Introduzione
|
Il
25 Aprile del 1911, moriva tragicamente suicida
a 48 anni Emilio Salgari, il romanziere che con
i suoi cento libri di straordinarie avventure aveva
appassionato intere generazioni di ragazzi. Personaggio
tra i suoi personaggi, coi baffi a manubrio, il cappello
a paglietta e la perenne sigaretta in bocca. Nella
Torino della "Belle époque", nonostante avesse lavorato
senza concedersi riposo per anni ed anni, inchiodato
al suo tavolo, per dar corpo e vita ai personaggi dei
suoi racconti, era vissuto in povertà, ed in povertà
lasciò morendo la moglie ed i figli: Fatima,
Nadir, Remerò e Omar.
|
|
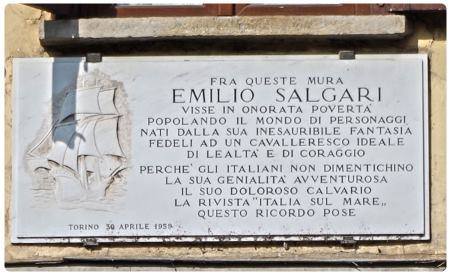 Sulla
facciata della casa di corso Casale 205, dove Emilio
Salgari visse con la famiglia, il 30 Aprile del 1959, fu posta
una lapide, ancora oggi visibile, la cui epigrafe recita:
"Fra queste mura Salgari visse in assoluta povertà, popolando
il mondo dei personaggi nati dalla sua inesauribile fantasia,
fedeli ad un cavalleresco ideale di lealtà e di coraggio. Perché
gli italiani non dimentichino la sua genialità avventurosa e
il suo doloroso calvario. La rivista "Italia sul mare" questo
ricordo pose. Torino 30 aprile 1959" . Sulla
facciata della casa di corso Casale 205, dove Emilio
Salgari visse con la famiglia, il 30 Aprile del 1959, fu posta
una lapide, ancora oggi visibile, la cui epigrafe recita:
"Fra queste mura Salgari visse in assoluta povertà, popolando
il mondo dei personaggi nati dalla sua inesauribile fantasia,
fedeli ad un cavalleresco ideale di lealtà e di coraggio. Perché
gli italiani non dimentichino la sua genialità avventurosa e
il suo doloroso calvario. La rivista "Italia sul mare" questo
ricordo pose. Torino 30 aprile 1959" .
A
questa celebrazione del 1959 prese parte l'allora sindaco, in
rappresentanza di Torino, la città che Salgari scelse lasciando
la natia
Verona. I suoi viaggi furono compiuti solo con
la fantasia, frutto della lettura di decine di libri sui più
svariati argomenti, libri scovati e divorati nelle
biblioteche, fin da giovanissimo. Dopo Verona,
Venezia, ancora Verona e un soggiorno a
Genova di circa due anni, Salgari si stabilì a
Torino dove produsse molti dei suoi romanzi e
novelle e dove avrebbe vissuto il resto della sua vita.

Piccolo riassunto di
una vita
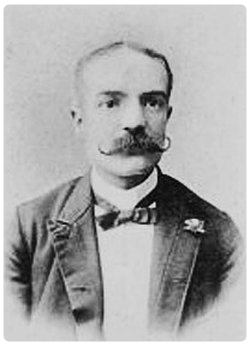 Emilio
Salgari nacque a Verona il 21 agosto del 1862, secondogenito
di tre fratelli: Paolo (nato nel 1861) e Clotilde, (nata nel
1864). Poco più di un anno prima della sua nascita l'Italia
unità era diventata realtà, ma il Veneto avrebbe fatto parte
dell'Impero Austro-Ungarico fino al 4 novembre 1866. Nessuno
avrebbe mai pensato che quel ragazzino minuto, che non
sarebbe mai cresciuto tanto, avrebbe accompagnato
generazioni di giovani ragazzi italiani in un viaggio
infinito nella fantasia. Il padre, Luigi Salgari, era
un possidente terriero e commerciante di panni; la madre,
Luigia Gradara, proveniva da una famiglia benestante
veneziana. Vivevano in Vicolo cieco Pozzo San
Marco 5, in pieno centro, a pochi passi da
Piazza delle Erbe. (anche se la casa dove nacque si
trovava sempre lì vicino, in Corso Porta Borsari 7,
dove oggi si trova una targa commemorativa). Il 7 settembre Salgari fu
battezzato nella Chiesa Santa Eufemia. Emilio
Salgari nacque a Verona il 21 agosto del 1862, secondogenito
di tre fratelli: Paolo (nato nel 1861) e Clotilde, (nata nel
1864). Poco più di un anno prima della sua nascita l'Italia
unità era diventata realtà, ma il Veneto avrebbe fatto parte
dell'Impero Austro-Ungarico fino al 4 novembre 1866. Nessuno
avrebbe mai pensato che quel ragazzino minuto, che non
sarebbe mai cresciuto tanto, avrebbe accompagnato
generazioni di giovani ragazzi italiani in un viaggio
infinito nella fantasia. Il padre, Luigi Salgari, era
un possidente terriero e commerciante di panni; la madre,
Luigia Gradara, proveniva da una famiglia benestante
veneziana. Vivevano in Vicolo cieco Pozzo San
Marco 5, in pieno centro, a pochi passi da
Piazza delle Erbe. (anche se la casa dove nacque si
trovava sempre lì vicino, in Corso Porta Borsari 7,
dove oggi si trova una targa commemorativa). Il 7 settembre Salgari fu
battezzato nella Chiesa Santa Eufemia.
 I Salgari erano
originari della Valpolicella e si occupavano di attività
agricole. Un ramo della famiglia si stabilì a Verona, dove
era nato il padre. Il giovane Emilio trascorse molto tempo
in campagna. Il suo rendimento scolastico non fu dei
migliori. Frequentò nel 1874-75 la prima classe presso il
Regio istituto tecnico, e la ripeté nel 1875-76 e nel
1876-77 presso l’Istituto tecnico comunale: alla terza prova
superò la sessione di esami. Nell’anno scolastico 1877-78 fu
rimandato ma non si presentò alla sessione autunnale. Non fu
mai, per così dire, uno studente modello nella sua Verona,
ma oggi nella sua città natale l'Istituto Comprensivo 13 in
via Durazza è intitolato a lui. Scorrendo i cognomi sugli
elenchi telefonici, qualche Salgari si trova ancora nella
città scaligera. I Salgari erano
originari della Valpolicella e si occupavano di attività
agricole. Un ramo della famiglia si stabilì a Verona, dove
era nato il padre. Il giovane Emilio trascorse molto tempo
in campagna. Il suo rendimento scolastico non fu dei
migliori. Frequentò nel 1874-75 la prima classe presso il
Regio istituto tecnico, e la ripeté nel 1875-76 e nel
1876-77 presso l’Istituto tecnico comunale: alla terza prova
superò la sessione di esami. Nell’anno scolastico 1877-78 fu
rimandato ma non si presentò alla sessione autunnale. Non fu
mai, per così dire, uno studente modello nella sua Verona,
ma oggi nella sua città natale l'Istituto Comprensivo 13 in
via Durazza è intitolato a lui. Scorrendo i cognomi sugli
elenchi telefonici, qualche Salgari si trova ancora nella
città scaligera.
Durante
l'adolescenza Emilio cominciò a sviluppare una evidente
propensione alla scrittura, con bozze di possibili romanzi.
Uno di questi datato primo agosto 1878 lo aveva titolato "Giorgio
Schestakoff, ovvero Un esiliato; un quaderno con nove
illustrazioni e tre carte geografiche era stato titolato
Il capitano Falconara; un altro ancora aveva come titolo
Le Avventure di Simone Van Der nella Nuova Guinea.
Questi primi tentativi di componimento letterario mostravano
allo stesso tempo una aspirazione a viaggiare, scoprire
nuovi luoghi, vivere la vita come una lunga avventura. Una
passione che veniva alimentata da libri e rivisti di
viaggio, atlanti, mappe, strumenti nautici. Fu quasi
scontato per il giovane Emilio provare ad alimentare propensione
per l'avventura e i viaggi
abbandonando gli studi tecnici a Verona per iscriversi al
Regio Istituto Tecnico e Nautico "Paolo Sarpi" di
Venezia, dove avrebbe potuto conseguire un diploma per
imbarcarsi come capitano di gran cabotaggio. Nella città
lagunare vivevano dei parenti materni e la nonna Matilde Trentin.
Salgari non si
presentò all'esame finale per conseguire la licenza di
capitano di gran cabotaggio. I suoi ultimi momenti a Venezia
culminarono nella partecipazione (in veste di spettatore
interessato) a un Congresso geografico del 1881 promosso
dalla Reale società geografica, cui intervennero
esploratori, missionari, militari, navigatori e scienziati,
curiosi di conoscere il mondo, in particolare la selvaggia
Africa e l’esotico Oriente. Fu nello stesso periodo che
nacque la leggenda di un suo viaggio per mare fino a
Brindisi tra l’autunno del 1881 e la tarda estate del 1882,
alimentata dal falso racconto postumo A bordo dell’Italia
Una. Primo viaggio marittimo dell’autore, pubblicato da
Sonzogno in appendice a I cacciatori di foche:
Umberto Bertuccioli, vicecomandante della Capitaneria del
porto di Venezia, all’inizio del Novecento svolse
un’approfondita indagine sui registri d’imbarco e non vi
reperì traccia di Salgari. Il futuro padre di Sandokan compì
solo alcuni viaggi di addestramento a bordo di una nave
scuola e successivamente un viaggio (ma probabilmente solo
in qualità di passeggero) sul mercantile "Italia Una", che
per tre mesi navigò su e giù per l'Adriatico, toccando la
costa dalmata e spingendosi fino al porto di Brindisi.
Tornato a Verona, nel 1883 iniziò a collaborare con il
giornale "La Nuova Arena", sulle cui pagine apparve a
puntate il suo primo romanzo, "Tay-See", stampato
successivamente (dopo aver subito varie modifiche alla
trama) con il titolo "La Rosa del Dong-Giang";
nell'ottobre dello stesso anno escono le prime puntate di "La
Tigre della Malesia". Iniziò così la sua fortunata e
tormentata carriera di scrittore.
Dal 1885
cominciò a lavorare all'altro quotidiano veronese l’Arena,
dove rimase fino al 1893. Qui, firmandosi come
‘Emilio’ o ‘Emilius’ si occupò principalmente di commedie,
opere e operette e balletti. Dopo un’esperienza al
Filarmonico, primo teatro cittadino, fu dirottato ai meno
importanti "Teatro Ristori" o al "Teatro Diurno" di piazza
Cittadella, arena estiva che metteva in scena opere di
autori locali e drammi di Jules Verne e di
Alexandre Dumas. Due suoi romanzi vennero adattati
e portati sulle tavole del Teatro Diurno da Francesco
Serravalli, collega e amico fraterno che nel 1889 mise
in scena con successo I misteri dell’India, e l’anno
seguente La Tigre della Malesia.
Come giornalista
per la Nuova Arena, si distinse con lo pseudonimo di ‘Ammiragliador’,
come commentatore di politica estera e di conflitti
internazionali: il conflitto nel Tonkino che contrapponeva
Francia e Cina; la rivolta mahdista contro Egitto e
Inghilterra. In quegli articoli si intravedeva già lo
scrittore che sarebbe stato.
Da questa
esperienza verrà pubblicato nel 1887 per l'editore Guigoni
di Milano il romanzo La favorita del Mahdi, primo
libro salgariano. Nello stesso anno, Il Telefono di Livorno
pubblicò Gli strangolatori del Gange (poi conosciuto
come I misteri della jungla nera) dove compaiono per
la prima volta Tremal-Naik, Kammamuri, Ada,
i thugs, anticipatori di Sandokan e Yanez.
L’anno seguente la Guigoni pubblicò Duemila leghe sotto
l’America, con la chiara influenza di Jules Verne. Le
appendici del quotidiano La Gazzetta di Treviso, tra il 1890
e il 1891, pubblicarono la versione rivisitata della
Tigre della Malesia, mentre quella definitiva apparve in
un unico volume nel 1900 con il titolo Le tigri di
Mompracem pcon l’editore Antonio Donath di Genova. Nel
1891 Il Giornale dei Fanciulli della casa editrice
Treves pubblicò La scimitarra di Budda, rivolto a un
pubblico giovanile. Fu solo l'inizio di una produzione
letteraria intensissima.
Intanto nel
novembre del 1889 il padre Luigi, convinto di essere affetto
da una malattia incurabile, si uccise lasciandosi cadere
dalla finestra della casa del cognato, di cui era ospite. Fu
il primo di una impressionante catena di suicidi formata
dallo stesso scrittore nel 1911, dal figlio Romero nel 1931
a 33 anni, dal figlio Omar, testimone e interprete della
leggenda paterna, nel 1963.
Nel 1892 si
sposa con una attrice di una compagnia amatoriale Ida
Peruzzi (che il marito chiamerà affettuosamente per
tutta la vita "Aida", come l'eroina di Verdi): un
matrimonio, questo, a suo modo riuscito (ma la moglie morirà
internata in manicomio); nello stesso anno la famiglia
Salgari, si era ampliatasi con la nascita della piccola
Fatima (la primogenita, seguiranno poi tre maschietti: Nadir
nel 1894, Romero nel 1898 e Omar nel 1900). Conclusa
l'attività giornalistica all’Arena, alla fine del 1893,
Salgari quando si trasferì a Torino per collaborare con gli
editori Speirani e Paravia senza vincoli contrattuali,
iniziando a scrivere anche per altri editori nazionali:
Bemporad, Cogliati, Treves, Voghera.
Dal 1898, per
circa due anni visse a Genova al seguito dell'editore
Antonio Donath, stabilendosi a Sampierdarena. In questo
periodo fiorirono altre leggende su Salgari, che lo vogliono
frequentatore di taverne del porto ad ascoltare le storie di
vecchi marinai. Per Donath scrisse alcune delle sue opere
migliori: I misteri della jungla nera, I Robinson
italiani, Il Corsaro Nero, Gli orrori della
Siberia, I figli dell’aria, L’uomo di fuoco,
Le due tigri, Capitan Tempesta, Cartagine
in fiamme, e altri. L'editore Donath fu coluni che diede
forma al libro salgariano che tutti oggi conosciamo con le
copertine sgargianti realizzate da importanti illustratori
come Alberto Della Valle, Gennaro Amato e
altri. Questo tipo di impostazione grafica, caratterizzerò
il libro d’avventura italiano fino agli anni Settanta del
Novecento.
Dopo i due anni
di Genova Salgari si trasferisce a
Torino allo scoccare del nuovo secolo. Nel capoluogo
piemontese lavorerà per l'editore Speirani, casa
editrice per ragazzi. Sono anni in cui, nonostante la grande
mole di lavoro e di pubblicazioni, le condizioni della
famiglia, per mantenere un rispettabile decoro borghese, si fanno
via via sempre più precarie; rompe il
contratto con Donath e passa a Bemporad (per cui, dal 1907
al 1911 scrive 19 romanzi). Il successo, specialmente tra i
ragazzi, continua, diversi titoli raggiungono le 100.000
copie, ma la critica ignorerà sempre la sua produzione. Il collasso nervoso e il ricovero della moglie
sono il colpo di grazia per un uomo stremato. Scrive tre
lettere, ai figli, agli editori, ai direttori dei giornali
torinesi e si toglie la vita il 25 aprile 1911.

La
fantasia si scontra con la dura realtà
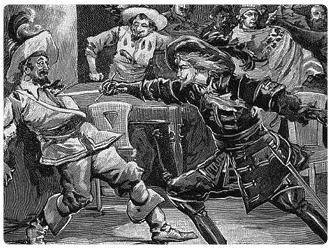 Emilio
Salgari, è stato per lungo tempo uno tra gli autori più letti
nel mondo; la sua opera ha un valore di indubbio documento nella
storia della cultura italiana; i suoi personaggi, continuano
ancora adesso a entusiasmare giovani e meno giovani lettori
di varie generazioni: se li hai letti da ragazzo (o da adulto)
non li dimenticherai mai... Sandokan, il Corsaro
Nero, il Leone di Damasco. Emilio Salgari fu, malgrado
i suoi limiti, uno scrittore assai più ricco in scrittura di
quanto non ammettesse l'opinione comune di allora. Può darsi,
è vero, che i suoi racconti siano come un bazar dove si affastellano
confusamente troppe suggestioni della letteratura e della moda;
certo riecheggiano, con uno straordinario eclettismo ed una
sensibilità approssimativa ma autentica, quasi tutti i temi
della cultura europea nella seconda metà dell'Ottocento, ma
che passione leggerli! In questi romanzi per ragazzi si trova
un po' di tutto, anche motivi meno adatti all'adolescenza: l'esasperazione
del tardo romanticismo e le fantasticherie della scapigliatura,
i furori del "romanzo nero" ed il titanismo alla
Nietzsche,
le suggestioni del melodramma (magari adattate al teatro dei
pupi) e, naturalmente, la voga dell'esotismo... Emilio
Salgari, è stato per lungo tempo uno tra gli autori più letti
nel mondo; la sua opera ha un valore di indubbio documento nella
storia della cultura italiana; i suoi personaggi, continuano
ancora adesso a entusiasmare giovani e meno giovani lettori
di varie generazioni: se li hai letti da ragazzo (o da adulto)
non li dimenticherai mai... Sandokan, il Corsaro
Nero, il Leone di Damasco. Emilio Salgari fu, malgrado
i suoi limiti, uno scrittore assai più ricco in scrittura di
quanto non ammettesse l'opinione comune di allora. Può darsi,
è vero, che i suoi racconti siano come un bazar dove si affastellano
confusamente troppe suggestioni della letteratura e della moda;
certo riecheggiano, con uno straordinario eclettismo ed una
sensibilità approssimativa ma autentica, quasi tutti i temi
della cultura europea nella seconda metà dell'Ottocento, ma
che passione leggerli! In questi romanzi per ragazzi si trova
un po' di tutto, anche motivi meno adatti all'adolescenza: l'esasperazione
del tardo romanticismo e le fantasticherie della scapigliatura,
i furori del "romanzo nero" ed il titanismo alla
Nietzsche,
le suggestioni del melodramma (magari adattate al teatro dei
pupi) e, naturalmente, la voga dell'esotismo...
 Il
periodo in cui scrisse fu molto importante: i suoi cento racconti
uscirono tra il 1880 ed il 1910; fu contemporaneo, e si sente,
di scrittori come Kipling e Conrad, di Cecil
Rhodes e di Pierre Loti, delle glorie imperiali vittoriane
e del Liberty, o
Art Nouveau
che dir si voglia, della guerra boera e della marcia europea
sulla Pechino in mano ai boxers. E fu, per quanto sembri paradossale,
un dannunziano: povero d'arte, modesto, "borghese", ma genuino
tanto nelle fantasticherie che negli errori di gusto. Il
periodo in cui scrisse fu molto importante: i suoi cento racconti
uscirono tra il 1880 ed il 1910; fu contemporaneo, e si sente,
di scrittori come Kipling e Conrad, di Cecil
Rhodes e di Pierre Loti, delle glorie imperiali vittoriane
e del Liberty, o
Art Nouveau
che dir si voglia, della guerra boera e della marcia europea
sulla Pechino in mano ai boxers. E fu, per quanto sembri paradossale,
un dannunziano: povero d'arte, modesto, "borghese", ma genuino
tanto nelle fantasticherie che negli errori di gusto.
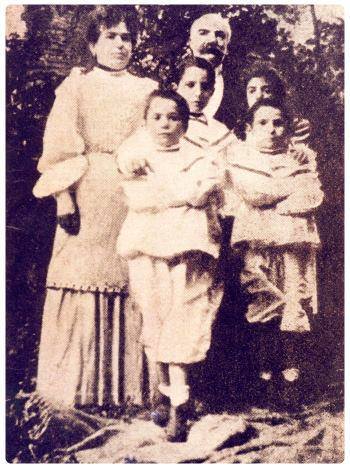 Sarebbe
un errore spiegare i candidissimi amori degli eroi salgariani
con le esigenze dei libri per ragazzi; una schietta ingenuità
romantica, che si ritrova anche nella sua esistenza, induce
lo scrittore a far piangere e delirare Sandokan, Tremai Naik,
il Leone di Damasco per amori frenetici ma innocenti: tutti
i suoi superuomini rifiuterebbero la felicità fuori del matrimonio.
L'esotismo sembra la passione dominante in Emilio Salgari; che
è figlio anche in questo del suo tempo, ma con una carica più
forte di fuga dalla realtà, con un disperato bisogno di rivalsa. Sarebbe
un errore spiegare i candidissimi amori degli eroi salgariani
con le esigenze dei libri per ragazzi; una schietta ingenuità
romantica, che si ritrova anche nella sua esistenza, induce
lo scrittore a far piangere e delirare Sandokan, Tremai Naik,
il Leone di Damasco per amori frenetici ma innocenti: tutti
i suoi superuomini rifiuterebbero la felicità fuori del matrimonio.
L'esotismo sembra la passione dominante in Emilio Salgari; che
è figlio anche in questo del suo tempo, ma con una carica più
forte di fuga dalla realtà, con un disperato bisogno di rivalsa.
Sognava di vivere
tra viaggi mirabili, avventure favolose, splendori da Mille
e una notte; ma forse per mare non andò oltre
Brindisi.
Condusse una grigia esistenza da piccolo borghese sedentario,
fu sempre costretto a lottare contro le difficoltà
economiche, data anche dal fatto che non si sapeva
amministrare a dovere. Scrivere era
la sua evasione: perciò nessuna terra poteva appagarlo meglio
dell'Oriente. Non a caso i suoi romanzi migliori furono ambientati
fra India e Malesia, o in una Cina di maniera rutilante di gemme,
oppure ancora tra isole dei Caraibi che assumono colori orientali,
o nel Levante. Salgari si documentava, frequentava le
biblioteche, era curioso, onnivoro. Quando scriveva un
libro, prima preparava informazioni su ambiente, flora,
fauna, e poi disegna una carta geografica con il percorso
dei personaggi (esistono ancora alcuni suoi schizzi).
 Ma
per un aspetto, importante, almeno Salgari si distacca dalla
cultura prevalente nel suo tempo: scriveva nell'età del trionfante
imperialismo europeo, delle grandi spedizioni africane, della
battaglia di Adua, ma era anticolonialista. Contemporaneo di
Kipling, non credeva nel "fardello dell'uomo bianco",
anzi denunciò la politica imposta dai bianchi ai popoli di colore;
inventò romanzi per guadagnare, ed ebbe il coraggio di muoversi
contro corrente. "Parteggiava" per gli indiani e per
i malesi contro i britannici; si sentiva solidale con gli indigeni
anche mentre infuriava la sanguinosa rivolta del Mahdi in Sudan;
si avverte che giudicava severamente l'oppressivo colonialismo
spagnolo. Ma
per un aspetto, importante, almeno Salgari si distacca dalla
cultura prevalente nel suo tempo: scriveva nell'età del trionfante
imperialismo europeo, delle grandi spedizioni africane, della
battaglia di Adua, ma era anticolonialista. Contemporaneo di
Kipling, non credeva nel "fardello dell'uomo bianco",
anzi denunciò la politica imposta dai bianchi ai popoli di colore;
inventò romanzi per guadagnare, ed ebbe il coraggio di muoversi
contro corrente. "Parteggiava" per gli indiani e per
i malesi contro i britannici; si sentiva solidale con gli indigeni
anche mentre infuriava la sanguinosa rivolta del Mahdi in Sudan;
si avverte che giudicava severamente l'oppressivo colonialismo
spagnolo.
Qualche critico
superficiale e di poche letture ha voluto fare di Salgari, per
il suo gusto dell'avventura, un ispiratore dell'interventismo
italiano nel 1915 nella Prima Guerra Mondiale, un precursore
del fascismo: nulla di più lontano dalla verità. Lo scrittore
torinese di adozione, rifiuta il nazionalismo, le guerre di
conquista, l'oppressione, ed ignora i temi della retorica patriottarda
fino a sostenere i cartaginesi contro i romani.
I suoi eroi sono
vendicatori di ingiustizie o ribelli contro la tirannide; talvolta
smaniosi e feroci, eppure con un senso profondo dell'equità.
Emilio Salgari era della stessa pasta. Anglofobo perché, secondo
la lezione storica del suo tempo, identificava Inghilterra ed
imperialismo; ma, diversamente da certi anticolonialisti contemporanei,
non rovescia sull'Europa tutti i delitti e tutte le colpe. Sandokan
e Tremai Naik, muovendosi alla caccia di Suyodhana nell'India
straziata dalla rivolta dei cipays del 1857, riconoscono che
in tutti e due i campi si commettono atrocità: come essere meno
faziosi?
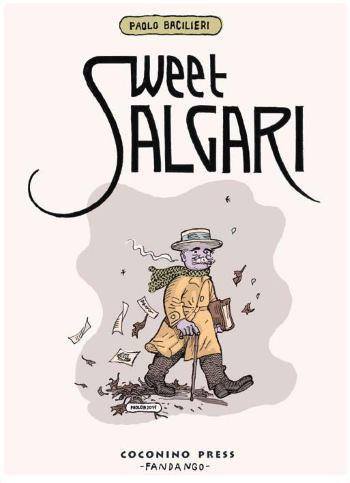 Da
poco, nella splendida cornice di
Lucca,
in occasione di Lucca Comics and Games, una delle principali
manifestazioni del fumetto e del libro di avventura in Italia,
è stato ancora una volta ricordato Salgari (leggete se ne avete
la possibilità l'ottimo Sweet Salgari di Paolo Bacilieri). A
distanza di più di un secolo dalla sua morte, viene ancora letto
da centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il mondo, che poi
si portano dietro i ricordi, magari frastagliati, che vengono
fuori in molti momenti successivi della vita, di terre esotiche,
fantastiche, ma possibili (la possibilità è tutto), simbolo
della speranza di ogni uomo di sognare di vivere, almeno per
un po', nell'avventura per dare un senso alla vita. Da
poco, nella splendida cornice di
Lucca,
in occasione di Lucca Comics and Games, una delle principali
manifestazioni del fumetto e del libro di avventura in Italia,
è stato ancora una volta ricordato Salgari (leggete se ne avete
la possibilità l'ottimo Sweet Salgari di Paolo Bacilieri). A
distanza di più di un secolo dalla sua morte, viene ancora letto
da centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il mondo, che poi
si portano dietro i ricordi, magari frastagliati, che vengono
fuori in molti momenti successivi della vita, di terre esotiche,
fantastiche, ma possibili (la possibilità è tutto), simbolo
della speranza di ogni uomo di sognare di vivere, almeno per
un po', nell'avventura per dare un senso alla vita.
Ogni "salgariano",
è naturale, ha i suoi eroi. Ci sono molti rami secchi, nell'opera
sterminata ed eclettica di Salgari. In pochi ricordano i racconti
polari o i romanzi di fantascienza, come Le meraviglie del
Duemila. Emilio Salgari era un cattivo imitatore di Jules
Verne; non "sentiva sue" le macchine, gli piacevano soltanto
i personaggi che si battono uomo contro uomo, all'arma bianca,
come i cavalieri antichi. Ma c'è chi su ogni altro "ciclo",
predilige quello del West, con re della prateria e La scotennatrice;
chi gusta i romanzi africani e ripensa volentieri alla Favorita
del Mahdi; chi dà la palma alle storie dei filibustieri,
e chi vorrebbe tornare ragazzo per rileggere con il gusto d'allora
la serie più vasta e fortunata: quella "della giungla". La maggioranza
dei lettori, vedono il miglior Salgari nelle avventure del Corsaro
Nero e nei racconti ambientati in un favoloso Oriente. Qui,
infatti, appare l'ispirazione vera dello scrittore: la fuga
dalla realtà verso un mondo cavalleresco ed esotico. Emilio
Salgari non scriveva soltanto per guadagnare; scriveva per vivere,
attraverso i suoi personaggi, le avventure mancate nella sua
grigia esistenza di piccolo borghese.
La fuga nella fantasia
non era un vezzo, la realtà di Salgari per tanti anni è stata
durissima da sopportare: il padre di Emilio, Luigi Salgari,
credendosi malato di una malattia incurabile si suicida nel
1889, due anni dopo la morte della madre Luigia Gradara;
le cure per la moglie Ida Peruzzi, che a partire dal
1903 inizia a dare segni di squilibrio mentale, fanno moltiplicare
i debiti che lo scrittore è costretto a contrarre; nella primavera
del 1911, quando Emilio si toglierà la vita sulle colline che
sovrastano Torino, la famiglia Salgari era in ulteriori difficoltà
economiche per le spese necessarie a curare la figlia Fatima
malata di tisi.
Nei suoi 27 anni
di frenetica attività Salgari si legò con contratti capestro
a una miriade di editori (Donath, Vogher,
Paravia, Speirani, Bietti, Bemporad),
che lo che lo pressarono con richieste continue di romanzi,
sino a tre all'anno, a gruppi di trenta cartelle per volta.
Per mantenere questi ritmi lo scrittore era costretto a scrivere
in media tre pagine al giorno, sabato e domenica comprese. Se
una domenica voleva riposare, o se un giorno era preso dalla
febbre, all'indomani le pagine da scrivere dovevano essere sei.
Un ritmo difficile da sostenere, condito dal fumo di 100 sigarette
al giorno sorseggiando del marsala.
Sullo scrittoio
dove distrusse la sua schiena e le sue forze, teneva —
accanto alla penna da pochi soldi, rotta e legata con uno
spago perché doveva lesinare il centesimo — un pugnale
arabo. Ma per le sue avventure nella giungla, si
accontentava di fantasticarle fra i domestici boschetti ed i
cespugli della collina torinese, dove portava a spasso
i figli, e dove, tragicamente si recò a morire. E dopo
essersi certamente identificato, in quelle fantasticherie,
con i suoi cento eroi vittoriosi, dovette confessarsi
battuto dalla squallida miseria. A Torino in quei giorni
andava in scena l'Esposizione Universale.
Il 13 aprile del
1911 un grande amico di Salgari, Augusto Franzoj, si
era tolto la vita nella vicina San Mauro Torinese. I due si
erano conosciuti nel febbraio del 1885, quando Salgari era
un giovane redattore del quotidiano La Nuova Arena.
Franzoj, mazziniano e patriota italiano, aveva partecipato
come volontario alla Terza Guerra di Indipendenza, ed era un
vero esploratore, specie nel Ghera e nel Sidama, vivendo
avventure come Salgari aveva solo immaginato, ed era per lui
probabilmente un modello. Forse fu proprio a quel punto, che
lo scrittore pensò di porre fine alla sua vita, cosa che
accadde 12 giorni dopo.
Ai suoi figli
lasciò scritto, secondo il quotidiano la Stampa in quei
giorni del 1911: "Miei cari figli, sono ormai un vinto. La
pazzia di vostra madre mi ha spezzato il cuore e tutte le
energie. Io spero che i milioni di miei ammiratori, che per
tanti anni ho divertito cd istruito, provvederanno a voi.
Non vi lascio che 150 lire, più un credito di seicento lire
che incasserete dalla signora Nusshaumer. Vi accludo qui il
suo indirizzo. Fatemi seppellire per carità essendo
completamente rovinato. Mantenetevi buoni ed onesti c
pensate. appena potrete. ad aiutare vostra madre. Vi bacia
tutti col cuore sanguinante il vostro disgraziato padre.
P.S. Vado a morire nella valle di San Martino, presso il
luogo ove, quando abitavamo in via Guastalla andavamo a fare
colazione. Si troverà il mio cadavere in uno di quei
burroncelli che voi conoscete perché lì andavate a
raccogliere fiori..
In un'altra
missiva scriverà: "Prego di non incolpare nessuno della
mia morte. Mi uccido spontaneamente perchè nella più
squallida miseria. Ho scritto ottanta volumi che hanno
arricchito i miei editori!... La povera mia moglie si trova
al manicomio, non so se furiosa o mentecatta..."
 Emilio
Salgari si toglie la vita il 25 aprile 1911. Verso le ore 18
una certa Luigia Quirico, che si era recata a far legna nel
bosco proprietà Rey presso la strada del Lauro a Madonna del
Pilone, scorse tra l'erba il corpo dello scrittore. Prima di eseguire
un "hara-kiri", alla maniera giapponese, come
scrissero i giornali, accoltellandosi al ventre, Salgari
scrisse una lettera
ai figli ed una sarcastica missiva agli editori.
"A voi che vi siete
arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia
in una continua semi-miseria od anche di più, chiedo solo che
per compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali.
Vi saluto spezzando la penna."
Ai funerali nessuna autorità, né personaggi illustri, ma
una folla di giovani, studenti, operai. artigiani.
Nel febbraio dell'anno dopo la salma dello scrittore venne
trasferita nella tomba di famiglia a Verona. Una violenta
pioggia non impedì al cimitero il discorso dell'allora
sindaco di Verona Gallizioli, dopo che il feretro era
passato, come raccontò un cronista, "tra imponenti siepi
umane". Emilio
Salgari si toglie la vita il 25 aprile 1911. Verso le ore 18
una certa Luigia Quirico, che si era recata a far legna nel
bosco proprietà Rey presso la strada del Lauro a Madonna del
Pilone, scorse tra l'erba il corpo dello scrittore. Prima di eseguire
un "hara-kiri", alla maniera giapponese, come
scrissero i giornali, accoltellandosi al ventre, Salgari
scrisse una lettera
ai figli ed una sarcastica missiva agli editori.
"A voi che vi siete
arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia
in una continua semi-miseria od anche di più, chiedo solo che
per compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali.
Vi saluto spezzando la penna."
Ai funerali nessuna autorità, né personaggi illustri, ma
una folla di giovani, studenti, operai. artigiani.
Nel febbraio dell'anno dopo la salma dello scrittore venne
trasferita nella tomba di famiglia a Verona. Una violenta
pioggia non impedì al cimitero il discorso dell'allora
sindaco di Verona Gallizioli, dopo che il feretro era
passato, come raccontò un cronista, "tra imponenti siepi
umane".
Salgari aveva
già tentato il suicidio un anno prima della sua morte, ma in quell'occasione
era stato fermato per tempo. Il 30 settembre 1922, Ida Peruzzi
esce dal manicomio di Collegno, con la sua cartella clinica
che indica semplicemente la dicitura ''migliorata''. Il giorno
dopo muore. Tragiche fini perseguiteranno anche negli anni a
venire la famiglia Salgari: nel 1931 si suicida il figlio Romero;
nel 1963 si suicida Omar, il figlio più piccolo di Salgari,
buttandosi dal secondo piano del suo alloggio.
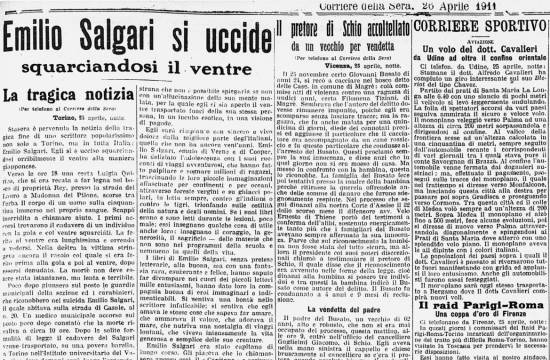 Anni dopo la
morte di Salgari si formarono delle associazioni che
spingevano per compensare i figli dello scrittore dai "torti
economici fatti al padre dagli editori". Vennero anche
fatte delle interrogazioni parlamentari in merito al
ministro della pubblica istruzione di allora Fedele. Venne
creato un fondo di ripartizione dei diritti di autore e una
delle associazioni pro Salgari, chiamata "Raduno", indirizzò
una lettera al ministero: Anni dopo la
morte di Salgari si formarono delle associazioni che
spingevano per compensare i figli dello scrittore dai "torti
economici fatti al padre dagli editori". Vennero anche
fatte delle interrogazioni parlamentari in merito al
ministro della pubblica istruzione di allora Fedele. Venne
creato un fondo di ripartizione dei diritti di autore e una
delle associazioni pro Salgari, chiamata "Raduno", indirizzò
una lettera al ministero:
"Alla Commissione la quale dovrà provvedere a ripartire il
fondo di un milione proveniente dai diritti di autore, - e
desidero sia senza indugio nominata, - propongo che ai figli
di Emilio Salgari, defraudato dei diritto d'autore, sia
concesso un efficace sussidio. Non bisogna dimenticare che
Emilio Salgari, il quale arrochì con suoi libri gli editori
e fu dalla miseria spinto al suicidio, ebbe la grande
benemerenza di avere educato la giovane generazione che
dette il sangue per la Patria."
Era il 1928. Alla lettera rispose l'allora giovane e
eterodosso sottosegretario fascista Giuseppe Bottai
"Carissimi amici: Voi avete intrapreso nel nome di Emilio
Salgari una battaglia che deve essere condotta sino alla
vittoria. Si tratta di rimettere ordine e chiarezza in un
mondo di rapporti economici che è non meno, se non di più
importante di quello in cui ormai il nuovo diritto è entrato
in pieno. L'impresa non è facile: auguriamoci che la
risoluzione del "caso Salgari" le dia il buon avvio. Vi
saluto affettuosamente."
Il 20 gennaio del 1928 l'editore Enrico Bemporand
con il quale Salgari pubblicò la maggior parte delle sue
opere fece pervenire una lettera al Corriere della Sera,
dove negava che lo scrittore non fosse stato pagato
adeguatamente, producendo una lettera inedita indirizzata
alla moglie di Salgari e negava anche la diceria che lo
scrittore veronese fosse pressato per la consegna dei suoi
manoscritti.
"Riceviamo dall'editore Enrico Bemporad di Firenze la copia
di una lettera che il Bemporad aveva, indirizzato alla
signora Salgari quando lo scrittore era ancora in vita. La
lettera diceva:
"Si
tranquillizzi dunque, io ho dovere e il desiderio di usare
sempre a suo marito la massima deferenza: e voglio che stia
bene in salute si riposi quando se ne sente il bisogno. Con
la suddetta frase ho voluto significare questo: Se anche
qualche mese non manderà il manoscritto, io gli manderò
egualmente il denaro"
Il comm. Bemporad rileva che tali parole "oneste e buone",
scritte da persona a persona e non destinate alla pubblicità
dimostrano la correttezza e la premura dell'editore verso
l'autore: ed osserva che il Salgari riceveva dalla sua
ditta, a norma di contratto, diecimila lire annue. Che per
quei tempi rappresentavo una notevole entrata: quindi è
assurdo attribuire a difficoltà economiche, derivanti dai
rapporti con la sua ditta, la sua volontaria tragica
fine.
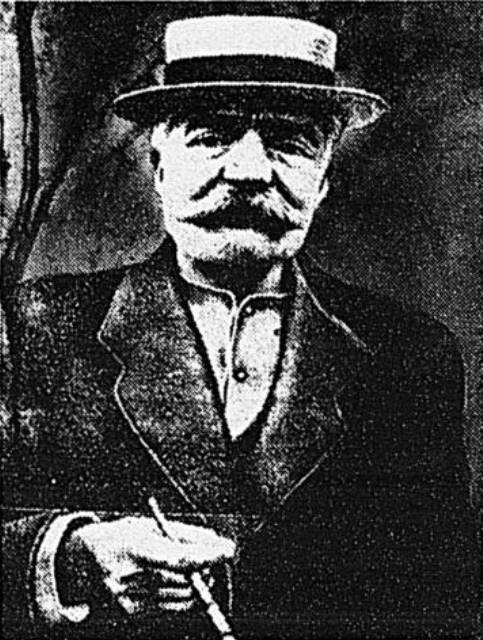 Quello
che è certo è che se tra le qualità umane del poeta resta
quella di saper dimenticare la meschina realtà nelle proprie
visioni interiori, così fu anche per Salgari, che nei suoi
romanzi non lasciò filtrare un solo particolare
dell'angusto, disperato, doloroso mondo in cui viveva;
trecentocinquanta lire, per esempio per tutti i diritti
presenti e futuri su
Un dramma nell'Oceano Pacifico. Fu uno dei suoi
primi contratti. Ma prese anche meno coi romanzi successivi,
che dovevano andare in giro per il mondo in milioni di copie
e tradotti in decine di lingue. Nonostante tutte le sue
peripezie interiori e la miseria, Salgari riuscì in ogni
caso a fare sognare una moltitudine di persone dalla sua
stanzetta, chino sulle pagine che andava componendo riga
dopo riga e, immagino, alzando ogni tanto lo sguardo a
qualcosa che vedeva solo lui, Mompracem, la jungla, il
deserto, il selvaggio West o la misteriosa Australia. Quello
che è certo è che se tra le qualità umane del poeta resta
quella di saper dimenticare la meschina realtà nelle proprie
visioni interiori, così fu anche per Salgari, che nei suoi
romanzi non lasciò filtrare un solo particolare
dell'angusto, disperato, doloroso mondo in cui viveva;
trecentocinquanta lire, per esempio per tutti i diritti
presenti e futuri su
Un dramma nell'Oceano Pacifico. Fu uno dei suoi
primi contratti. Ma prese anche meno coi romanzi successivi,
che dovevano andare in giro per il mondo in milioni di copie
e tradotti in decine di lingue. Nonostante tutte le sue
peripezie interiori e la miseria, Salgari riuscì in ogni
caso a fare sognare una moltitudine di persone dalla sua
stanzetta, chino sulle pagine che andava componendo riga
dopo riga e, immagino, alzando ogni tanto lo sguardo a
qualcosa che vedeva solo lui, Mompracem, la jungla, il
deserto, il selvaggio West o la misteriosa Australia.
A parziale
consolazione di tutti si può concludere che qualche
giustizia fu fatta dopo la sua morte, quando gli editori,
nel 1928, timorosi di vedersi espropriati, come toccò a
coloro che avevano sfruttato
Flaubert, rivendettero, sia
pure a un prezzo dieci volte superiore, agli eredi i diritti
sulle opere salgariane.
Ma era vero che
Salgari era sfruttato dagli editori?
Nel 2011, in occasione del centenario della morte dello
scrittore veronese è uscito un interessante libro dal titolo
Emilio Salgari. La macchina dei sogni di Claudio
Gallo e Giuseppe Bonomi. Gallo, è un veronese, che al suo
concittadino ha dedicato tanti anni di ricerca. È molto
interessante il fatto che secondo lui Salgari era il
contrario di quello oggi spesso si legge. Non era uno
sprovveduto che lavorava su un tavolino traballante col
pennino spuntato. Vendeva molto, era stimato dai lettori,
era consapevole del suo progetto: scrivere in Italia libri
di genere appassionanti come quelli di Jules Verne e Dumas
in Francia. Anche per questo Salgari figlio della
Scapigliatura, il gruppo artistico e letterario sviluppatosi
nell'Italia settentrionale a partire dagli anni sessanta
dell'Ottocento che erano animati da uno spirito di
ribellione nei confronti della cultura tradizionale e il
buonsenso borghese. Gli scapigliati, sempre secondo Gallo,
non erano solo quelli che avevano i capelli lunghi e
bevevano troppo, ma furano coloro che avevano introdotto in
Italia
Edgar Allan Poe, l'inventore dei generi
moderni. E hanno reso una libertà di scrittura extra
tradizione. Salgari ha scritto anche un romanzo scapigliato,
La Bohème italiana.
Figlio del suo tempo, Salgari era anche un positivista, che
aveva fiducia nel progresso e nella ragione. Come mostra ne
I Robinson italiani, dove basta la conoscenza per
sopravvivere in un ambiente ostile e ricreare il mondo
civile. Gallo afferma che in realtà Salgari non era di
famiglia povera, e gli editori se lo contendevano. Aveva
anche un agente per il mercato estero. I suoi compensi erano
doppi rispetto a scrittori famosi come
Luigi Capuana. L'unico problema? Non era un bravo
amministratore. Salgari guadagnava dai suoi romanzi (anche
usando gli pseudonimo di Altieri o Bertolucci) circa 1000
lire al mese, una cifra ragguardevole per allora. Per fare
un esempio uno scrittore come Giosuè Carducci,
cedette le sue poesie a Zanichelli per cinquemila lire. Ma
questi conti da ragioniere non entravano e non potevano
entrare nella mentalità di un uomo che si identificava con
uno dei suoi più cari personaggi, Yanez: il portoghese dalle
mille astuzie e dall'"ennesima sigaretta", il fratellino
bianco di Sandokan, era lui, Salgari. Una notte in cui era
in preda alla febbre, la moglie lo udì mormorare: "Yanez
sta male! Yanez sta male!"
Indizi sull'influenza
di Salgari
Salgari e la difesa delle cause dei
popoli oppressi
Emilio Salgari, padre di "Eroi e Avventure esotiche", è soprattutto
lo scrittore delle lotte dei popoli oppressi contro la violenza
del colonialismo, contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo
e contro le vessazioni dei popoli più avanzati contro popolazioni
considerate sottosviluppate. Salgari va letto soprattutto
per il suo amore per la libertà e la sua appassionata critica
anticolonialista e antimperialista.
Nei romanzi salgariani troviamo eroi indigeni che combattono
per la libertà del loro popolo, pirati e corsari di nobili origini,
che diventano carnefici, dopo aver perso le loro famiglie sotto
i colpi spietati dei pugnali al soldo delle potenze imperiali
(Inghilterra nel caso del pirata malese Sandokan, Spagna nel
caso del corsaro italiano Emilio di Ventimiglia), persone che
hanno combattuto per la loro indipendenza, avventurieri pronti
a sacrificare la loro vita per rimanere fedeli a un ideale di
vita eroica.
La difesa appassionata dei popoli che hanno combattuto contro
l'oppressione coloniale si trova in particolare in Le Stragi
delle Filippine, La Costa d'Avorio, La Capitana
del Yucatan, Gli Orrori della Siberia, Le Aquile
della Steppa, La Scotennatrice e Le selve ardenti.
In Salgari non c'è una rappresentazione edificante del
mondo coloniale così come si trova in tante pagine di Rudyard
Kipling (che fu lo scrittore che celebrò i fasti dell'impero
coloniale britannico).
Dai romanzi di Salgari
si impara ad amare la libertà, a difendere le cause dei popoli
oppressi, a guadagnare la fiducia nella forza dell'uomo e nella
tenacia dei ribelli che combattono contro gli abusi dell'oppressione
imperialista e la violenza dei tiranni. Ecco perché la narrazione
di Emilio Salgari è così importante e perché la sua opera non
può essere ridotta alla letteratura giovanile.
Salgari nel contesto
letterario, culturale e artistico italiano
Salgari è da cent'anni una parte importante dell'immaginario
italiano. Fino agli anni Settanta tutti i bambini giocavano
a Sandokan e ai pirati malesi, leggevano le avventure di Yanez
e Kammamuri, sognavano la "Perla di Labuan". Vera e propria
figura centrale nel panorama letterario, culturale e artistico
del nostro paese, Emilio Salgari è entrato nell'immaginario
collettivo dei lettori non solo per le sue opere rivolte a un
vasto pubblico, ma soprattutto per la sua passione per l'avventura.
Non furono un caso le numerosissime trasposizioni su altri media:
opere teatrali, film e fumetti.
Nelle trame salgariane il lettore si identifica facilmente con
gli eroi, attraverso una sorta di immedesimazione con la figura
del protagonista, arrivando a vivere le avventure che la vita
quotidiana gli impedisce di vivere. Federico Fellini
fu uno dei tanti artisti che amavano i libri di Salgari. Il
compositore Pietro Mascagni aveva nella sua biblioteca
oltre 50 titoli di Salgari.
Umberto Eco "divorò" le opere di Salgari da bambino.
Salgari è stato l'autore più letto nei Paesi del Nord e del
Sud America che hanno accolto gli emigranti italiani.
Salgari e il Sud America
Argentina
Anche i bambini del Sud America sono cresciuti con i suoi libri.
Tutte le biografie di Che Guevara ricordano che tra i
suoi autori preferiti c'era Salgari, di cui lesse sessantadue
romanzi. Ernesto "Che" Guevara, uno dei rivoluzionari più famosi
della storia fin da bambino era un lettore vorace. Il fratello
Roberto lo ricordava chiuso nel bagno perché nessuno lo interrompesse
mentre si dedicava al suo passatempo preferito, la lettura.
Come per molti bambini dell'epoca, i libri preferiti dal
Che erano le avventure di Emilio Salgari e di
Jules Verne.
A dieci anni scriveva a sua zia Beatriz Guevara: "Quando
passi per via Santa Fe, scopri se hanno I misteri dell'India
di Emilio Salgari".
Cile
Luis Sepulveda ha raccontato che suo nonno, un anarchico
spagnolo emigrato in Cile, aveva organizzato il primo circolo
di lettura delle opere di Salgari nella sua nuova patria. Nella
casa di Allende, la scrittrice Isabel Allende, raccontò
come i libri di Salgari erano stati tramandati come reliquie
da padre in figlio, compreso Salvador Allende, il presidente
del Cile dal 1970 al 1973, deposto e, probabilmente, ucciso
in seguito al Colpo di Stato del generale Pinochet.
Anche Manuel Rojas (Premio Nazionale per la Letteratura
Cilena 1957) era un appassionato lettore di Salgari. Il primo
libro che gli sfece scoccare la scintilla per lo scrittore veronese
fu "scoperto" nella vetrina di una libreria mentre andava a
scuola. Si chiamava "Devastazioni dei Pirati", ma non
sapeva chi fosse l'autore. Costava venti centesimi e dovette
raccogliere due centesimi al giorno per porterlo acquistare.
Quando l'aprì in strada si rese conto che era la seconda parte
di un romanzo intitolato Los náufragos del Liguria di
Emilio Salgari (I Robinson italiani, 1896): "Ho letto
il libro e ho cominciato a raccogliere soldi per comprare il
primo volume. E con questo sono andato sull'albero, dove continuo."
Fu una mera coincidenza che Rojas fosse stato attirato da una
copertina con l'immagine di un selvaggio mezzo nudo catturato
da uomini bianchi? Non credo. Fino a quel momento, la vita non
era stata facile per lui, anzi piuttosto avventurosa, salgariana;
una esistenza fatta di povertà, straccioni, uomini solitari
e persino pazzi, operai che dal mattino presto alla sera faticavano
per mettere in bocca un pasto. L'avventura, lo sradicamento,
lo hanno accompagnato fino alla fine della sua vita, quando
si è innamorato di un donna quarant'anni più giovane di lui,
ha perso molti amici e ha dovuto iniziare una nuova vita all'età
di settant'anni.
Manuel Rojas, ha scritto: "Ogni appassionato di letteratura
forma negli anni una vera e propria mitologia degli autori che,
in un modo o nell'altro, incorpora nella propria formazione".
Rojas elencò i suoi autori: "Tutto è iniziato con Salgari,
seguito da Victor Hugo. Mi sono piaciuti Vargas Vila e Zamacóis.
Più tardi gli scrittori che mi hanno colpito di più non sono
cambiati. Dostoevskij, Tolstoj, Cechov, Faulkner, Melville,
Lawrence, Hudson..."
Argentina
La nazione latinoamericana dove Emilio Salgari conobbe la sua
maggiore popolarità (pari e forse superiore a quella che lo
accompagnava in Italia) e dove lasciò una profonda impronta
è l'Argentina. Questo è forse comprensibile visto che ancora
oggi, il 70% degli argentini sono di origine italiana, ma fu
più di questo. Nel paese sudamericano "Salgari" era anche un
settimanale a fumetti (settimanale della casa editrice Abril)
con immagini disegnate in Italia da importanti disegnatori quali
Albertarelli, Molino, Papparella, Ferrari
e altri. L'obiettivo della rivista era quello di tradurre in
immagini i romanzi salgariani (una vera e propria funzione di
mediazione tra letteratura e fumetto).
Una moltitudine di bambini argentini lesse avidamente quelle
pagine che oggi sono prezioso materiale da collezione, ed è
molto probabile che tra loro ci fossero futuri grandi nomi del
fumetto argentino, come Héctor Germán Oesterheld, creatore
di El Eternauta, Mort Cinder, Ticonderoga,
Sherlock Time, nei cui brillanti copioni ci sono evidenti
tracce di Salgari.
Lo scrittore argentino
Rolo Diez dice di aver trovato nella saga salgariana
dei corsari una lezione di ribellione contro la dittatura. Salgari
ha ispirato anche altri scrittori latinoamericani, da Jorge
Luis Borges a Carlos Fuentes. Quest'ultimo dice che
non ci sarebbe letteratura latinoamericana senza Salgari.
Pablo Neruda, poeta, ma anche importante voce politica,
era un altro appassionato salgariano. Tony Guiteras,
uno dei leader della prima rivoluzione cubana, fu ispirato dalle
avventure di Salgari e partecipò poi alle proteste studentesche
degli anni Trenta.
In realtà tutti
gli scrittori rivoluzionari sudamericani sono convinti salgariani.
García Márquez è uno, poi Osvaldo Soriano,
Francisco Coloane e Daniel Chavarría... cosa faceva
Sandokan, in fondo, se non lottare per la libertà, per la giustizia,
per i deboli contro i forti?
Immagine e parola
Nei romanzi di Emilio Salgari, l'immagine gioca un ruolo decisivo.
Il primo illustratore di Salgari fu lo stesso Salgari, che realizzò
alcuni schizzi dei momenti salienti delle sue trame. I primi
romanzi dell'autore ad essere illustrati sono stati La scimitarra
di Budda e La favorita del Mahdi, nello stile tipico
dell'epoca, l'Art
Nouveau. A livello di immagini l'autore può essere considerato
un vero anticipatore. Nei suoi testi il visivo è fortemente
presente, quasi in modo cinematografico, lasciando spazio
alla potenza della riproducibilità dell'immagine, che permette
di creare le premesse per un diverso rapporto con i lettori.
Il suo tipo di scrittura, molto moderno per l'epoca in cui è
inserito, evoca sempre il visivo. Con Salgari, infatti, nasce
un modello di romanzo che ha come elemento principale l'illustrazione:
l'immagine comincia ad essere considerata come un contributo
fondamentale al testo. Si potrebbe dire che il romanzo di Salgari
rappresenta un terreno fertile che permette il rapido passaggio
ad altre forme espressive, come la graphic novel moderna.
Adattamento a fumetti
per il "Corriere dei piccoli" delle Tigri di Mompracem
Il romanzo salgariano rappresenta si può dire, una forma primitiva
di graphic novel. Non a caso Hugo Pratt, che conosceva
bene il lavoro dello scrittore, dal 1969 con Mino Milani
iniziò a realizzare un adattamento a fumetti per il "Corriere
dei piccoli" de Le tigri di Mompracem, e pubblicò i suoi
primi fumetti argentini sulla rivista "Salgari".
Le radici letterarie
dei fumetti di Pratt, la sua grande passione per la letteratura,
il periodo in cui lavorò in Argentina e gli adattamenti di opere
note, ad esempio nel romanzo Le meraviglie del 2000,
sono chiari esempi del legame indissolubile tra romanzi e fumetti;
un ponte letterario, artistico, sociale e culturale, costruito
con Emilio Salgari, tra Italia e Argentina, che resiste ancora
oggi.
Cronologia
delle opere e dei vari cicli dei romanzi
Ciclo dei pirati della Malesia
Ciclo dei Corsari delle Antille
Ciclo dei corsari delle Bermude
Ciclo Far West
Ciclo dei due marinai
Ciclo del fiore
delle Perle /Ciclo del mar giallo
Ciclo "I Figli
dell’aria"
Ciclo Capitan
Tempesta
Avventure in India
Avventure africane
Avventure in Russia
Fantascienza
Romanzi storici
Avventure in Persia
Romanzi d'Oriente
Romanzi in Oceania
Romanzi di mare
Romanzi del Far
West
Romanzi tra i
ghiacci
Nel paese dei ghiacci
Romanzi nelle Americhe
Romanzi in Italia
Racconti
I racconti della “Bibliotechina Aurea Illustrata?
Autobiografico
Di seguito alcuni
dei titoli più noti della sterminata produzione salgariana:
Copyright © Informagiovani-italia.com. La
riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi
supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione
scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal☕
Torna su
|
