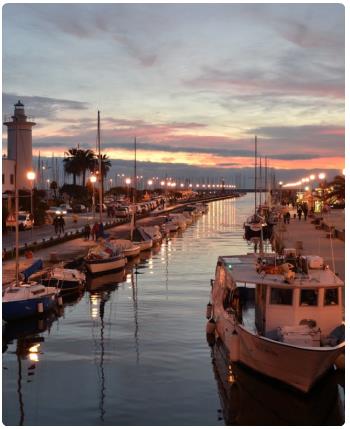Circa un
millennio fa, la zona in cui si trova oggi
Viareggio, era completamente sommersa dal mare.
L'area interna, piena di acqua stagnante e
puzzolente, costituiva una vasta palude infestata da
zanzare e malaria. Questo territorio era l'accesso
al mare della Repubblica di Lucca, che decise nel
1171, in accordo con i genovesi, alleati contro
Pisa, di costruire un castello cilindrico alto circa
40 metri per difendere la zona. La strada per
accedere al castello era molto difficile e
successivamente prese il nome di Viam Regiam.
perchè la strada, di notevole valenza strategica,
era posta sotto la protezione dell'Imperatore del
Sacro Romano Impero, Federico Barbarossa (ricordiamo
che Lucca era una città indipendente ma posta sotto
la protezione dell'Impero). Secondo alcune teorie,
il nome della città di Viareggio potrebbe derivare
proprio dal nome di questa strada.
Dopo essere stato conteso da Pisa e Lucca, il
castello perse gradualmente la sua importanza
militare. In seguito, il castello fu dato in
feudo al lucchese Pagano Baldovini da Federico II.
Nel 1441, Lucca perse il suo scalo marittimo di
Motrone e dovette trasferire il porto alla foce del
canale Burlamacca.
Nel 1460, i lucchesi decisero di bonificare le terre
circostanti, offrendo terreni a coloro che volevano
partecipare all'opera di bonifica affidata a un ingegnere di
nome Lionello. Nonostante le difficoltà, l'approdo migliorò
gradualmente, aprendo la strada ai traffici mercantili che
arrivavano dal mare a Lucca. Nel 1534 il Senato di Lucca
decretò la costruzione di una nuova fortificazione più
vicina al mare, la Torre Matilde, per proteggere il
canale e difendersi dai vicini pisani. Al 1559 risale la
Chiesa di San Pietro, la prima dell'abitato, che in seguito
sarebbe diventata la Chiesa di SS, Annunziata. Nel 1600
viene aperto il primo mercato agricolo.
Nel 1618, Viareggio divenne capoluogo della Vicaria del
litorale. Durante il Settecento, Viareggio era una zona
malsana a causa delle paludi e delle zone acquitrinose, e la
popolazione era molto ridotta, solo 22 abitanti nel 1742.
Tuttavia, a metà del secolo, l'ingegnere idraulico
Bernardino Zendrini, al servizio della Repubblica di
Venezia, iniziò a bonificare la zona. Egli tagliò la macchia
palustre, costruì le cateratte e scavò il fondale del
Burlamacca per migliorare la situazione ambientale.
Zendrini riesce nel suo intento ricavando al posto di
malsani acquitrini, terreni fertili alla coltivazione. Per
riparare i campi dal salmastro marino vengono piantati i
pini che daranno origine alle famose e grandi pinete che
possiamo ammirare ancora oggi.
Nel 1748, l'architetto Valentino Valentini tracciò un piano
regolatore in cui le vie furono disposte in modo ortogonale,
parallele e perpendicolari al mare. I terreni bonificati
furono ripartiti tra le famiglie nobili lucchesi, ma la
popolazione locale si sentì esclusa e protestò. Il Senato
della Repubblica intervenne e annullò le concessioni,
rivendendole tramite aste pubbliche. Le famiglie nobili
lucchesi decisero quindi di costruire le loro ville a
Viareggio, trasformando il borgo in un paese. La vita
economica si concentrò sull'agricoltura e sullo scalo
marittimo, mentre la popolazione continuò a crescere.
Anche la città di Lucca fu conquistata da Napoleone e
trasformata in Principato, governata di fatto dalla sorella
Elisa Bonaparte, che fu incoraggiata dal fratello
imperatore ad aumentare l'attività marittima. I pescatori
erano invitati ad imbarcare ragazzi di 12 anni per insegnare
loro a pescare in cambio di un'indennità annuale. L'altra
sorella di Napolene, Paolina Borghese, si fa
costruire l'edificio oggi noto come Palazzo Paolina.
Dopo la caduta di Napoleone, lo stato di Lucca fu assegnato
a Maria Luisa di Borbone e Viareggio fu elevata a
città nel 1820. I Borboni trasformarono Viareggio, grazie al
suo architetto di fiducia, Lorenzo Nottolini (che
abbiamo già incontrato nella nostra guida di Lucca) che nel
giro di pochi decessi sarebbe diventata un famoso centro di
villeggiatura e costruirono una darsena nel 1819 per
favorire l'attività cantieristica.
Nel 1822, la morte del poeta Shelley intaccò
l'atmosfera vacanziera di Viareggio e la città divenne meta
di pellegrinaggio per i letterati europei. Nel 1825, i primi
"bagnetti" iniziarono ad essere costruiti grazie ad alcune
iniziative locali. Nel 1826, Carlo Lodovico di Borbone
perfezionò il piano regolatore e disciplinò le concessioni
delle aree fabbricabili e prestò maggior attenzione
all'estetica dei fabbricati. Nel 1827, approvò il progetto
di costruzione dello stabilimento dei bagni comunali. Tra il
1820 e il 1828, furono costruite 234 case e vennero
installate una ventina di risaie nei terreni paludosi dietro
la città.
Nel corso dell'Ottocento, Viareggio, con il suo mare e i
suoi bagni, divenne una delle mete balneari più popolari
d'Italia. Il duca Carlo Lodovico, che governava la città nel
primo quarto del secolo, fece costruire due stabilimenti
balneari ad U, considerati i primi in Italia, dove si
praticava la talassoterapia per curare varie malattie. Ogni
anno venivano eseguiti lavori di abbellimento e
manutenzione, e venivano organizzate feste e giochi.
Nel 1838 vennero costruiti i bagni caldi, noti anche come
bagni d'Igea, tutti in marmo bianchissimo e con finestre
che davano direttamente sul mare, per poter godere di un
magnifico paesaggio. L'acqua dei bagni poteva essere salata
o dolce, a seconda della richiesta del bagnante. Nel 1847,
Carlo Lodovico cedette il ducato di Lucca a Leopoldo II di
Toscana.
Durante l'Ottocento, Viareggio fu chiamata la "Perla del
Tirreno" e divenne una meta turistica molto frequentata, sia
per la bellezza del mare che per l'offerta di servizi
balneari, come i bagni, i bagnetti e i bagni d'Igea. La
città crebbe anche grazie all'iniziativa di alcuni
viareggini, che costruirono le prime case e i primi
stabilimenti balneari, e all'attenzione del governo locale,
che disciplinò le concessioni delle aree fabbricabili e
promosse la costruzione di una darsena e di uno stabilimento
per i bagni comunali.
Alla fine del secolo, Viareggio era già una città in
crescita, con un'economia basata sul turismo e
sull'industria cantieristica, ma anche sulla coltivazione
del riso nelle risaie installate nei terreni paludosi dietro
la città.
Nonostante la balneazione fosse già praticata, i primi bagni
aperti al pubblico furono il Dori e il Nereo
nel 1823, ma permettevano l'ingresso solo ai singoli sessi.
Nel XIX secolo, con l'avvento del turismo, Viareggio
cominciò a diventare una località di villeggiatura,
frequentata dalle famiglie aristocratiche di Lucca e di
Firenze. In questo periodo furono costruite le prime
strutture alberghiere, come il Grand Hotel Principe di
Piemonte, e furono realizzate le prime passeggiate e i
primi stabilimenti balneari. Nel 1860, la Lucchesia e
Viareggio entrarono a far parte del Regno d'Italia. Nel
tardo 1800 furono costruiti altri stabilimenti balneari come
il Nettuno, il Balena, il Felice e il
lungomare fu reso ancora più sfarzoso grazie alla
costruzione di edifici in stile Liberty. Si prendono a
costruire lussuosi e confortevoli alberghi. Nel 1873 inizia
la straordinaria avventura del Carnevale viareggino, che
dura fino ai nostri giorni.
Molti personaggi famosi hanno scelto Viareggio come luogo di
vacanza nel passato, tra cui attori come Ermete Zacconi,
Dina Galli, Peppino De Filippo e Totò,
scrittori come Enrico Pea, Alberto Moravia e
Luigi Pirandello con la moglie Marta Abba, e
anche l'inventore Guglielmo Marconi e molti altri.
Questa scelta di Viareggio come meta turistica ha avuto
importanti conseguenze per l'industria della città, poiché
le attività rumorose e inquinanti sono state costrette ad
allontanarsi dalla zona urbana. Tuttavia, l'industria
navale, specializzata nella produzione di imbarcazioni da
diporto a vela e motore, continua ad essere fiorente nella
zona.
Nel 1917, un vasto incendio distrusse tutti i padiglioni
balneari, e l'unico edificio che rimase intatto fu lo stand
Martini, che rappresentava l'unica testimonianza della
passeggiata del diciannovesimo secolo. L'incendio fornì
l'occasione per rinnovare l'immagine del litorale, e i
variopinti padiglioni furono sostituiti da strutture più
uniformi, seguendo un disegno coerente. Nel 1928, fu dato
l'ordine di rimuovere tutti i pontili in legno dei bagni, e
da quel momento in poi, si può dire che un'era era giunta al
termine.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Viareggio subì numerosi
bombardamenti, che causarono danni ingenti alla città. Dopo
la guerra, la città conobbe un nuovo periodo di sviluppo
economico e turistico, grazie alla creazione di nuove
infrastrutture come la strada statale Aurelia e la
costruzione di nuovi complessi residenziali e alberghieri.
Oggi, Viareggio è una città vivace e dinamica, che offre
numerose attrazioni turistiche come le spiagge, le
passeggiate, il Carnevale di Viareggio e l'offerta culturale
dei suoi musei e delle sue gallerie d'arte.
Il settore della pesca è molto attivo a Viareggio, con una
flotta di pescherecci che garantisce una produzione ittica
annua di 80.000 tonnellate. L'artigianato e la floricoltura
(garofani, tulipani, rose, fresie, ecc.) sono anche
sviluppati nella città.
Viareggio vanta importanti opere d'arte in stile Liberty Art
Nouveau, numerosi palazzi illustri e monumenti lasciati da
Lorenzo Viani. Oltre alla Torre Matilde, che è stata
utilizzata come carcere dal 1819 fino alla fine della
Seconda Guerra Mondiale, ci sono anche i palazzi Bernardini,
Piccioli, Belluomini (che ha ospitato Pio VII) e Palazzo
Cittadella, che è diventato in seguito l'Albergo Vittoria,
dove hanno soggiornato Alessandro Manzoni (nel 1846)
e Giuseppe Giusti (nel 1849).
C'è anche il raffinato Palazzo Paolina, nonché la
villa Puccini, a Torre del Lago ultima dimora del
Maestro ormai malato, dove è stata creata l'opera Turandot.
Infine, c'è il monumento romantico del 1894 al poeta inglese
Percy Bysshe Shelley, annegato al largo di Viareggio
nel 1822.
L'unica frazione di Viareggio è appunto Torre del Lago,
così chiamata per una torre del XV secolo che
originariamente si chiamava Torre Guinigi, come quella di
Lucca appartenente alla potente famiglia omonima, poi
chiamata Torre del Turco, dal nome dei successivi
proprietari. Nel 1925, in onore del più illustre dei suoi
cittadini, il paese ha aggiunto il nome di Puccini.
Nelle vicinanze si trova anche Villa Borbone, con una
bellissima tenuta fatta costruire da Maria Luisa di Borbone
e progettata sempre da Lorenzo Nottolini, che è sede di
manifestazioni legate al festival pucciniano. La villa
conserva una cappella del 1849 costruita dal Gheri, con
pregevoli opere pittoriche e belle sculture di marmo, dove
si trovano le tombe di Carlo III dei Borbone, duca di Parma,
e Carlo Ludovico di Borbone, ultimo duca di Lucca.




Ostelli Viareggio
Ostelli Italia
Auberges de Jeunesse
Italie
Hotel Viareggio
Carte Viareggio
Karte von Viareggio
Mapa Viareggio
Map of Viareggio
Carte
de la Toscane
Karte von Toskana
Mapa Toscana
Map of Tuscany
Carte d'Italie
Karte von Italien
Mapa Italia
Map of Italy