|
|
Sei qui: Siena
>
Cosa vedere a Siena >
Duomo di Siena - Cattedrale di Siena
|
Se il
Palazzo
Pubblico è il capolavoro
dell'architettura civile di Siena il Duomo lo
è per quella religiosa. All'uno e all'altro
guardano, con stupefatta ammirazione, i più illustri
visitatori della città: per il Duomo, basti qui
ricordare, fra i tanti nomi prestigiosi, quelli di
Taine, Ruskin (la Chiesa più
straordinaria che avesse mai visto in Italia), di
Wagner. Il Duomo o Cattedrale di Siena è
dedicata a Santa Maria Assunta
ed è stata realizzata in stile romano-gotico.
|
|
Non sappiamo esattamente quando questa
chiesa venne edificata, ciò che è certo è che nel 1226 vi fu una
registrazione sulle spese per la sua costruzione.
Storia della
costruzione del Duomo di Siena
 È
molto probabile che, nel luogo dove oggi sorge il Duomo, vi fosse in
precedenza un tempio pagano, dedicato alla dea Minerva. La tradizione vuole
che la consacrazione della cattedrale avvenne il 18 novembre del 1179
e che venne consacrata dallo stesso
Papa Alessandro III. Ancora oggi, il 18 novembre viene esposto lo
stendardo papale. Quello che è certo è che qui esisteva già, fin dall'XI
secolo, una piccola chiesa con funzione di cattedrale. Verso la metà del
secolo seguente, all'alba dell'età comunale, si diede inizio alla
costruzione di un tempio più grande e cui strutture essenziali erano già
innalzate nel secondo decennio del 1200. Grande impulso alla prosecuzione
dell'opera diedero, dal 1238 al 1285, i monaci cistercense dell'Abbazia
di San Galgano
(farà le prime chiese gotiche italiane di cui rimangono
ancora, presso Siena, imponenti rovine) con i quali si impiantò la cupola
tra il 1259 e il 1264 e si edificarono l'abside e il peribolo (recinto
sacro) nel 1267 entrambi poi demoliti. Furono sempre i monaci cistercensi ad
affidare a Nicola Pisano l'esecuzione del pulpito, e al figlio
Giovanni Pisano, la decorazione scultorea della parte inferiore della
facciata. Nel secondo decennio del 1300, durante il Governo dei Nove,
Siena volle sbandierare la sua raggiunta prosperità con l'ampliamento di una
cattedrale in onore di Maria Assunta: per questo si abbatterono
abside e capo di croce e il tempio fu prolungato, sotto la direzione di
Camaino di Crescentino 1317. Poi nemmeno questo sembrava bastare e si
immaginò una Chiesa che, per vastità e magnificenza, vincessi confronto col
Duomo di Firenze, città eterna rivale. È
molto probabile che, nel luogo dove oggi sorge il Duomo, vi fosse in
precedenza un tempio pagano, dedicato alla dea Minerva. La tradizione vuole
che la consacrazione della cattedrale avvenne il 18 novembre del 1179
e che venne consacrata dallo stesso
Papa Alessandro III. Ancora oggi, il 18 novembre viene esposto lo
stendardo papale. Quello che è certo è che qui esisteva già, fin dall'XI
secolo, una piccola chiesa con funzione di cattedrale. Verso la metà del
secolo seguente, all'alba dell'età comunale, si diede inizio alla
costruzione di un tempio più grande e cui strutture essenziali erano già
innalzate nel secondo decennio del 1200. Grande impulso alla prosecuzione
dell'opera diedero, dal 1238 al 1285, i monaci cistercense dell'Abbazia
di San Galgano
(farà le prime chiese gotiche italiane di cui rimangono
ancora, presso Siena, imponenti rovine) con i quali si impiantò la cupola
tra il 1259 e il 1264 e si edificarono l'abside e il peribolo (recinto
sacro) nel 1267 entrambi poi demoliti. Furono sempre i monaci cistercensi ad
affidare a Nicola Pisano l'esecuzione del pulpito, e al figlio
Giovanni Pisano, la decorazione scultorea della parte inferiore della
facciata. Nel secondo decennio del 1300, durante il Governo dei Nove,
Siena volle sbandierare la sua raggiunta prosperità con l'ampliamento di una
cattedrale in onore di Maria Assunta: per questo si abbatterono
abside e capo di croce e il tempio fu prolungato, sotto la direzione di
Camaino di Crescentino 1317. Poi nemmeno questo sembrava bastare e si
immaginò una Chiesa che, per vastità e magnificenza, vincessi confronto col
Duomo di Firenze, città eterna rivale.
 Questo
progetto di "Duomo Nuovo", modificava sostanzialmente la pianta della chiesa
precedente: tutta la parte costruita, infatti doveva costituire soltanto il
transetto al quale dovevano essere aggiunte le navate longitudinali con la
facciata ("il Facciatone"). L'impresa ciclopica fu iniziata nel 1339, da
Lando Di Pietro, al quale seguirono Giovanni di Agostino e
Domenico di Agostino. I lavori procedettero con rapidità eccezionale ma
anche con altissimo dispendio. La peste del 1348 impose un'interruzione
durante la quale emersero gravi insufficienze nella statica dell'edificio,
troppo frettolosamente portata avanti sul terreno non preparato e rassodato
a dovere. La crisi economica seguita alla peste, l'inutilità dei tentativi
di rimediare agli errori commessi, condussero alla decisione di interrompere
l'ambizioso progetto. Questo
progetto di "Duomo Nuovo", modificava sostanzialmente la pianta della chiesa
precedente: tutta la parte costruita, infatti doveva costituire soltanto il
transetto al quale dovevano essere aggiunte le navate longitudinali con la
facciata ("il Facciatone"). L'impresa ciclopica fu iniziata nel 1339, da
Lando Di Pietro, al quale seguirono Giovanni di Agostino e
Domenico di Agostino. I lavori procedettero con rapidità eccezionale ma
anche con altissimo dispendio. La peste del 1348 impose un'interruzione
durante la quale emersero gravi insufficienze nella statica dell'edificio,
troppo frettolosamente portata avanti sul terreno non preparato e rassodato
a dovere. La crisi economica seguita alla peste, l'inutilità dei tentativi
di rimediare agli errori commessi, condussero alla decisione di interrompere
l'ambizioso progetto.
Nei decenni successivi si sistemarono le
strutture pericolanti mentre quelle lasciate in piedi furono destinate a
uffici dell'Opera del Duomo (dove
Jacopo della Quercia
scolpì la
Fonte Gaia). Non rimase quindi altro che portare a termine il vecchio
Duomo: la nuova abside fu conclusa nel 1382, poi si rifecero più alte le
volte della navata centrale e, dal 1376, Giovanni di Cecco ultimò la
parte superiore della facciata.
Torna su
Parte esterna del Duomo di Siena
 Stilisticamente
la facciata del Duomo di Siena accomuna motivi strutturali romanici nella
parte inferiore, e gotici, nella parte superiore, ma l'anima del monumento,
per così dire, è tipicamente gotica. Solo le arcate del centro sono,
infatti, un motivo ancora romanico ma esse si inseriscono in un tutt'uno con
la articolata complessità e peculiarità dell'architettura gotica. La parte
inferiore è una mirabile creazione di Giovanni Pisano e dei suoi
aiutanti eseguita tra il 1284 e il 1296, ma venne finita solo nel 1333. È
divisa in tre parti dai portali sormontati da archi a tutto sesto (quelli
laterali leggermente archi acuti), questi ultimi inclusi dentro cuspidi
triangolari. Pilastri angolari (su uno zoccolo marmoreo) uniscono non solo
la parte inferiore ma tutto il prospetto. Fasci di colonnine finemente
decorate con motivi vegetali precedono il portale: quello di mezzo reca,
nell'architrave, un bassorilievo di Tino di Camaino evocante una
Storia di Anna e Gioacchino (i
genitori
della Madonna). Stilisticamente
la facciata del Duomo di Siena accomuna motivi strutturali romanici nella
parte inferiore, e gotici, nella parte superiore, ma l'anima del monumento,
per così dire, è tipicamente gotica. Solo le arcate del centro sono,
infatti, un motivo ancora romanico ma esse si inseriscono in un tutt'uno con
la articolata complessità e peculiarità dell'architettura gotica. La parte
inferiore è una mirabile creazione di Giovanni Pisano e dei suoi
aiutanti eseguita tra il 1284 e il 1296, ma venne finita solo nel 1333. È
divisa in tre parti dai portali sormontati da archi a tutto sesto (quelli
laterali leggermente archi acuti), questi ultimi inclusi dentro cuspidi
triangolari. Pilastri angolari (su uno zoccolo marmoreo) uniscono non solo
la parte inferiore ma tutto il prospetto. Fasci di colonnine finemente
decorate con motivi vegetali precedono il portale: quello di mezzo reca,
nell'architrave, un bassorilievo di Tino di Camaino evocante una
Storia di Anna e Gioacchino (i
genitori
della Madonna).
 Le statue e i busti, di Giovanni Pisano e dei suoi
collaboratori, si riferiscono a personaggi dell'antico testamento,: qui sono
in copia (gli originali si possono vedere nel Museo dell'Opera del Duomo)
la decorazione scultorea seguiva un criterio non solo decorativo ma anche
didascalico: la parte inferiore della facciata è infatti dedicata alla
preparazione dell'Avvento di Maria, quella superiore alla sua
presenza in terra sino all'assunzione in cielo. Ma la modifica nell'ordine
delle statue rende oggi meno leggibile questa successione tematica. La porta
centrale in bronzo e opera moderna di Enrico Manfrini del 1958,
glorificando la Madonna attraverso il ricordo della sua vita nonché dei
personaggi biblici, dei papi, dei santi e degli artisti che promossero la
devozione alla vergine. Le statue e i busti, di Giovanni Pisano e dei suoi
collaboratori, si riferiscono a personaggi dell'antico testamento,: qui sono
in copia (gli originali si possono vedere nel Museo dell'Opera del Duomo)
la decorazione scultorea seguiva un criterio non solo decorativo ma anche
didascalico: la parte inferiore della facciata è infatti dedicata alla
preparazione dell'Avvento di Maria, quella superiore alla sua
presenza in terra sino all'assunzione in cielo. Ma la modifica nell'ordine
delle statue rende oggi meno leggibile questa successione tematica. La porta
centrale in bronzo e opera moderna di Enrico Manfrini del 1958,
glorificando la Madonna attraverso il ricordo della sua vita nonché dei
personaggi biblici, dei papi, dei santi e degli artisti che promossero la
devozione alla vergine.
 La
parte superiore della facciata, espressione dell'estrema evoluzione del
gotico, è tutto un fiorire di motivi decorativi: statue tarde trecentesche
(anche in questo caso gli originali sono al museo dell'Opera del Duomo),
fregi, tarsie, eccetera, attorno alle strutture fondamentali. Il grande
rosone centrale si trova dentro un'ordinatissima cornice quadrata
(adornata di patriarchi, profeti, evangelisti e, in alto, della Madonna). Le
due gallerie laterali tentacoli sono separate dalla citata cornice da due
piloni, nonché La
parte superiore della facciata, espressione dell'estrema evoluzione del
gotico, è tutto un fiorire di motivi decorativi: statue tarde trecentesche
(anche in questo caso gli originali sono al museo dell'Opera del Duomo),
fregi, tarsie, eccetera, attorno alle strutture fondamentali. Il grande
rosone centrale si trova dentro un'ordinatissima cornice quadrata
(adornata di patriarchi, profeti, evangelisti e, in alto, della Madonna). Le
due gallerie laterali tentacoli sono separate dalla citata cornice da due
piloni, nonché
 le
tre cuspidi terminali, con la centrale assai più alta delle altre, su cui
svetta un angelo, di
Tommaso Redi del 1639. La superficie di queste cuspidi e
animata da mosaici eseguiti dalla scuola di Murano su cartoni di
Luigi Mussini e Alessandro Franchi nel tardo ottocento,
illustranti, a sinistra, la Presentazione della vergine al tempio,
nel centro l'Incoronazione di Maria, a destra, la Natività di Gesù. le
tre cuspidi terminali, con la centrale assai più alta delle altre, su cui
svetta un angelo, di
Tommaso Redi del 1639. La superficie di queste cuspidi e
animata da mosaici eseguiti dalla scuola di Murano su cartoni di
Luigi Mussini e Alessandro Franchi nel tardo ottocento,
illustranti, a sinistra, la Presentazione della vergine al tempio,
nel centro l'Incoronazione di Maria, a destra, la Natività di Gesù.
I progettista della parte superiore della
facciata, il senese Giovanni di Cecco nel 1376 si ispirò, con tutta
evidenza, alla quasi coeva facciata del Duomo di Orvieto, capolavoro
di un altro senese, Lorenzo Maitani. L'attuazione di questo disegno
diede luogo alla simmetria dei piloni laterali alla cornice del rosone
rispetto ai sottostanti pilastri del portale mediano: a simmetria che però
non inficia la validità estetica dell'intero organismo architettonico.
Torna su
Fianco destro e Campanile
 Sul
fianco destro del Duomo (quello sinistro, con una monofora chiusa, e
congiunto con il palazzo arcivescovile), divise da pilastri coronati da
copie di statue trecentesche (gli originali sono in un sotterraneo del
Duomo) è sforato da rifare ogivali cuspidato. Il paramento è orizzontalmente
percorso da strisce di marmi scuri alternati ad ampie fasce di marmi
bianchi: questa decorazione prosegue nel transetto destro, aperto da fine
strato gotico, nel capo di croce che fa corpo unico con battistero, nonché
nel
Campanile,
eretto nel 1313 sopra la preesistente struttura della Torre dei
Bisdomini, su disegno di Agostino di Giovanni e di
Agnolo di Ventura. Sul
fianco destro del Duomo (quello sinistro, con una monofora chiusa, e
congiunto con il palazzo arcivescovile), divise da pilastri coronati da
copie di statue trecentesche (gli originali sono in un sotterraneo del
Duomo) è sforato da rifare ogivali cuspidato. Il paramento è orizzontalmente
percorso da strisce di marmi scuri alternati ad ampie fasce di marmi
bianchi: questa decorazione prosegue nel transetto destro, aperto da fine
strato gotico, nel capo di croce che fa corpo unico con battistero, nonché
nel
Campanile,
eretto nel 1313 sopra la preesistente struttura della Torre dei
Bisdomini, su disegno di Agostino di Giovanni e di
Agnolo di Ventura.
 In esso, secondo i prototipi lombardi, le aperture
si fanno più ampie procedendo dal basso (monofora) verso l'alto (evapora) e
la copertura in forma di cuspide contornata da quattro pinnacoli. Il
campanile del Duomo di Siena in stile romanico, alto quasi 77 metri, venne
costruito nel 1313. Insieme alla
Torre del
Mangia alta 88 metri è uno dei punti di riferimento
cittadini. Della precedente torre campanaria rimangono le strutture murarie
visibili nella cella interna. Il campanile possiede sei campane, che quasi
formano una scala diatonica corretta, di epoche e fusioni differenti fra
loro. Il loro suono sotto il punto di vista acustico non è sicuramente dei
migliori ma sono molto interessanti sotto il punto di vista storico. In esso, secondo i prototipi lombardi, le aperture
si fanno più ampie procedendo dal basso (monofora) verso l'alto (evapora) e
la copertura in forma di cuspide contornata da quattro pinnacoli. Il
campanile del Duomo di Siena in stile romanico, alto quasi 77 metri, venne
costruito nel 1313. Insieme alla
Torre del
Mangia alta 88 metri è uno dei punti di riferimento
cittadini. Della precedente torre campanaria rimangono le strutture murarie
visibili nella cella interna. Il campanile possiede sei campane, che quasi
formano una scala diatonica corretta, di epoche e fusioni differenti fra
loro. Il loro suono sotto il punto di vista acustico non è sicuramente dei
migliori ma sono molto interessanti sotto il punto di vista storico.
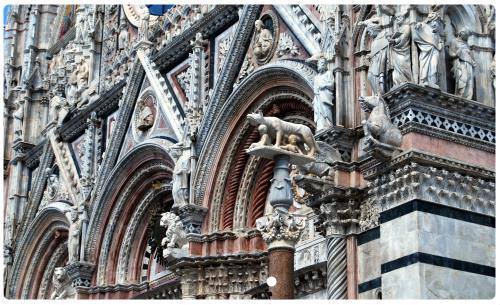 Spostandoci
ora sulla piattaforma che precede l'ingresso frontale del Duomo, sul
pavimento troviamo, tre restaurati graffiti (copie di originali di
Nastagio di Gaspare, del 1450) figurano la Cerimonia delle
restrizioni delle gerarchie ecclesiastiche. Ai lati della scalinata due
colonne recano la simbolica Lupa che allatta i gemelli, copie di
Giovanni Pisano
e di Urbano da Cortona (gli originali si trovano nel museo dell'Opera
del Duomo). Percorrendo il fianco sinistro del Duomo di Siena, si arriva in
vista delle superbe strutture del "Duomo Nuovo" erette tra il 1339 e
il 1355. Esse comprendono parte della facciata principale, il cosiddetto
Facciatone; la navata destra, attaccata al Duomo è scandita da cinque
enormi arcate (e aperta nella parete); una parte del fianco sinistro con tre
arcate e monofore ceche sono incastrate nelle mura del palazzo della
prefettura. Quello che vediamo ci lascia immaginare l'incomparabile
grandiosità dell'opera se fosse stata compiuta e ci dà qualche saggio
della sua alta qualità d'arte: si osservino a questo proposito le
decorazioni di Giovanni D'Agostino ideatore anche della bellissima porta
laterale nel 1345. Nelle prime tre arcate chiuse della navata destra è
ubicato Museo dell'Opera del Duomo. Spostandoci
ora sulla piattaforma che precede l'ingresso frontale del Duomo, sul
pavimento troviamo, tre restaurati graffiti (copie di originali di
Nastagio di Gaspare, del 1450) figurano la Cerimonia delle
restrizioni delle gerarchie ecclesiastiche. Ai lati della scalinata due
colonne recano la simbolica Lupa che allatta i gemelli, copie di
Giovanni Pisano
e di Urbano da Cortona (gli originali si trovano nel museo dell'Opera
del Duomo). Percorrendo il fianco sinistro del Duomo di Siena, si arriva in
vista delle superbe strutture del "Duomo Nuovo" erette tra il 1339 e
il 1355. Esse comprendono parte della facciata principale, il cosiddetto
Facciatone; la navata destra, attaccata al Duomo è scandita da cinque
enormi arcate (e aperta nella parete); una parte del fianco sinistro con tre
arcate e monofore ceche sono incastrate nelle mura del palazzo della
prefettura. Quello che vediamo ci lascia immaginare l'incomparabile
grandiosità dell'opera se fosse stata compiuta e ci dà qualche saggio
della sua alta qualità d'arte: si osservino a questo proposito le
decorazioni di Giovanni D'Agostino ideatore anche della bellissima porta
laterale nel 1345. Nelle prime tre arcate chiuse della navata destra è
ubicato Museo dell'Opera del Duomo.
Torna su
Interno
 La
pianta della chiesa è di impianto romanico a croce latina, suddivisa in tre
navate ampio transetto, abside e coro, volta a crociera con archi a
pieno centro e la cupola sovrastante. L'occhio è subito attratto dalla selva
di possenti pilastri polistili che dividono le navate e proseguono nei due
bracci del transetto (i pilastri sono in tutto ben 26): in essi ritorna
quella di cromia di marmi che abbiamo già visto all'esterno. Una variazione
di colori che, se frenano un pochino lo slancio verticale, danno allo stesso
tempo calore e sensazioni pittoriche a tutta la chiesa, alle quali
contribuiscono anche la policromia delle pareti, l'azzurro le stelle dipinte
delle volte è, più di tutto, la stupenda pavimentazione. Entrati nella
cattedrale ciò che colpisce maggiormente è la sua meravigliosa navata
centrale, dalla quale si possono ammirare ben 171 busti che
raffigurano altrettanti Papi, tra i quali c’è anche San Pietro. Sotto i
Papi vi sono trentasei busti di imperatori, ma non essendoci didascalie, non
si sa esattamente chi siano. La
pianta della chiesa è di impianto romanico a croce latina, suddivisa in tre
navate ampio transetto, abside e coro, volta a crociera con archi a
pieno centro e la cupola sovrastante. L'occhio è subito attratto dalla selva
di possenti pilastri polistili che dividono le navate e proseguono nei due
bracci del transetto (i pilastri sono in tutto ben 26): in essi ritorna
quella di cromia di marmi che abbiamo già visto all'esterno. Una variazione
di colori che, se frenano un pochino lo slancio verticale, danno allo stesso
tempo calore e sensazioni pittoriche a tutta la chiesa, alle quali
contribuiscono anche la policromia delle pareti, l'azzurro le stelle dipinte
delle volte è, più di tutto, la stupenda pavimentazione. Entrati nella
cattedrale ciò che colpisce maggiormente è la sua meravigliosa navata
centrale, dalla quale si possono ammirare ben 171 busti che
raffigurano altrettanti Papi, tra i quali c’è anche San Pietro. Sotto i
Papi vi sono trentasei busti di imperatori, ma non essendoci didascalie, non
si sa esattamente chi siano.
Torna su
Pavimento
 Il
pavimento è uno dei vanti del Duomo di Siena, suddiviso com'è in 56
riquadri, i più antichi dei quali dal 1369 in poi, a graffito, i più
recenti, quelli fino al 1547, a commesso di marmi (un tipo di mosaico con in
marmi). Il pavimento istoriato fa parte di una concezione gotica transalpina
del tempio, secondo la quale ogni elemento deve concorrere organicamente al
fine ultimo dell'esaltazione della divinità, della preparazione alla strada
del cielo. I soggetti dei riquadri sono dedicati, per gran parte, a fatti
del Vecchio Testamento (Storie di Mosé, di Giosuè, di Abramo, di
Elia) ma, con essi, sono commiste figure mitiche (le Sibille,
ritenute però anticipatrici di Cristo) e allegoriche (Virtù) nonché,
unico episodio del nuovo testamento, la rappresentazione della Strage
degli innocenti. A quest'artistica fatica durata due secoli si
dedicarono una quarantina di artisti, perlopiù senesi. Alcuni riquadri,
malridotti dal tempo sono stati in parte rifatti o sostituiti da copie.
Altri, i più antichi pregevoli, vengono protetti da tavolate e sono visibili
ogni anno dal 15 agosto al 15 settembre. Ricordiamo qui alcuni fra i più
rinomati autori di cartoni per l'esecuzione del pavimento: Domenico di
Nicolò, Matteo di Giovanni, Domenico di Bartolo,
Benvenuto di Giovanni, Urbano da Cortona,
Antonio Federighi, Neroccio di Bartolomeo, il Pinturicchio,
e massimo fra tutti per novità di invenzioni e operosità, Domenico
Beccafumi, che, del 1547, fece i disegni di 35 riquadri. Il
pavimento è uno dei vanti del Duomo di Siena, suddiviso com'è in 56
riquadri, i più antichi dei quali dal 1369 in poi, a graffito, i più
recenti, quelli fino al 1547, a commesso di marmi (un tipo di mosaico con in
marmi). Il pavimento istoriato fa parte di una concezione gotica transalpina
del tempio, secondo la quale ogni elemento deve concorrere organicamente al
fine ultimo dell'esaltazione della divinità, della preparazione alla strada
del cielo. I soggetti dei riquadri sono dedicati, per gran parte, a fatti
del Vecchio Testamento (Storie di Mosé, di Giosuè, di Abramo, di
Elia) ma, con essi, sono commiste figure mitiche (le Sibille,
ritenute però anticipatrici di Cristo) e allegoriche (Virtù) nonché,
unico episodio del nuovo testamento, la rappresentazione della Strage
degli innocenti. A quest'artistica fatica durata due secoli si
dedicarono una quarantina di artisti, perlopiù senesi. Alcuni riquadri,
malridotti dal tempo sono stati in parte rifatti o sostituiti da copie.
Altri, i più antichi pregevoli, vengono protetti da tavolate e sono visibili
ogni anno dal 15 agosto al 15 settembre. Ricordiamo qui alcuni fra i più
rinomati autori di cartoni per l'esecuzione del pavimento: Domenico di
Nicolò, Matteo di Giovanni, Domenico di Bartolo,
Benvenuto di Giovanni, Urbano da Cortona,
Antonio Federighi, Neroccio di Bartolomeo, il Pinturicchio,
e massimo fra tutti per novità di invenzioni e operosità, Domenico
Beccafumi, che, del 1547, fece i disegni di 35 riquadri.
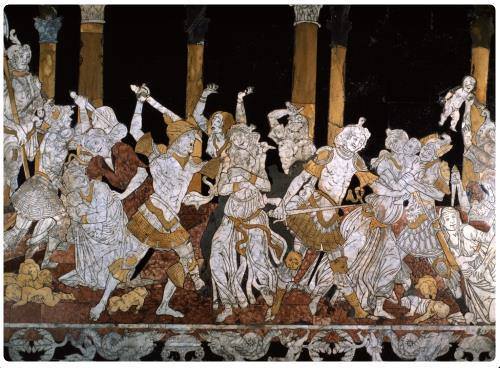 A
lui dobbiamo le più belle storie bibliche fra le quali eccellenti sono
Mosé fa scaturire dalle acque dalla rupe Horeb, il Sacrificio di
Abramo, ambedue nel presbiterio, il Sacrificio di Ahab, sotto la
cupola. Particolare attenzione meritano ancora l'Allegoria della fortuna,
di Paolo Mannucci su cartoni del Pinturicchio nella navata centrale,
la Sibilla Eritrea, di Antonio Federighi
nella navata destra; l'Imperatore Sigismondo in trono, di Domenico
di Bartolo nel transetto destro, l'Allegoria della giustizia, di
Marchese d'Adamo da Como nell'abside sinistra, la Strage degli
innocenti, di Matteo di Giovanni ed Erode cacciato dal trono,
di Benvenuto di Giovanni. Ambedue nel transetto sinistro. A
lui dobbiamo le più belle storie bibliche fra le quali eccellenti sono
Mosé fa scaturire dalle acque dalla rupe Horeb, il Sacrificio di
Abramo, ambedue nel presbiterio, il Sacrificio di Ahab, sotto la
cupola. Particolare attenzione meritano ancora l'Allegoria della fortuna,
di Paolo Mannucci su cartoni del Pinturicchio nella navata centrale,
la Sibilla Eritrea, di Antonio Federighi
nella navata destra; l'Imperatore Sigismondo in trono, di Domenico
di Bartolo nel transetto destro, l'Allegoria della giustizia, di
Marchese d'Adamo da Como nell'abside sinistra, la Strage degli
innocenti, di Matteo di Giovanni ed Erode cacciato dal trono,
di Benvenuto di Giovanni. Ambedue nel transetto sinistro.
Oltre al pavimento, un'altra peculiarità
artistica del Duomo di Siena, sono la serie di 172 busti immaginari di
pontefici (compresi il busto di Cristo, in fondo all'abside) che fanno
da mensole al conrbicione che corre sull'alto della navata centrale e del
presbiterio. Sotto questi busti sono collocati, a intervalli, altri 36
busti immaginari di imperatori, da Costantino a Teodosio: sono tutte
sculture del quattro e del 500. Presso l'ingresso si trovano due
Acquasantiere finemente lavorate da Antonio Federighi nel 1463.
Torna su
Retrofacciata
 Il
portale di mezzo è adornato di colonne decorate da Giovanni Di Stefano,
con piedistalli di bassorilievi (Storie di Maria) di Urbano da
Cortona; sopra il portale, l'architrave reca altri rilievi dedicati alla
Vita di Sant'Ansano del XV secolo. La vetrata a colori del Rosone
mostra un'Ultima Cena) opera di
Pastorino de' Pastorini che la realizzò nel 1549, forse su cartone di
Perin del Vaga (della bottega del Ghirlandaio e collaboratore
di
Raffaello).
Ai lati, sempre in controfacciata, In una nicchia, si trova la statua di
Paolo V (Camillo borghese di Siena), di Fulvio Signorini
nel 1605 e Marcello II di Domenico Cafaggi per volere del
rettore dell'Opera del Duono Giugurta Tommasi per rappresentare i
primi due papi senesi Alessandro III (1591) e Pio II (1592).
In seguito furono convertiti in altri papi per aggiunta delle barbe, ad
opera della bottega della famiglia Mazzuoli (anni ottanta del Seicento). È
presumibile che questo fu fatto per non oscurare il programma di
rappresentazione di tutti i papi senesi con nuovi monumenti commemorativi
che si stava compiendo in quegli anni. Il
portale di mezzo è adornato di colonne decorate da Giovanni Di Stefano,
con piedistalli di bassorilievi (Storie di Maria) di Urbano da
Cortona; sopra il portale, l'architrave reca altri rilievi dedicati alla
Vita di Sant'Ansano del XV secolo. La vetrata a colori del Rosone
mostra un'Ultima Cena) opera di
Pastorino de' Pastorini che la realizzò nel 1549, forse su cartone di
Perin del Vaga (della bottega del Ghirlandaio e collaboratore
di
Raffaello).
Ai lati, sempre in controfacciata, In una nicchia, si trova la statua di
Paolo V (Camillo borghese di Siena), di Fulvio Signorini
nel 1605 e Marcello II di Domenico Cafaggi per volere del
rettore dell'Opera del Duono Giugurta Tommasi per rappresentare i
primi due papi senesi Alessandro III (1591) e Pio II (1592).
In seguito furono convertiti in altri papi per aggiunta delle barbe, ad
opera della bottega della famiglia Mazzuoli (anni ottanta del Seicento). È
presumibile che questo fu fatto per non oscurare il programma di
rappresentazione di tutti i papi senesi con nuovi monumenti commemorativi
che si stava compiendo in quegli anni.
Torna su
Navata destra
 Seguono
quattro altari adorni di pitture seicentesche; che la si aprono la porta
laterale quella di accesso al campanile. Sopra questa porta sta alla tomba
del vescovo Tommaso Piccolomini del Testa, di
Neroccio di Bartolo eseguita tra il 1484 al 1485; ai lati della tomba,
rilievi di
Urbano da Cortona con Sei episodi della vita della Madonna di cui
è notevole l'Annunciazione. Da qui c'è uno stupendo colpo d'occhio
sulla cupola che si innalza al centro della crociera. Impostata su sei
piloni (ai due lati della navata di mezzo sono appoggiate le antenne issate
sul Carroccio di Siena
durante la Battaglia di Montaperti). Seguono
quattro altari adorni di pitture seicentesche; che la si aprono la porta
laterale quella di accesso al campanile. Sopra questa porta sta alla tomba
del vescovo Tommaso Piccolomini del Testa, di
Neroccio di Bartolo eseguita tra il 1484 al 1485; ai lati della tomba,
rilievi di
Urbano da Cortona con Sei episodi della vita della Madonna di cui
è notevole l'Annunciazione. Da qui c'è uno stupendo colpo d'occhio
sulla cupola che si innalza al centro della crociera. Impostata su sei
piloni (ai due lati della navata di mezzo sono appoggiate le antenne issate
sul Carroccio di Siena
durante la Battaglia di Montaperti).
Agli angoli dell'esagono della cupola, sei
colonne sostengono altrettante statue dorate di santi (i quattro patroni di
Siena, nonché San Bernardino a Santa Caterina) modellate da Ventura
Turapilli
e da Bastiano di Francesco tra il XV e il XVI secolo. Sopra queste
colonne si incurvano nicchie che trasformano l'esagono della cupola nel
dodecagono del tamburo. Quest'ultimo si adorna di un finto loggiato spartito
da 42 colonnette e nelle cui piccole arcate appaiono le figure di 42
patriarchi profeti, dipinte in chiaroscuro da vari artisti senesi del 1400.
Più in alto si incurva la calotta terminale della cupola decorata a finti
lagunari e conclusa dalla lanterna alla sommità.
Torna su
Cappella Ghigi e Transetto
Sinistro
 Il
transetto destro, come l'opposto, è distinto in due navate da pilastri. A
destra si apre la Cappella Chigi (o della Madonna del voto) costruita
nel 1661 su progetto del celeberrimo caposcuola barocco Gianlorenzo
Bernini, per volere del Papa senese
Alessandro VII Chigi. In un ambiente circolare sormontato da cupola
dorata, è tutto un trionfo di decorazioni. Otto colonne lo spartiscono in
altrettanti settori, ovunque ci sono stato, marmi, bronzi, fregi, quadri.
Sull'altare, disegnato dallo stesso Bernini posa la tavola raffigurante la
Madonna del voto, di un imitatore di Guido da Siena del tardo
duecento. Si ritengono del Bernini gli angeli in bronzo dorato che
contornano la Madonna del voto mentre di sua mano sono sicuramente le
splendide statue di San Girolamo e della Maddalena posti in
una nicchia presso l'ingresso. Le altre statue nelle nicchie ai fianchi
dell'altare si devono a scultori lombardi del seicento (Ercole Ferrara
e Antonio Raggi) mentre i sovrastanti quattro bassorilievi, le storie
di Maria, furono eseguiti a Roma nel 1748. Nella parete sinistra, si trova
la
Visitazione della Madonna a Elisabetta, quadro del marchigiano Carlo
Maratta del tardo seicento, al quale Maratta si ispira anche per il
mosaico della parete opposta evocante la sua Fuga in Egitto. Il
transetto destro, come l'opposto, è distinto in due navate da pilastri. A
destra si apre la Cappella Chigi (o della Madonna del voto) costruita
nel 1661 su progetto del celeberrimo caposcuola barocco Gianlorenzo
Bernini, per volere del Papa senese
Alessandro VII Chigi. In un ambiente circolare sormontato da cupola
dorata, è tutto un trionfo di decorazioni. Otto colonne lo spartiscono in
altrettanti settori, ovunque ci sono stato, marmi, bronzi, fregi, quadri.
Sull'altare, disegnato dallo stesso Bernini posa la tavola raffigurante la
Madonna del voto, di un imitatore di Guido da Siena del tardo
duecento. Si ritengono del Bernini gli angeli in bronzo dorato che
contornano la Madonna del voto mentre di sua mano sono sicuramente le
splendide statue di San Girolamo e della Maddalena posti in
una nicchia presso l'ingresso. Le altre statue nelle nicchie ai fianchi
dell'altare si devono a scultori lombardi del seicento (Ercole Ferrara
e Antonio Raggi) mentre i sovrastanti quattro bassorilievi, le storie
di Maria, furono eseguiti a Roma nel 1748. Nella parete sinistra, si trova
la
Visitazione della Madonna a Elisabetta, quadro del marchigiano Carlo
Maratta del tardo seicento, al quale Maratta si ispira anche per il
mosaico della parete opposta evocante la sua Fuga in Egitto.
 Usciti
dalla Cappella del Voto si nota: a destra del primo altare, la statua di
Papa Alessandro III, di
Antonio Raggi, del 1663; a sinistra, quella del Papa Alessandro VII,
di Ercole Ferrara, del 1668, dinnanzi alla quale si trova la pietra
tombale del vescovo senese Carlo Bartoli (morto nel 1444), decorata
da graffiti di Antonio Federighi e Giuliano da Como, su
probabile disegno di Pietro del Minella nel tardo quattrocento.
L'altare antistante la pietra tombale reca una pregevole tela del calabrese
Mattia Preti nel 1650 circa, celebrante una Predicazione di San
Bernardino. Nella cappella angolare, detta del Sacramento, sono murati,
alla parete destra, cinque bassorilievi quattrocenteschi eseguiti da
Giovanni Francesco da Imola (gli Evangelisti) e da Giovanni di
Turino
(San Paolo); l'altare è adornato da una Adorazione dei Pastori,
di Alessandro Casolani nel 1594. Usciti
dalla Cappella del Voto si nota: a destra del primo altare, la statua di
Papa Alessandro III, di
Antonio Raggi, del 1663; a sinistra, quella del Papa Alessandro VII,
di Ercole Ferrara, del 1668, dinnanzi alla quale si trova la pietra
tombale del vescovo senese Carlo Bartoli (morto nel 1444), decorata
da graffiti di Antonio Federighi e Giuliano da Como, su
probabile disegno di Pietro del Minella nel tardo quattrocento.
L'altare antistante la pietra tombale reca una pregevole tela del calabrese
Mattia Preti nel 1650 circa, celebrante una Predicazione di San
Bernardino. Nella cappella angolare, detta del Sacramento, sono murati,
alla parete destra, cinque bassorilievi quattrocenteschi eseguiti da
Giovanni Francesco da Imola (gli Evangelisti) e da Giovanni di
Turino
(San Paolo); l'altare è adornato da una Adorazione dei Pastori,
di Alessandro Casolani nel 1594.
Torna su
Presbiterio e Altare Maggiore
 Per
una tradizione che risale ai tempi paleocristiani, il Presbiterio e
sopraelevato rispetto alle navate. Vi campeggia l'Altare Maggiore
in marmo, mirabile invenzione di
Baldassarre Peruzzi del 1532, messa in opera da Pellegrino Di Pietro.
Sull'altare poggia un dovizioso ciborio in bronzo di Lorenzo di Pietro,
detto il Vecchietta costruito tra il 1467 e il 1472, qui traslato nel
1506 dall'Ospedale di Santa Maria alla Scala, in sostituzione della
Maestà di Duccio da Buoninsegna (che si trova nel Museo
dell'Opera del Duomo). Ai lati, due squisiti Angeli portacandelabri,
di Giovanni Di Stefano; gli altri angeli inferiori sono magistrali
sculture di Francesco di Giorgio Martini eseguiti tre 1497 1499.
Altri otto stupendi angeli, di Domenico Beccafumi eseguiti tre 1548 e
1550, impreziosiscono i pilastri. A lato dell'altare si trova la "Cattedra",
la residenza vescovile disegnata da Bertolomeo Nerori, detto
Riccio, al quale appartengono anche il leggio dietro l'altare e, in
alto, la cantoria di sinistra nel 1550 (come dice il nome, la zona destinata
ai cantori), mentre la cantoria opposta è un lavoro di Antonio Barilli
del 1510. Per
una tradizione che risale ai tempi paleocristiani, il Presbiterio e
sopraelevato rispetto alle navate. Vi campeggia l'Altare Maggiore
in marmo, mirabile invenzione di
Baldassarre Peruzzi del 1532, messa in opera da Pellegrino Di Pietro.
Sull'altare poggia un dovizioso ciborio in bronzo di Lorenzo di Pietro,
detto il Vecchietta costruito tra il 1467 e il 1472, qui traslato nel
1506 dall'Ospedale di Santa Maria alla Scala, in sostituzione della
Maestà di Duccio da Buoninsegna (che si trova nel Museo
dell'Opera del Duomo). Ai lati, due squisiti Angeli portacandelabri,
di Giovanni Di Stefano; gli altri angeli inferiori sono magistrali
sculture di Francesco di Giorgio Martini eseguiti tre 1497 1499.
Altri otto stupendi angeli, di Domenico Beccafumi eseguiti tre 1548 e
1550, impreziosiscono i pilastri. A lato dell'altare si trova la "Cattedra",
la residenza vescovile disegnata da Bertolomeo Nerori, detto
Riccio, al quale appartengono anche il leggio dietro l'altare e, in
alto, la cantoria di sinistra nel 1550 (come dice il nome, la zona destinata
ai cantori), mentre la cantoria opposta è un lavoro di Antonio Barilli
del 1510.
Torna su
Abside
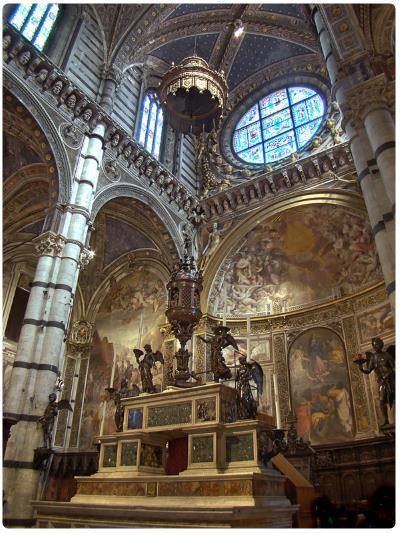 Gli
affreschi di Domenico Beccafumi che ravvivano il catino dell'abside,
per progressivo deperimento, sono stati purtroppo ampiamente ritoccati e
ridipinti (Apostoli del 1544;
Trinità in gloria del 1812); sotto figurano l'Assunzione di Maria,
di Bartolomeo Cesi del 1594, fiancheggiata da due affreschi di Ventura
Salimbeni (Ester e Assuero a destra e gli Ebrei nel deserto
a sinistra) al quale si devono anche le figure dei santi eseguite tra il
1608 il 1611. La vetrata dell'abside, dedicata alla Glorificazione
della Madonna è fra le più antiche dipinte in Italia: ne diede i cartoni
Duccio da Buoninsegna e fu eseguita da maestri senesi nel 1288 e
ripresa quasi un secolo dopo la Giacomo di Castello. Massimo
monumento dell'abside e il Coro in legno che occupa tutta la parte
inferiore del catino absidale. Comprende 51 stalli ed è costituito da
due parti congiunte: quella di mezzo, di impronta rinascimentale, disegnata
sempre dal Riccio ed eseguita da Teseo di Bartolino e Benedetto di
Giovanni tre 1567 1570, e quelle laterali, le più belle, di gusto
gotico, elaborate da Francesco Giacomo del Tonghio tra il 1362 e il
1397, successivamente ingemmate da finissimi intarsi sui dorsali, capolavori
di Giovanni da Verona del 1503, provenienti dall'ex Monastero di
San Benedetto Fuori Porta. Gli
affreschi di Domenico Beccafumi che ravvivano il catino dell'abside,
per progressivo deperimento, sono stati purtroppo ampiamente ritoccati e
ridipinti (Apostoli del 1544;
Trinità in gloria del 1812); sotto figurano l'Assunzione di Maria,
di Bartolomeo Cesi del 1594, fiancheggiata da due affreschi di Ventura
Salimbeni (Ester e Assuero a destra e gli Ebrei nel deserto
a sinistra) al quale si devono anche le figure dei santi eseguite tra il
1608 il 1611. La vetrata dell'abside, dedicata alla Glorificazione
della Madonna è fra le più antiche dipinte in Italia: ne diede i cartoni
Duccio da Buoninsegna e fu eseguita da maestri senesi nel 1288 e
ripresa quasi un secolo dopo la Giacomo di Castello. Massimo
monumento dell'abside e il Coro in legno che occupa tutta la parte
inferiore del catino absidale. Comprende 51 stalli ed è costituito da
due parti congiunte: quella di mezzo, di impronta rinascimentale, disegnata
sempre dal Riccio ed eseguita da Teseo di Bartolino e Benedetto di
Giovanni tre 1567 1570, e quelle laterali, le più belle, di gusto
gotico, elaborate da Francesco Giacomo del Tonghio tra il 1362 e il
1397, successivamente ingemmate da finissimi intarsi sui dorsali, capolavori
di Giovanni da Verona del 1503, provenienti dall'ex Monastero di
San Benedetto Fuori Porta.
Torna su
Sagrestia
 A
sinistra della porta d'ingresso si trova una piccola pila pensile in bronzo
dorato, marmo bianco e smalto, prodigio dell'arte orafa di Giovanni di
Turino del 1437. Fra le molte opere d'arte si possono ammirare: i resti
di affreschi di Domenico di Bartolo
e altri nelle tre cappelle, forse di Nicola di Naldo (cappella a
destra), di
Gualtiero di Giovanni (cappella centrale) e probabilmente di
Benedetto di Bindo (cappella sinistra), tutti del primo quattrocento.
Dalla cappella sinistra si passa al vestibolo (anticamera della
sacrestia) dove troviamo un busto di Alessandro VII, di Melchiorre
Caffà, valido epigono di Lorenzo Bernini. Nella successiva sala
capitolare, alcune pitture di Sano di Pietro che nella
Predicazione di San Bernardino in Piazza del campo, caratterizza
piacevolmente voti costumi e luoghi del tempo. San Bernardino era un grande
comunicatore e predicatore e non a caso è patrono dei pubblicitari. Come
potete vedete un particolare curioso del tempo è la rigida separazione tra
uomini e donne nei luoghi pubblici. A
sinistra della porta d'ingresso si trova una piccola pila pensile in bronzo
dorato, marmo bianco e smalto, prodigio dell'arte orafa di Giovanni di
Turino del 1437. Fra le molte opere d'arte si possono ammirare: i resti
di affreschi di Domenico di Bartolo
e altri nelle tre cappelle, forse di Nicola di Naldo (cappella a
destra), di
Gualtiero di Giovanni (cappella centrale) e probabilmente di
Benedetto di Bindo (cappella sinistra), tutti del primo quattrocento.
Dalla cappella sinistra si passa al vestibolo (anticamera della
sacrestia) dove troviamo un busto di Alessandro VII, di Melchiorre
Caffà, valido epigono di Lorenzo Bernini. Nella successiva sala
capitolare, alcune pitture di Sano di Pietro che nella
Predicazione di San Bernardino in Piazza del campo, caratterizza
piacevolmente voti costumi e luoghi del tempo. San Bernardino era un grande
comunicatore e predicatore e non a caso è patrono dei pubblicitari. Come
potete vedete un particolare curioso del tempo è la rigida separazione tra
uomini e donne nei luoghi pubblici.
Torna su
Transetto sinistro
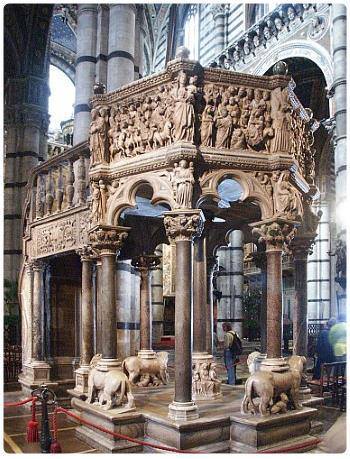 Accostato
ai pilastri della cupola si offre alla nostra ammirazione il famoso
Pulpito di Nicola Pisano, in marmo, di forma ottagonale,
con aiuti alla realizzazione del figlio Giovanni Pisano e di Arnolfo di
Cambio, Duccio di Donato e altri maestri senesi, eseguito tre
1266 1268. Si tratta di un capolavoro assoluto della scultura romanico
gotica o, meglio, di ogni tempo. In esso la serena e classica compostezza di
Nicola Pisano, ancora presente nei primi due pannelli, lascia il posto
al pathos palpitante di Giovanni Pisano. Nei pannelli del parapetto
del pulpito sono scolpiti a bassorilievo eventi e storie evangeliche nel
seguente ordine: 1) Natività e visitazione; 2) Arrivo dei
Magi e adorazione dei Magi; 3) Presentazione di Gesù al tempio,
Sogno di Giuseppe e fuga in Egitto; 4) Strage degli innocenti; 5)
Crocifissione; 6) Giudizio finale dei reprobi; 7) Giudizio
finale degli eletti. Queste Storie sono separate da statue di
Profeti e di Angeli. L'ottavo lato dell'ottagono è occupato dalla
scala di accesso rifatta sul disegno del Riccio. I lati del parapetto
appoggiano su archi trilobi (nei pennacchi, altre Statue di Profeti)
separati a loro volta, da Statue di virtù. Sotto gli archi trilobi si
innalzano le colonnette marmoree di sostegno con capitelli corinzi. Le basi
delle colonnette sono, alternamente, a stilobate (lo stilobate è il piano su
cui appoggia il colonnato) e a leoni e leonesse sbrananti animali
(antichissimo simbolo, questo della Chiesa trionfante sul paganesimo). Il
basamento della colonna centrale è invece sostituito da un gruppo di
bassorilievi con le allegorie delle sette alti liberali e della musica. Accostato
ai pilastri della cupola si offre alla nostra ammirazione il famoso
Pulpito di Nicola Pisano, in marmo, di forma ottagonale,
con aiuti alla realizzazione del figlio Giovanni Pisano e di Arnolfo di
Cambio, Duccio di Donato e altri maestri senesi, eseguito tre
1266 1268. Si tratta di un capolavoro assoluto della scultura romanico
gotica o, meglio, di ogni tempo. In esso la serena e classica compostezza di
Nicola Pisano, ancora presente nei primi due pannelli, lascia il posto
al pathos palpitante di Giovanni Pisano. Nei pannelli del parapetto
del pulpito sono scolpiti a bassorilievo eventi e storie evangeliche nel
seguente ordine: 1) Natività e visitazione; 2) Arrivo dei
Magi e adorazione dei Magi; 3) Presentazione di Gesù al tempio,
Sogno di Giuseppe e fuga in Egitto; 4) Strage degli innocenti; 5)
Crocifissione; 6) Giudizio finale dei reprobi; 7) Giudizio
finale degli eletti. Queste Storie sono separate da statue di
Profeti e di Angeli. L'ottavo lato dell'ottagono è occupato dalla
scala di accesso rifatta sul disegno del Riccio. I lati del parapetto
appoggiano su archi trilobi (nei pennacchi, altre Statue di Profeti)
separati a loro volta, da Statue di virtù. Sotto gli archi trilobi si
innalzano le colonnette marmoree di sostegno con capitelli corinzi. Le basi
delle colonnette sono, alternamente, a stilobate (lo stilobate è il piano su
cui appoggia il colonnato) e a leoni e leonesse sbrananti animali
(antichissimo simbolo, questo della Chiesa trionfante sul paganesimo). Il
basamento della colonna centrale è invece sostituito da un gruppo di
bassorilievi con le allegorie delle sette alti liberali e della musica.
Torna su
Cappella di Sant'Ansano
 La
laterale
Cappella di Sant'Ansano
si trova di fronte a quella del Sacramento. Nell'altare troviamo una tela di
Francesco Vanni, Sant'Ansano che battezza i senesi del 1596.
Alla parete sinistra troviamo il Monumento Sepolcrale del cardinale
Riccardo Petroni, eseguita nel 1317 opera di Tino da Caimaino, il
massimo scultore senese dopo Jacopo della Quercia. Sopra la base
sorretta da mensole, quattro cariatidi sostengono il sarcofago adorno di
rilievi ispirati al Vangelo. Sul sarcofago si trova il cataletto con la
statua del vescovo protetta da un velario sorretto da angeli. Conclude il
solenne monumento, un tabernacolo a cuspide dove appaiono le statue delle
Madonna con Bambino e dei Santi Pietro e Paolo. Altra insigne
lastra tombale in bronzo è quella dedicata al Vescovo Pecci, di
Donatello
e 1426, incastrata nel pavimento e solitamente coperta. La
laterale
Cappella di Sant'Ansano
si trova di fronte a quella del Sacramento. Nell'altare troviamo una tela di
Francesco Vanni, Sant'Ansano che battezza i senesi del 1596.
Alla parete sinistra troviamo il Monumento Sepolcrale del cardinale
Riccardo Petroni, eseguita nel 1317 opera di Tino da Caimaino, il
massimo scultore senese dopo Jacopo della Quercia. Sopra la base
sorretta da mensole, quattro cariatidi sostengono il sarcofago adorno di
rilievi ispirati al Vangelo. Sul sarcofago si trova il cataletto con la
statua del vescovo protetta da un velario sorretto da angeli. Conclude il
solenne monumento, un tabernacolo a cuspide dove appaiono le statue delle
Madonna con Bambino e dei Santi Pietro e Paolo. Altra insigne
lastra tombale in bronzo è quella dedicata al Vescovo Pecci, di
Donatello
e 1426, incastrata nel pavimento e solitamente coperta.
Uscisti dalla Cappella, in posizione simmetrica
rispetto alle statue del braccio opposto al transetto, si trovano le statue
di Pio II, di Giuseppe Mazzuoli del 1698, e di Pio III
di Pietro Balestra nel 1706. Sul pavimento, lastra tombale graffita
del 1468. Seguono due altari: nel secondo si trova un crocifisso in legno
che si ritiene, solo per tradizione appartenuto al Carroccio Senese.
Torna su
Cappella di San Giovanni
Battista
 Proseguendo
ci appare
Cappella di San Giovanni Battista, che viene utilizzata come
Battistero, questa cappella venne realizzata nel 1482 per conservare il
braccio di San Giovanni Battista, la reliquia che Papa Pio II regalò a
Siena. La cappella si presenta in uno stile tipicamente rinascimentale, con
la pianta a cerchio e sovrastata da una cupola. Ideata da Giovanni di
Stefano
nel 1482, preceduta da un portale marmoreo scolpito con prodigiosa finezza
Lorenzo Marrina e fiancheggiato da due ordini di sovrapposte colonne
(le basi, creduto un tempo di età romana sono forse, invece di Antonio
Federighi). Il cancello in ferro battuto è di Sallustio di Francesco
Barili. La cappella e minuzionamente ornata di stucchi di Alberto
Caponeri e di Cosimo Lucchi del 1596 e reca nel centro il
fonte battesimale con rilievi, probabilmente sempre di Antonio Federighi. Di
particolare pregevolezza è tutta l'ornamentazione inferiore della cappella.
Alla sinistra si trova un bel Ritratto di Alberto Aringhieri giovane,
rettore dell'Opera del Duomo, del Pinturicchio; Sant'Ansano,
statua di Giovanni Di Stefano del 1487; Il battista di
Donatello statua mirabile dell'ultima maniera dell'artista;
Decollazione del Battista, del Pinturicchio, rifatta da
Francesco Rustici detto il Rustichino nel 1608; Santa Caterina
di Alessandria, scultura delicatissima di Neroccio di Bartolomeo
nel 1487; Ritratto di Alberto Aringhieri anziano del Pinturicchio.
Fuori dalla Cappella, a destra, in una nicchia, si trova la Statua di
Marcantonio Zonzadari, di Giuseppe e Bartolomeo Mazzuoli del
1725. Proseguendo
ci appare
Cappella di San Giovanni Battista, che viene utilizzata come
Battistero, questa cappella venne realizzata nel 1482 per conservare il
braccio di San Giovanni Battista, la reliquia che Papa Pio II regalò a
Siena. La cappella si presenta in uno stile tipicamente rinascimentale, con
la pianta a cerchio e sovrastata da una cupola. Ideata da Giovanni di
Stefano
nel 1482, preceduta da un portale marmoreo scolpito con prodigiosa finezza
Lorenzo Marrina e fiancheggiato da due ordini di sovrapposte colonne
(le basi, creduto un tempo di età romana sono forse, invece di Antonio
Federighi). Il cancello in ferro battuto è di Sallustio di Francesco
Barili. La cappella e minuzionamente ornata di stucchi di Alberto
Caponeri e di Cosimo Lucchi del 1596 e reca nel centro il
fonte battesimale con rilievi, probabilmente sempre di Antonio Federighi. Di
particolare pregevolezza è tutta l'ornamentazione inferiore della cappella.
Alla sinistra si trova un bel Ritratto di Alberto Aringhieri giovane,
rettore dell'Opera del Duomo, del Pinturicchio; Sant'Ansano,
statua di Giovanni Di Stefano del 1487; Il battista di
Donatello statua mirabile dell'ultima maniera dell'artista;
Decollazione del Battista, del Pinturicchio, rifatta da
Francesco Rustici detto il Rustichino nel 1608; Santa Caterina
di Alessandria, scultura delicatissima di Neroccio di Bartolomeo
nel 1487; Ritratto di Alberto Aringhieri anziano del Pinturicchio.
Fuori dalla Cappella, a destra, in una nicchia, si trova la Statua di
Marcantonio Zonzadari, di Giuseppe e Bartolomeo Mazzuoli del
1725.
Torna su
Navata sinistra e Libreria
Piccolomini
Nella navata sinistra appare subito il
magnifico prospetto della Libreria Piccolomini, costituito da due
arcate marmoree elegantemente lavorate da Lorenzo di Mariano Fucci
detto il Marrina nel 1497. Nell'arcata destra, troviamo un altarino
con configura a bassorilievo di San Giovanni Evangelista di
Giovanni di Stefano. In quella sinistra, che è l'ingresso della
Libreria, si trova il doppio cancello in bronzo di Antonio Ormanni
sempre del 1497. Nel lunettone sopra l'ingresso, troviamo l'Incoronazione
di Pio III
del Pinturicchio.
 La
Libreria Piccolomini fu costruita per volere del cardinale Francesco
Todeschini Piccolomini, poi diventato papa Pio III nel 1495, per
custodirvi la preziosa libreria dello zio il papa Pio II. Per
abbellirla fu chiamato a Siena il Pinturicchio, condiscepolo, alla
scuola del Perugino, di
Raffaello,
il quale, secondo la tradizione di
Vasari, avrebbe dato al
Pinturicchio cartoni e schizzi delle varie composizioni. L'opera eseguita
tra il 1505 il 1507 dal maestro ormai più che cinquantenne (con molti
aiuti), conferma le sue qualità peculiari: ricchezza e vivacità di colori,
gusto per l'eleganza decorativa, piacevolezza di narrazione. Nella sala
rettangolare, pavimentate in magnolia che con lo stemma dei Piccolomini del
1507, i 10 affreschi del Pinturicchio, sono suddivisi da lesene decorate "a
grottesche" (Le grottesche sono un particolare tipo di decorazione pittorica
parietale che affonda le sue radici nella pittura romana di epoca augustea e
che fu riscoperto e reso popolare a partire dalla fine del Quattrocento. In
questo caso sono decorazione che intreccia motivi sfigurati e geometri tanti
e che continua nei pennacchi) che rappresentano, a partire dalla finestra in
fondo a destra: 1)
Il giovane Enea Silvio Piccolomini parte per il Concilio di Basilea; 2)
È ambasciatore del Concilio alla corte del re Giacomo di Scozia; 3)
Riceve la corona d'alloro di poeta dall'imperatore del sacro Romano impero
Federico III; 4) Viene inviato come ambasciatore di Federico III
presso il Papa Eugenio IV; 5) Quale vescovo di Siena presente, a
porta Camogli a, Federico III alla fidanzata Eleonora di Portogallo; 6)
È nominato cardinale del Papa Callisto III; 7) Viene eletto
pontefice con il nome di Pio II; 8) A Mantova esorta il congresso a
intraprendere una crociata contro i turchi; 9) Decreta la
canonizzazione di Santa Caterina di Siena; 10)
Ad Ancona esorta il congresso ad affrettare la partenza per la crociata
(che non si farà mai). La
Libreria Piccolomini fu costruita per volere del cardinale Francesco
Todeschini Piccolomini, poi diventato papa Pio III nel 1495, per
custodirvi la preziosa libreria dello zio il papa Pio II. Per
abbellirla fu chiamato a Siena il Pinturicchio, condiscepolo, alla
scuola del Perugino, di
Raffaello,
il quale, secondo la tradizione di
Vasari, avrebbe dato al
Pinturicchio cartoni e schizzi delle varie composizioni. L'opera eseguita
tra il 1505 il 1507 dal maestro ormai più che cinquantenne (con molti
aiuti), conferma le sue qualità peculiari: ricchezza e vivacità di colori,
gusto per l'eleganza decorativa, piacevolezza di narrazione. Nella sala
rettangolare, pavimentate in magnolia che con lo stemma dei Piccolomini del
1507, i 10 affreschi del Pinturicchio, sono suddivisi da lesene decorate "a
grottesche" (Le grottesche sono un particolare tipo di decorazione pittorica
parietale che affonda le sue radici nella pittura romana di epoca augustea e
che fu riscoperto e reso popolare a partire dalla fine del Quattrocento. In
questo caso sono decorazione che intreccia motivi sfigurati e geometri tanti
e che continua nei pennacchi) che rappresentano, a partire dalla finestra in
fondo a destra: 1)
Il giovane Enea Silvio Piccolomini parte per il Concilio di Basilea; 2)
È ambasciatore del Concilio alla corte del re Giacomo di Scozia; 3)
Riceve la corona d'alloro di poeta dall'imperatore del sacro Romano impero
Federico III; 4) Viene inviato come ambasciatore di Federico III
presso il Papa Eugenio IV; 5) Quale vescovo di Siena presente, a
porta Camogli a, Federico III alla fidanzata Eleonora di Portogallo; 6)
È nominato cardinale del Papa Callisto III; 7) Viene eletto
pontefice con il nome di Pio II; 8) A Mantova esorta il congresso a
intraprendere una crociata contro i turchi; 9) Decreta la
canonizzazione di Santa Caterina di Siena; 10)
Ad Ancona esorta il congresso ad affrettare la partenza per la crociata
(che non si farà mai).
 Ad
alcuni collaboratori di Pinturicchio si devono le pitture di soggetto
mitologico e allegorico della volta, al cui centro si trova lo stemma dei
Piccolomini. Nel centro della libreria, sopra un piedistallo marmoreo
attribuito al Federighi, posano le statue delle Tre Grazie, da
un originale ellenistico, stupenda per la morbida eleganza delle figure
armoniosamente intrecciate. Sui banchi intagliati posti sotto gli affreschi
sono in visione preziosi corali finemente Miniati da famosi artisti
quattrocenteschi quali Liberale da Verona, Girolamo da Cremona,
Sano di Pietro, Guidoccio Cozzarelli, Benvenuto di Giovanni.
Sopra l'ingresso della libreria, la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso,
ottima coppia di uno dei rilievi della Fonte Gaia. Tra le finestre,
statue in bronzo di Cristo risorto, di Fulvio Signorini nel 1595. Ad
alcuni collaboratori di Pinturicchio si devono le pitture di soggetto
mitologico e allegorico della volta, al cui centro si trova lo stemma dei
Piccolomini. Nel centro della libreria, sopra un piedistallo marmoreo
attribuito al Federighi, posano le statue delle Tre Grazie, da
un originale ellenistico, stupenda per la morbida eleganza delle figure
armoniosamente intrecciate. Sui banchi intagliati posti sotto gli affreschi
sono in visione preziosi corali finemente Miniati da famosi artisti
quattrocenteschi quali Liberale da Verona, Girolamo da Cremona,
Sano di Pietro, Guidoccio Cozzarelli, Benvenuto di Giovanni.
Sopra l'ingresso della libreria, la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso,
ottima coppia di uno dei rilievi della Fonte Gaia. Tra le finestre,
statue in bronzo di Cristo risorto, di Fulvio Signorini nel 1595.
Usciti dalla libreria, proseguiamo nella navata
sinistra, dove per il monumento di Bandino Bandini sormontato da un
gruppo scultoreo (Gesù risorto e due angeli) di un maestro
nell'orbita di Michelangelo del 1570 circa e, più avanti l'Altare
Piccolomini, opera dell'estrema maturità del maestro Andrea Bregno
del 1580 di squisita eleganza: è stato nella nicchia (i Santi Gregorio,
Paolo, Pietro e Pio) sono dell'esordiente
Michelangelo eseguiti
tre 1501 al 1504, il quale forse condusse a termine anche il San
Francesco iniziato da Pietro Torrigiani. La statua della nicchia in
alto è attribuita al giovane
Jacopo della Quercia; la tavola incorniciata
dall'ancona in marmo, la Madonna del Latte, è opera di Paolo di
Giovanni Fei del 1381. Seguono tre altari con dipinti di Pietro
Sorri del tardo '500 e Francesco Trevisani del tardo '600
interna. Contro la facciata interna so trova la Statua di papa Marcello
II di Domenico Cafaggi.
Copyright ©
Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque
forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza
autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
Dove si trova?
Torna su
Ostelli Siena
Ostelli Italia
Auberges de Jeunesse Italie
Hotel Siena
Carte de Sienne
Karte von Siena
Mapa Siena
Map of Siena
Carte de la Toscane
Karte von Toskana
Mapa Toscana Map of
Tuscany
Carte d'Italie
Karte von Italien
Mapa Italia
Map of Italy |
