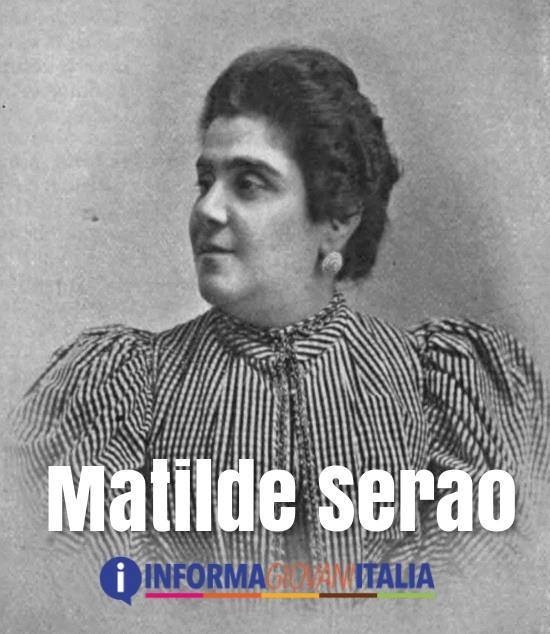|
Sei
qui: Biografie >
Matilde Serao è stata una scrittrice e giornalista italiana, nata a
Patrasso, in Grecia, nel 1856 e morta a Napoli nel 1927. Serao è stata una
delle prime donne a fare carriera come giornalista in Italia e ha fondato
diversi periodici di successo, tra cui il quotidiano "Il Mattino". Come
scrittrice, ha scritto numerosi romanzi, raccolte di racconti e opere
teatrali, tra cui il celebre "Il paese di cuccagna". I suoi scritti spesso
riflettono sulla vita sociale e culturale del suo tempo e hanno influenzato
la letteratura italiana a cavallo fra 800 e 900.
|
Matilde Serao è stata una delle più importanti
giornaliste italiane. Una donna di oltre 100 anni fa, forte e determinata,
che si affermò professionalmente, creando e dirigendo un suo giornale. Simbolo dell’emancipazione femminile,
visse a cavallo tra Ottocento e Novecento, quando alle donne erano negati i basilari diritti civili, come il diritto
al voto. Fu una delle indiscusse protagoniste della vita culturale di
Napoli per oltre 40 anni, giornalista e scrittrice, capace di dipingere con
le sue parole l'anima della sua città e dei suoi abitanti.
|
|
Vita di Matilde
Serao
 Di
padre napoletano e madre greca, la Serao è famosa per aver collezionato numerosi
primati, tra i quali quello appunto di essere stata la prima donna italiana
direttore di un giornale e quello di essere stata
candidata, negli anni '20 del Novecento, 6 volte al
Premio Nobel per la letteratura (senza mai vincerlo).
Con il marito, Edoardo Scarfoglio, aveva fondato
prima il "Corriere di Roma" e poi, a Napoli, "Il
mattino" che ebbe grande successo. Da sola, dopo aver
divorziato da Scarfoglio, sempre a Napoli, fondò il
quotidiano "Il Giorno", che diresse per tutta la
vita. Di
padre napoletano e madre greca, la Serao è famosa per aver collezionato numerosi
primati, tra i quali quello appunto di essere stata la prima donna italiana
direttore di un giornale e quello di essere stata
candidata, negli anni '20 del Novecento, 6 volte al
Premio Nobel per la letteratura (senza mai vincerlo).
Con il marito, Edoardo Scarfoglio, aveva fondato
prima il "Corriere di Roma" e poi, a Napoli, "Il
mattino" che ebbe grande successo. Da sola, dopo aver
divorziato da Scarfoglio, sempre a Napoli, fondò il
quotidiano "Il Giorno", che diresse per tutta la
vita.
Si prodigò per il rinnovamento
dell'editoria italiana della nuova Italia unita e venne accostata
ai grandi della letteratura del tempo come
Luigi Pirandello e
Grazia Deledda.
La Serao è stata una delle figure femminili più
interessanti del periodo, conoscitrice della psicologia collettiva e
individuale, specie femminile, amava rappresentare
passioni, tresche e ambizioni della società borghese e
del mondo politico-giornalistico. Regina dei
salotti letterari e mondani romani e partenopei, è stata per alcuni una
donna amabile e per altri, una donna rozza e volgare, per via di quel suo
linguaggio fin troppo sincero e chiassoso (come viene
riportato in molte sue biografie, non mancava di mettere
in bella mostra la sua figura estroversa, a tratti
comicamente sgraziata e tozza).
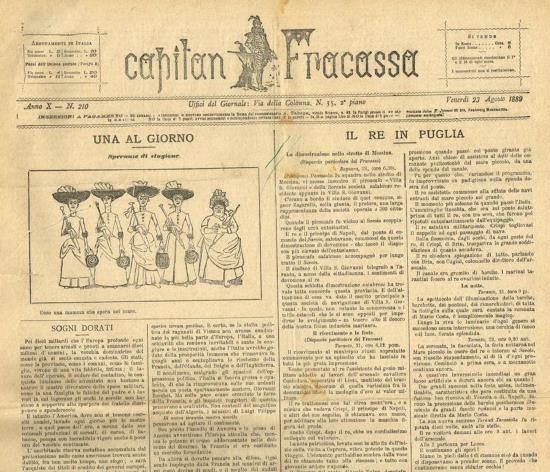 La
città natale di Matilde Serao era Patrasso, in Grecia,
dove nacque il 7 marzo 1856, da padre campano (Francesco Serao,
avvocato e giornalista) originario di Napoli, e costretto a lasciare l'Italia per le sue idee anti-borboniche, e da madre greca (Paolina
Borely), appartenente ad una nobile casata decaduta, donna colta ed
intelligente. Pochi anni dopo la
nascita della bambina, la famiglia si trasferì nuovamente in Campania, prima
nei pressi di
Caserta (per la precisione a Ventaroli, una frazione
di Carinola) e in seguito a
Napoli. Nella città partenopea la piccola Matilde venne
iscritta alla scuola, dove tuttavia non riuscì subito ad imparare a
leggere e a scrivere, e questo nonostante le influenze della famiglia (il
padre giornalista, già aveva ripreso a pieno ritmo a collaborare con alcuni
giornali locali d’ispirazione liberale) e le attenzioni della madre, che la
seguiva con costanza. Si racconta che Matilde fino all’età di otto anni non
sapesse né leggere né scrivere. La
città natale di Matilde Serao era Patrasso, in Grecia,
dove nacque il 7 marzo 1856, da padre campano (Francesco Serao,
avvocato e giornalista) originario di Napoli, e costretto a lasciare l'Italia per le sue idee anti-borboniche, e da madre greca (Paolina
Borely), appartenente ad una nobile casata decaduta, donna colta ed
intelligente. Pochi anni dopo la
nascita della bambina, la famiglia si trasferì nuovamente in Campania, prima
nei pressi di
Caserta (per la precisione a Ventaroli, una frazione
di Carinola) e in seguito a
Napoli. Nella città partenopea la piccola Matilde venne
iscritta alla scuola, dove tuttavia non riuscì subito ad imparare a
leggere e a scrivere, e questo nonostante le influenze della famiglia (il
padre giornalista, già aveva ripreso a pieno ritmo a collaborare con alcuni
giornali locali d’ispirazione liberale) e le attenzioni della madre, che la
seguiva con costanza. Si racconta che Matilde fino all’età di otto anni non
sapesse né leggere né scrivere.
A 16 anni si convertì alla religione cattolica, mentre
prima aveva fede ortodossa, ereditata dalla madre; non
aveva ancora un titolo di studio, che conseguì nel 1874, a 18 anni, alla fine degli studi alla
scuola magistrale. Il diploma di maestra le servì da subito per trovare lavoro;
vinse un concorso come ausiliaria ai Telegrafi di Stato, e
poté aiutare la famiglia, che, da qualche tempo, si
trovava in una difficile situazione economica. Nel tempo
libero iniziò a coltivare il suo interesse per la
letteratura ed il giornalismo.
 Nel frattempo, la
su innata curiosità e lo spirito di
osservazione, rendevano Matilde sempre più interessata alla rappresentazione
della società che la circondava, in particolare alle deplorevoli condizioni
del popolino napoletano e delle lavoro femminile. Grazie anche ai contatti del padre,
Matilde iniziò a pubblicare bozzetti e novelle su
giornali locali con lo pseudonimo di Tuffolina (userà diversi
pseudonimi in tutta la sua carriera). Non paga, e forte della
sua
determinazione nel far valere le proprie doti letterarie, riuscì a
22 anni ad entrare nella redazione del Corriere del Mattino,
inizialmente facendo brevi articoli di appendice. Per lo
stesso giornale pubblicò una prima novella, intitolata "Opale". Nel frattempo, la
su innata curiosità e lo spirito di
osservazione, rendevano Matilde sempre più interessata alla rappresentazione
della società che la circondava, in particolare alle deplorevoli condizioni
del popolino napoletano e delle lavoro femminile. Grazie anche ai contatti del padre,
Matilde iniziò a pubblicare bozzetti e novelle su
giornali locali con lo pseudonimo di Tuffolina (userà diversi
pseudonimi in tutta la sua carriera). Non paga, e forte della
sua
determinazione nel far valere le proprie doti letterarie, riuscì a
22 anni ad entrare nella redazione del Corriere del Mattino,
inizialmente facendo brevi articoli di appendice. Per lo
stesso giornale pubblicò una prima novella, intitolata "Opale".
Il periodo
romano e i salotti letterari
 Animata dalla voglia di affermarsi, a 26 anni, accompagnata
dal padre, si trasferì a
Roma, dove iniziò
a frequentare i più importanti salotti letterari e ad offrire una
cospicua produzione di suoi scritti ai giornali della
città. La sua spontanea fisicità, descritta come un po'
grossolana e rozza, non passò inosservata presso le "damine eleganti" e i frequentatori dei
salotti mondani, tanto che si ritrovò spesso al centro di frivoli
pettegolezzi. D'altra parte la giovane Matilde, caparbia com'era, riuscì a
costruirsi una fama di donna indipendente, suscitando non poca curiosità, e
qualche invidia, da parte delle stesse donne. Animata dalla voglia di affermarsi, a 26 anni, accompagnata
dal padre, si trasferì a
Roma, dove iniziò
a frequentare i più importanti salotti letterari e ad offrire una
cospicua produzione di suoi scritti ai giornali della
città. La sua spontanea fisicità, descritta come un po'
grossolana e rozza, non passò inosservata presso le "damine eleganti" e i frequentatori dei
salotti mondani, tanto che si ritrovò spesso al centro di frivoli
pettegolezzi. D'altra parte la giovane Matilde, caparbia com'era, riuscì a
costruirsi una fama di donna indipendente, suscitando non poca curiosità, e
qualche invidia, da parte delle stesse donne.
Sfavorita dalla sua fisicità, dai modi giudicati troppo
spontanei per l'ambiente salottiero, per la risata
grossa, scrisse:
"Quelle damine eleganti non sanno che io le conosco da
cima a fondo che le metterò nelle mie opere; esse non
hanno coscienza del mio valore, della mia potenza…".
La passione per il giornalismo e la letteratura vinse
contro ogni difficoltà. Matilde iniziò presto a collaborare con gli editori del
"Capitan Fracassa", quotidiano fondato nel 1880 da Raffaello Giovagnoli
e Luigi Arnaldo Vassallo. Più avanti strinse altre
collaborazioni con testate come il
"Fanfulla della Domenica", la
"Nuova Antologia"
e la
"Cronaca bizantina". Le collaborazioni furono possibili
nel contesto di una nuovo e crescente interesse da parte
del pubblico, soprattutto dal 1860, per le notizie riguardanti il nuovo assetto politico
italiano e la situazione economica e
sociale del Paese dopo l'unità. A quel tempo a
Roma affluirono numerosi finanziamenti per la nascita di nuove testate
giornalistiche, soldi che facilitarono la vita degli editori. Il "Capitan Fracassa" era
finanziato dal banchiere
toscano Moisé Bondi, che usava frequentare artisti e
intellettuali presso la birreria Morteo di via del Corso, nel palazzo dove
aveva sede (al piano di sopra) lo stesso giornale. In questo contesto, la
Serao – così come anche altri intellettuali, tra cui D'Annunzio e Carducci –
divenne una delle figure del legame tra giornalismo e mondo letterario.
 Quelli di Roma furono anni molto produttivi per la Serao:
dopo il libro "Dal vero" (1879), nel 1881 pubblicò un libro di racconti intitolato "Leggende Napolitane"; seguirono "Cuore infermo" (1881)
e "Fantasia" (1883), quindi "Fior di passione"(1883),
"Piccole
anime" (1883), "La Virtù di checchina" (1884), sul tentativo
fallito di un'avventura amorosa di una donna borghese,
dove s'indagava il tema dell’arrivismo borghese
che, con il miraggio dei soldi e del lusso, inganna il
vuoto dell’esistenza. Seguirono "La conquista di Roma"
(1885), "Il romanzo della fanciulla" (1886), "Vita e avventure di
Riccardo Ioanna" (1887), che Benedetto Croce definì come "il
romanzo del giornalismo", e quindi "All'erta, sentinella!" (1889).
Tutte queste opere trattavano delle avversità della vita della gente comune
e furono particolarmente apprezzate dalla critica. Quelli di Roma furono anni molto produttivi per la Serao:
dopo il libro "Dal vero" (1879), nel 1881 pubblicò un libro di racconti intitolato "Leggende Napolitane"; seguirono "Cuore infermo" (1881)
e "Fantasia" (1883), quindi "Fior di passione"(1883),
"Piccole
anime" (1883), "La Virtù di checchina" (1884), sul tentativo
fallito di un'avventura amorosa di una donna borghese,
dove s'indagava il tema dell’arrivismo borghese
che, con il miraggio dei soldi e del lusso, inganna il
vuoto dell’esistenza. Seguirono "La conquista di Roma"
(1885), "Il romanzo della fanciulla" (1886), "Vita e avventure di
Riccardo Ioanna" (1887), che Benedetto Croce definì come "il
romanzo del giornalismo", e quindi "All'erta, sentinella!" (1889).
Tutte queste opere trattavano delle avversità della vita della gente comune
e furono particolarmente apprezzate dalla critica.
Il verismo nelle opere di Matilde Serao
 Le opere più acclamate della Serao sono ancora oggi quelle che
aderiscono ad un realismo severo, all'interno dell'allora affermata
corrente letteraria del
Verismo. Si narrano i mali sociali del
sud d'Italia, le differenze di classe, la povertà che diventa sempre più
estrema, la corruzione della politica e delle istituzioni. Tra i suoi
scritti più conosciuti, troviamo "Il ventre di Napoli" (1884),
che racconta del mancato aiuto del governo al popolo napoletano durante lo
scoppio dell'epidemia di colera. In una Napoli caratterizzata dalle
contraddizioni, si descrive una nobiltà privilegiata che
conviveva con il "ventre" della città, costituito dal
suo popolino, uomini, donne, bambini, costretti a vivere
in condizioni di povertà inumana. Nel testo sono
descritte le tristi condizioni di vita, la rassegnazione
fatalistica, l'ignoranza e le superstizioni locali. Il
critico letterari Momigliano definì la Serao: "la più
grande pittrice di folle che abbia dato il nostro
verismo". Le opere più acclamate della Serao sono ancora oggi quelle che
aderiscono ad un realismo severo, all'interno dell'allora affermata
corrente letteraria del
Verismo. Si narrano i mali sociali del
sud d'Italia, le differenze di classe, la povertà che diventa sempre più
estrema, la corruzione della politica e delle istituzioni. Tra i suoi
scritti più conosciuti, troviamo "Il ventre di Napoli" (1884),
che racconta del mancato aiuto del governo al popolo napoletano durante lo
scoppio dell'epidemia di colera. In una Napoli caratterizzata dalle
contraddizioni, si descrive una nobiltà privilegiata che
conviveva con il "ventre" della città, costituito dal
suo popolino, uomini, donne, bambini, costretti a vivere
in condizioni di povertà inumana. Nel testo sono
descritte le tristi condizioni di vita, la rassegnazione
fatalistica, l'ignoranza e le superstizioni locali. Il
critico letterari Momigliano definì la Serao: "la più
grande pittrice di folle che abbia dato il nostro
verismo".
Il connubio
sentimentale e professionale con Scarfoglio
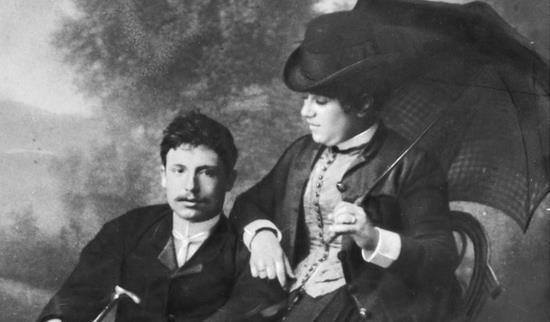 Alla redazione del Capitan Fracassa, Matilde conobbe il suo
futuro sposo, Edoardo Scarfoglio, intellettuale, scrittore e
giornalista. Non fu un incontro molto entusiasmante,
almeno inizialmente: lei ne rimase affascinata sin da
subito, lui ebbe invece a commentare uno dei suoi libri
come "una minestra fatta di tutti gli avanzi di un
banchetto copioso". Non era avvenente Matilde e lo sapeva, ma aveva
dalla sua una forte personalità e sapeva affabulare,
tanto da riuscire ad introdursi in un ambiente del tutto
ostile alle donne. Alla redazione del Capitan Fracassa, Matilde conobbe il suo
futuro sposo, Edoardo Scarfoglio, intellettuale, scrittore e
giornalista. Non fu un incontro molto entusiasmante,
almeno inizialmente: lei ne rimase affascinata sin da
subito, lui ebbe invece a commentare uno dei suoi libri
come "una minestra fatta di tutti gli avanzi di un
banchetto copioso". Non era avvenente Matilde e lo sapeva, ma aveva
dalla sua una forte personalità e sapeva affabulare,
tanto da riuscire ad introdursi in un ambiente del tutto
ostile alle donne.
Nel 1885 i due si sposarono e misero su famiglia. Il
matrimonio fu un vero evento mondano e fu descritto da
Gabriele D’Annunzio su La Tribuna del 3 marzo.
Dall’unione nacquero quattro figli maschi, Antonio,
Carlo, Paolo e Michele, tutti futuri giornalisti.
Nonostante le gravidanze, il lavoro di Matilde non si
interruppe. I due coniugi fondarono un
proprio giornale, "Il Corriere di Roma", definito come
il primo tentativo italiano di creare un quotidiano sul
modello della stampa
parigina. Il giornale però ebbe vita breve, si conquistò un affezionato pubblico,
ma subì la concorrenza del più letto "La Tribuna",
altro quotidiano romano della sinistra storica, molto più diffuso all'epoca.
Il quotidiano dei coniugi Serao-Scarfoglio finì per essere molto indebitato
e cessò le pubblicazioni nel novembre del 1887. Venne successivamente
sostituito da una nuova esperienza giornalistica, questa volta a Napoli,
nata grazie all'aiuto dell'allora proprietario del Corriere del Mattino,
Matteo Schilizzi (che si accollò tutti i debiti del giornale
romano).
Il Corriere di
Napoli, il Mattino e il successo delle cronache mondane
Nel 1888, dall'unione del quotidiano romano e del giornale di
Schilizzi, nacque il "Corriere di Napoli", che da lì a breve sarebbe
diventato uno dei quotidiani di maggior successo del sud
Italia; di particolare apprezzamento fu la rubrica
espressamente curata dalla Serao, intitolata "Api, Mosconi e Vespe", che
trattava sagacemente di cronaca
mondana. Erano articoli di cronaca popolare che rappresentavano la vita
cittadina in modo vivace e disinvolto, capaci di
catturare l'attenzione del lettore. Il pubblico
femminile percepiva la giornalista quasi come una
confidente per le cronache mondane e i pettegolezzi,
inoltre Matilde e si era ritagliata un ruolo anche come
esperta di ricette di cucina e consigliera per le norme
di buona creanza.
Di se stessa, la Serao scrisse:
"Dal primo giorno, io non ho mai voluto né saputo essere
altro che una fedele e umile cronista della mia memoria".
Lasciata successivamente anche questa esperienza,
e non senza una buona uscita (100mila lire dell'epoca), nel 1892 la Serao
fondò con il marito un altro quotidiano, il Mattino, ancora oggi tra
i più diffusi giornali italiani e all'epoca il giornale
più venduto e conosciuto dell'intero Sud Italia.
Lo scandalo e il divorzio
 Il 1892 fu però un periodo abbastanza sfortunato.
Il tradimento del marito con la cantante Gabrielle Bessard, ebbe
tragiche conseguenze: rimasta incinta, l'amante morì suicida, sulla porta di casa dell'uomo
non prima d'aver lasciato la povera
figlioletta in fasce sull'uscio. La notizia fu censurata poco proprio dal giornale di
proprietà della coppia, e venne invece pubblicata su "Il Corriere", suscitando
grande scalpore e risonanza mediatica. La neonata venne da subito
presa in cura da Matilde, che adottò la bambina (dandole perfino il nome
della madre, Paolina) e lasciò definitivamente il marito
dopo poco (Scarfoglio morì a Napoli nel 1917). Il 1892 fu però un periodo abbastanza sfortunato.
Il tradimento del marito con la cantante Gabrielle Bessard, ebbe
tragiche conseguenze: rimasta incinta, l'amante morì suicida, sulla porta di casa dell'uomo
non prima d'aver lasciato la povera
figlioletta in fasce sull'uscio. La notizia fu censurata poco proprio dal giornale di
proprietà della coppia, e venne invece pubblicata su "Il Corriere", suscitando
grande scalpore e risonanza mediatica. La neonata venne da subito
presa in cura da Matilde, che adottò la bambina (dandole perfino il nome
della madre, Paolina) e lasciò definitivamente il marito
dopo poco (Scarfoglio morì a Napoli nel 1917).
Nel frattempo, la sua attività letteraria continuò senza
sosta. Nel 1891 fu pubblicato "Il paese di Cuccagna", uno dei romanzi
più significativi della letteratura veristica italiana. Vi si narrano usi e
costumi del sottoproletariato partenopeo e dei piccoli artigiani, che
affidano tutte le loro speranze alla mitica vincita al Lotto. Napoli è stata
il grande teatro a cielo aperto dove la giornalista attingeva ispirazione,
osservando e narrando i suoi abitanti la Serao ci ha regalato un dipinto
unico dell'epoca, pieno di vita, rappresentando gli aristocratici, surreali
e inadeguati, i borghesi vacui e i popolani, veri e vicini con le loro gioie
e disperazioni, miserie e speranze, furbizie e innocenza.
Del 1890 è "Addio, amore!" (1890), seguirono "Castigo" (1893),
"L'infedele" (1897), "Nel paese di Gesù"
(1898), dai ricordi di un viaggio in Palestina, "La ballerina" (1899),
"Suor Giovanna della Croce" (1900).
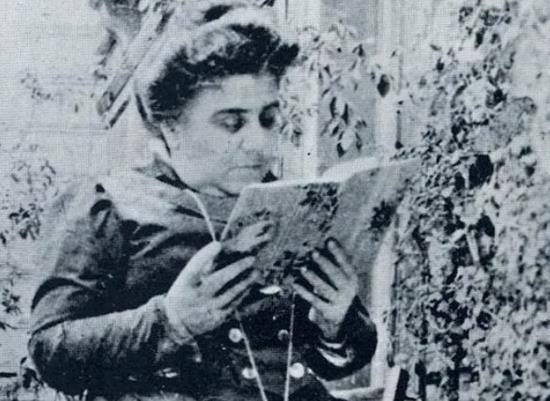 La separazione con Edoardo Scarfoglio avvenne
ufficialmente nel 1902, in concomitanza con la Commissione d'inchiesta
del senatore Saredo su Napoli, che indagava sul risanamento della città
e il presunto malaffare con la camorra dell'allora sindaco. L'inchiesta
coinvolse anche la testata giornalistica del Mattino, lo stesso Scarfoglio,
e indirettamente anche Matilde, che venne additata per scambio di
raccomandazioni per alcune posizioni di lavoro. La separazione con Edoardo Scarfoglio avvenne
ufficialmente nel 1902, in concomitanza con la Commissione d'inchiesta
del senatore Saredo su Napoli, che indagava sul risanamento della città
e il presunto malaffare con la camorra dell'allora sindaco. L'inchiesta
coinvolse anche la testata giornalistica del Mattino, lo stesso Scarfoglio,
e indirettamente anche Matilde, che venne additata per scambio di
raccomandazioni per alcune posizioni di lavoro.
Un giornale
tutto suo e un nuovo compagno
La scrittrice lasciò Il Mattino il 13 novembre del 1902, e dopo vari altri tentativi, infruttuosi,
approdò nel 1904 ad una nuova avventura, quella del "Il Giorno", che
fondò e diresse. Divenne così la prima donna nella storia del
giornalismo italiano a dirigere una testata giornalistica, entrando in concorrenza con
il quotidiano diretto dall'ormai ex
marito.
Nello stesso periodo ebbe inizio il rapporto sentimentale
con il giornalista e avvocato, Giuseppe Natale.
Nel 1917, dopo la morte di Scarfoglio, Matilde lo sposò,
ufficializzando così la loro unione. Da lui ebbe una figlia, all'età di 48
anni, che chiamò Eleonora. Natale l'accompagnò per il resto della vita. Il
nome Eleonora fu dato alla figlia in onore di Eleonora Duse, famosa
attrice e amica di lunga data di Matilde: le due donne furono molto legate, e non
solo Matilde fece da testimone di nozze alla Duse, ma ebbe anche modo di
recensire molti dei suoi spettacoli, così come di esserle consigliera fidata.
Ad esempio la convinse ad accettare il ruolo nel suo primo ed unico
film, nel 1916, tratto dal romanzo di
Grazia Deledda,
"Cenere". A documentare la stretta
amicizia è anche uno scambio epistolare tra le due donne, lettere scritte
tra il 1901 ed il 1924.
Lo stile di Matilde Serao
Le sue
osservazioni la Serao le custodiva gelosamente ed erano le stesse di cui si
cibavano i suoi romanzi, e non poteva essere altrimenti: le sue analisi
venivano trasfigurate nei romanzi magari definiti mondani dalla critica
letteraria del tempo, eppure così potenti da offrire uno
spaccato umano dell'allora società, più credibile di quello di molti altri
intellettuali più famosi. Tanti la criticarono per il suo stile, ma
la sua priorità non era stilistica, bensì quella di comunicare al lettore,
di farlo partecipare, coinvolgerlo, ottenere la sua comprensione della trama
dello spettacolo tragicomico offerto da Napoli.
Per l'epoca fu una scrittrice di best seller, facendo fiorire il genere
della scrittura al femminile, raccontando con la propria penna, i suoi
tempi.
Le donne di Matilde
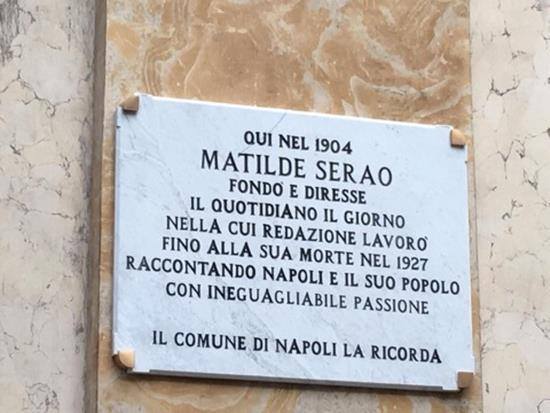 Se
la Serao da una parte è stata elogiata per la vera
rappresentazione della società della sua epoca, e del
ruolo femminile, dall'altra si è spesso sottolineato come non
abbia mai condannato apertamente le divisioni sociali,
la condizione inferiore delle donne, né tanto meno abbia proposto rimedi.
Non volle mai sostenere le battaglie e le esternazioni del
nascente movimento femminista, come quelle a favore del diritto di voto
alle donne e del divorzio. In effetti la Serao è
stata una donna che scriveva di donne ma che non volle
mai essere una femminista, probabilmente per mantenere
l'acquisizione di un ruolo (quello intellettuale) fino
ad allora tipicamente maschile. Se
la Serao da una parte è stata elogiata per la vera
rappresentazione della società della sua epoca, e del
ruolo femminile, dall'altra si è spesso sottolineato come non
abbia mai condannato apertamente le divisioni sociali,
la condizione inferiore delle donne, né tanto meno abbia proposto rimedi.
Non volle mai sostenere le battaglie e le esternazioni del
nascente movimento femminista, come quelle a favore del diritto di voto
alle donne e del divorzio. In effetti la Serao è
stata una donna che scriveva di donne ma che non volle
mai essere una femminista, probabilmente per mantenere
l'acquisizione di un ruolo (quello intellettuale) fino
ad allora tipicamente maschile.
Del ruolo della donna nella società Matilde Serao si dimostrò essere
una delle più fedeli descrittrici e ne furono dimostrazione oltre alle varie
pubblicazioni anche la partecipazione alla rivista bimestrale
"Il Giornale delle Donne", rivista femminile e conformista,
dell'epoca. Descrisse le donne ma non fece dell'emancipazione la sua
causa, semplicemente realizzò la sua emancipazione di donna.
Scrisse di sé:
"conquisto
il mio posto a furia di urti, di gomitate,
col fitto
e ardente desiderio di arrivare,
senza aver
nessuno che mi aiuti o quasi nessuno.
Ma tu sai
che io non do ascolto alle debolezze del mio sesso e tiro avanti per la via
come fossi un giovanotto".
La scrittrice, che aveva ritratto nei suoi romanzi il volto e l’animo di
tante donne, popolane, borghesi, aristocratiche, a nessuna di queste
aveva mai fatto manifestare idee che non fossero conformi alla mentalità
dominante.
Apprezzata è certo la rappresentazione della
verità, della realtà che osservò con cura e acume, che qui vogliamo ricordare in alcuni suoi pensieri, dalla
prefazione a "L'anima semplice. Suor Giovanna della Croce" del 901:
"Esse [le donne] hanno di somigliante una sola cosa, viva e
schietta, ed è il dolore: hanno di somigliante questa crisi dell’anima,
questa crisi così rude, che lacera tutti i veli dell’artificio sociale, che
strappa tutte le leggere parvenze della vita mondana, che dirada tutte le
ipocrisie e che mostra nudo, ferito, sanguinante, il cuore umano della
principessa e della sconosciuta operaia".
Matilde Serao scrisse di tutto, dall’articolo di costume a quello sulla
moda o sull’arredamento, all’articolo di critica letteraria o di stampo
politico, servendosi spesso di pseudonimi per muoversi meglio in un universo
professionale prettamente maschile. Manifestò poca propensione per le idee
femministe che cominciavano a diffondersi, opponendosi alle novità e
all'istituzione del suffragio femminile e del divorzio. Restò un
osservatrice attenta della strenua lotta per la sopravvivenza del popolo e
della condizione femminile, ma scelse di stare lontana dal giornalismo come
forma espressiva e colta delle donne, alla Eleonora Pimentel de Fonseca (che
durante la repubblica napoletana del 1799 aveva fondato il giornale
politico- rivoluzionario, il Monitore Napoletano). Sul ruolo della donna
aveva fatto la sua scelta e non fu quella politica che altre donne, in
quegli anni, avrebbero sperato da lei.
Gli ultimi anni
Non le sono mancate le polemiche nei confronti del suo atteggiamento
verso il fascismo,
nonostante i pezzi antifascisti pubblicati sui suoi giornali. La critica
ha polemizzato sul fatto che nei suoi salotti mondani, la Serao incontrasse lo stesso Benito Mussolini, il quale pur sapendola ostile
al fascismo (“Io sono antifascista? aveva avuto l'ardire di
confessargli, a testa alta), la teneva comunque in buona considerazione,
almeno fino a quando i rapporti tra i due vennero compromessi con la
pubblicazione, la sua ultima in vita, di "Mors tua.... Romanzo in tre
giornate" (1926). Il romanzo fu osteggiato dal regime fascista per il
suo contenuto fortemente critico verso la retorica della guerra, per il
messaggio chiaro che ammonisce: nessuno uscirà indenne dalla guerra, tutti
avranno qualche ferita immedicabile, ognuno dovrà fare i conti con qualcosa
di irrimediabilmente perso. Nello stesso anno perse il Premio Nobel, a
favore di Grazia Deledda, in parte probabilmente anche per l'opposizione del
regime fascista alla sua vittoria.
Nel 1927 la Serao morì a causa di un infarto, che la colpì mentre scriveva.
Aveva 71 anni. Partecipò al suo funerale una marea di gente del popolo. Le sue spoglia riposano nel cimitero di Poggioreale a Napoli.
Giornalismo e marketing
Scrisse ben 26 romanzi, fondò e diresse più di un giornale. Fu una donna
visionaria nel giornalismo come nelle strategie di vendita (creò
addirittura una tessera a punti per l'acquisto del giornale). La giornalista
Miriam Mafai ha scritto che “Tutto il giornalismo italiano è figlio di
Matilde Serao e di Edoardo Scarfoglio?, usando i numeri per spiegare la
sua frase: alla fine del 1800, Matilde e il marito erano riusciti a vendere
ben 30.000 copie del loro giornale, un miracolo editoriale se si pensa che
gli abitanti di Napoli erano circa 500.000 e che il tasso di
alfabetizzazione era solo il 25%. Un giornalismo moderno quello di Matilde
Serao, con pezzi di costume, aforismi, curiosità, temi di cronaca e
polemica capaci di attirare lettori e abbonamenti, un esempio di marketing
inimmaginabile all'epoca.
Gli albori del
cinema
La Serao fu la prima tra gli intellettuali italiani a scrivere di cinema
con un ironico articolo del 1906 e passerà da posizioni critiche verso la
nuova arte a una partecipazione sempre più convinta che si realizza in
articoli di critica cinematografica e in scritture per il cinema con
adattamenti dai suoi romanzi e con sceneggiature. Nella critica
cinematografica in particolare la Serao sperimenta nuovi spazi giornalistici
per la scrittura.
Antologia
critica
Benché Matilde Serao abbia, nel corso della sua carriera, pubblicato
libri divenuti molto popolari, il giudizio critico sulla sua opera è stato a
lungo compromesso dalla severa opinione di Renato Serra (Cesena, 5
dicembre 1884 – Monte Podgora, 20 luglio 1915), autorevole critico
letterario dell'epoca, che la relega più al ruolo (secondario per un
critico) di giornalista che a quello di di romanziera. Parte di questo
giudizio fu condizionato dalla stesura da parte della Serao di piccoli
romanzi mondani.
Benedetto Croce la pensava in modo sulla scrittrice napoletana e le
riconosceva una "fantasia mirabilmente limpida e viva", ma si
ricordano i commenti di anche Pietro Pancrazi, oltre che di Attilio
Momigliano, il quale definì la Serao: «la più grande pittrice di folle
che abbia dato il nostro verismo». Il Premio Nobel Giosuè Carducci la
giudicò "la più forte prosatrice d'Italia", Gabriele D'Annunzio che
nutriva per lei una profonda amicizia le dedicò il romanzo Giovanni
Episcopo (e pubblicò articoli sul Mattino, giornale fondato dalla
Serao insieme al Scarfoglio e fece parte della redazione di Capitan
Fracassa), mentre Paul Bourget scrisse la prefazione alla traduzione
francese de Il paese di cuccagna. Sulla rivista letteriaria "La
revue blanche", fondata a
Liegi nel 1889 da Paul Leclercq e Auguste Jeunehomme,
la Serao scrisse alcuni pezzi al fianco di personalità come Marcel Proust e
Guillaume Apollinaire. Il traduttore francese della Serao era Georges
Herelle, lo stesso che traduceva D'Annunzio.
Uno dei punti deboli della Serao secondo la critica fu l'inclinazione
alle chiacchiere mondane che potevano precipitare verso il pettegolezzo. Le
curiosità sulle vite mondane di Roma e Napoli, spesso fecero deviare il
giudizio di molti sulle sue notevolissime doti giornalistiche e artistiche.
Fa eccezione a tutto questo, anche per la critica, il reportage che diede
vita a Il ventre di Napoli, che mise in luce la realtà dei quartieri
degradati e fatiscenti della città, brulicanti di una umanità incredibile.
La critica letteraria e scrittrice Anna Banti apprezzò la prima parte
della produzione di Serao, considerando minori gli ultimi vent’anni di
attività della scrittrice; stimò la sua capacità di osservatrice, mentre
disapprovò (ancora una volta) le influenze mondano-dannunziane del secondo
periodo.
Opere di Matilde Serao
Opale, Tipografia De Angelis (con lo pseudonimo di Tuffolina), Napoli
1878. (Raccolta di bozzetti poi apparsi in parte nella raccolta "Dal Vero")
Dal vero, Editrice Sociale Perussia e Quadrio, Milano 1879.
Raccolta Minima, Editrice Sociale Perussia e Quadrio, Milano 1881.
Leggende napoletane, Ottino, Milano 1881.
Cuore infermo, Casanova, Torino 1881.
Pagina azzurra, Quadrio, Milano 1883.
Fantasia, Francese Casanova Editore, Torino 1883.
La virtù di Checchina, Giannotta, Catania 1884.
Il ventre di Napoli, Treves, Milano 1884.
La conquista di Roma, Barbera, Firenze 1885.
Il romanzo della fanciulla, Treves, Milano 1886.
Vita e avventure di Riccardo Joanna, Giuseppe Galli Editore, Milano 1887.
L'Italia a Bologna, Treves, Milano 1888.
Fior di passione, Giuseppe Galli Editore, Milano 1888.
All'erta sentinella! Racconti napoletani, Treves, Milano 1889.
Addio amore! Tipografia di Francesco Giannini e Figli, Napoli 1890.
Il paese di cuccagna, Romanzo napoletano, Treves, Milano 1891.
Piccolo romanzo, Pierro, Napoli 1891.
La donna dall'abito nero (Fior di passione), Pierro, Napoli 1892.
Castigo, Francesco Casanova Editore, Torino 1893.
Gli amanti, Treves, Milano 1894.
Le amanti, Treves, Milano 1894.
Beatrice, Pierro, Napoli 1895. (Presente nella raccolta
Sognando
col titolo "La donna ispiratrice")
L'indifferente, Pierro, Napoli 1896.
Donna Paola, Vogherà, Roma 1897.
L'infedele, Editrice Brigola, Milano 1897.
Storia di una monaca, Giannetta, Catania 1898.
Nel Paese di Gesù. Ricordi di un viaggio in Palestina, Tipografia Aurelio
Tocco, Napoli 1899.
La ballerina, Giannetta, Catania 1899.
Come un fiore, Tipografia Salvatore Landi, Firenze 1900.
Fascino Muliebre, Istituto Italiano di Arti Grafiche, Bergamo 1901.
Suor Giovanna della Croce, Treves, Milano 1901.
Lettere d'amore, Giannetta, Catania 1901.
La Madonna e i Santi, Tipografia Angelo Traili, Napoli 1902.
Novelle sentimentali, Belforte, Livorno, 1902.
L'anima dei fiori, Libreria Editrice Nazionale, Milano 1903.
Storia di due anime, Roma 1904.
Santa Teresa, Giannetta, Catania 1904.
L'Italia e Stendhal, Giannetta, Catania 1904.
Saper vivere. Norme di buona creanza, Perrella, Napoli 1905.
Tre donne, Vogherà, Roma 1905.
Sognando, Giannotta, Catania 1906.
La leggenda di Napoli, Perrella, Napoli 1906.
Sterminator Vesevo. Diario dell'eruzione. Aprile 1906, Perrella, Napoli
1906.
Dopo il perdono, Roma 1906.
Dopo il perdono. Dramma in quattro atti, Perrella, Napoli 1908.
Lettere di una viaggiatrice, Perrella, Napoli 1908.
I capelli di Sansone, Perrella, Napoli 1909.
San Gennaro nella leggenda e nella vita, Carabba, Lanciano 1909.
Evviva la vita! Nuova Antologia, Firenze, 1909
La Dernièrefée. Conte pour les enfants, Devambetz, Parigi, 1909.
Il Pellegrino Appassionato, Perrella, Napoli 1911.
Evviva la guerra! Primavera Italica, Perrella, Napoli 1912.
La mano tagliata, Salani, Firenze 1912.
Ella non rispose, Treves, Milano 1914.
Idillio di Pulcinella, Casa Editrice Italiana di A. Quattrini, Firenze 1914.
La leggenda di Napoli, Tipografia Bideri, Napoli 1916.
Piccole Anime, Tipografia Bideri, Napoli 1916.
Parla una donna. Diario femminile di guerra. Maggio 1915-marzo 1916, Treves,
Milano 1916.
Temi il leone, Salani, Firenze 1916.
La vita è così lunga, Treves, Milano 1918.
La moglie di un grand'uomo, Quintieri, Milano 1919.
Ricordando Neera. Conferenza tenuta il 10 maggio 1920 a Milano, Treves,
Milano 1920.
Preghiere, Treves, Milano 1921.
Mors tua... romanzo in tre giornate, Treves, Milano 1926.
Alcuni suoi
romanzi hanno avuto pubblicazione postuma, tra cui "Via delle cinque lune"
(Altro titolo per "Giovannino o la Morte" )
(1941) e "L'occhio di Napoli" (1962).
Copyright ©
Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque
forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza
autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
|