|
Museo di Capodimonte
|
Il Museo di Capodimonte, si
trova nel maestoso palazzo omonimo, una delle maggiori attrazioni di
Napoli, uno dei maggiori musei europei che non ha niente da invidiare ad
istituzioni come il
Prado di
Madrid, il
Louvre o la
National Gallery di Londra, situato sulle alture della città
che offrono tra l'altro il quadro di Napoli e della sua baia. Dal 1743, l'edificio, oggi come
Museo Nazionale, ospita, per espresso volere di
Carlo III di Borbone la collezione d'arte di Elisabetta Farnese
(sua madre). Il re non si fermò al museo, ma per suo volere furono anche
creati i laboratori di Capodimonte, officine di ceramiche artistiche.
|
|
 Tra
gli straordinari capolavori opere di
Raffaello,
Caravaggio,
Pieter Bruegel il Vecchio,
Tiziano (nove sue
opere),
Parmigianino,
Tintoretto, Perugino,
Mantegna,
Velazquez,
Goya,
Van Dyck, Mattia Preti, Luca Giordano,
Annibale
Carracci,
El Greco,
Simone Martini, Taddeo Di Bartolo,
Bernardo Daddi, una Crocefissione del
Masaccio, proveniente dal
Polittico di Pisa (che stava nella Chiesa di Santa
Maria del Carmine nella città toscana) (un'intera sala a lui dedicata),
Masolino,
Botticelli, Luca Signorelli,
Perugino,
Pinturicohio, Lippi, Correggio, il
Giambologna. In più l’esposizione dedicata all’arte
contemporanea (secondo e terzo piano), ospita capolavori
di artisti di fama internazionale, tra cui Andy
Warhol,
Mimmo Jodice, Alberto Burri, Mario Merz, Joseph
Kosuth, Enzo Cucchi, Michelangelo
Pistoletto. Dalle finestre e al terrazzo da cui si
osserva un quadro anch'esso bellissimo, la città con
l'azzurro mare, i Campi Flegrei e le Isole in una
inquadratura che non si dimentica. Tra
gli straordinari capolavori opere di
Raffaello,
Caravaggio,
Pieter Bruegel il Vecchio,
Tiziano (nove sue
opere),
Parmigianino,
Tintoretto, Perugino,
Mantegna,
Velazquez,
Goya,
Van Dyck, Mattia Preti, Luca Giordano,
Annibale
Carracci,
El Greco,
Simone Martini, Taddeo Di Bartolo,
Bernardo Daddi, una Crocefissione del
Masaccio, proveniente dal
Polittico di Pisa (che stava nella Chiesa di Santa
Maria del Carmine nella città toscana) (un'intera sala a lui dedicata),
Masolino,
Botticelli, Luca Signorelli,
Perugino,
Pinturicohio, Lippi, Correggio, il
Giambologna. In più l’esposizione dedicata all’arte
contemporanea (secondo e terzo piano), ospita capolavori
di artisti di fama internazionale, tra cui Andy
Warhol,
Mimmo Jodice, Alberto Burri, Mario Merz, Joseph
Kosuth, Enzo Cucchi, Michelangelo
Pistoletto. Dalle finestre e al terrazzo da cui si
osserva un quadro anch'esso bellissimo, la città con
l'azzurro mare, i Campi Flegrei e le Isole in una
inquadratura che non si dimentica.
Composizione nel tempo della
Collezione Farnese
 Il
nucleo principale delle raccolte conservate nel Museo
di Capodimonte
è costituito dalla straordinaria Collezione Farnese,
composta da opere d'arte provenienti dai palazzi di
famiglia di
Piacenza,
Parma,
color no è
Roma.
La famiglia Farnese originaria di Tuscania e diffusasi
nell'orvietano, a partire dal 1400 divenne molto potente
fino a che le sue vicende si consumarono fra Parma e
Roma. Il primo a elevare la casata a rango superiore fu
il cardinale
Alessandro Farnese vissuto tre 1468 e il 1549. Avviato alla carriera
ecclesiastica a soli 15 anni, a Roma il prelato si
dedicò con passione agli studi umanistici sotto la guida
di Pomponio Leto. Fu tuttavia coinvolto in alcune
vicende politiche che videro contrapporsi la sua
famiglia a Innocenzo VIII (Giovanni Battista
Cybo): preso in ostaggio, fu rinchiuso a
Castel
Sant'Angelo da dove evase il 25 maggio
del 1486. Abbandonata Roma, si rifugiò a
Firenze
sotto la protezione di Lorenzo de' Medici . Nella
città toscana poté assistere anche alle lezioni di
Marsilio Ficino e conoscere Giovanni Pico della
Mirandola e due futuri papi Giovanni e
Giulio de' Medici. Il periodo dell'esilio forzato si
trasformò quindi in un'occasione di incontro con la
celebre Accademia Neoplatonica
sostenuta da Lorenzo il Magnifico. Nel 1490 il mutamento
del quadro politico riportò il cardinale Alessandro
Farnese a Roma. Rimasto unico maschio di casa Farnese,
il prelato, per assicurare la continuità dinastica,
strinse un legame con Silvia Ruffini, vedova
dalla quale ebbe ben quattro figli. Il progetto di
rafforzare il potere della famiglia continuò con maggior
vigore dopo la sua elezione al soglio pontificio con il
nome di Paolo III, il 13 ottobre del 1534. Fu il
papa, tra le altre cose fu acerrimo nemico
dell'imperatore
Carlo V, promotore del
Concilio
di Trento e della Controriforma e
dell'istituzione dell'ordine dei Gesuiti di Ignazio
da Loyola, di cui faceva parte anche il papa
Francesco. Il
nucleo principale delle raccolte conservate nel Museo
di Capodimonte
è costituito dalla straordinaria Collezione Farnese,
composta da opere d'arte provenienti dai palazzi di
famiglia di
Piacenza,
Parma,
color no è
Roma.
La famiglia Farnese originaria di Tuscania e diffusasi
nell'orvietano, a partire dal 1400 divenne molto potente
fino a che le sue vicende si consumarono fra Parma e
Roma. Il primo a elevare la casata a rango superiore fu
il cardinale
Alessandro Farnese vissuto tre 1468 e il 1549. Avviato alla carriera
ecclesiastica a soli 15 anni, a Roma il prelato si
dedicò con passione agli studi umanistici sotto la guida
di Pomponio Leto. Fu tuttavia coinvolto in alcune
vicende politiche che videro contrapporsi la sua
famiglia a Innocenzo VIII (Giovanni Battista
Cybo): preso in ostaggio, fu rinchiuso a
Castel
Sant'Angelo da dove evase il 25 maggio
del 1486. Abbandonata Roma, si rifugiò a
Firenze
sotto la protezione di Lorenzo de' Medici . Nella
città toscana poté assistere anche alle lezioni di
Marsilio Ficino e conoscere Giovanni Pico della
Mirandola e due futuri papi Giovanni e
Giulio de' Medici. Il periodo dell'esilio forzato si
trasformò quindi in un'occasione di incontro con la
celebre Accademia Neoplatonica
sostenuta da Lorenzo il Magnifico. Nel 1490 il mutamento
del quadro politico riportò il cardinale Alessandro
Farnese a Roma. Rimasto unico maschio di casa Farnese,
il prelato, per assicurare la continuità dinastica,
strinse un legame con Silvia Ruffini, vedova
dalla quale ebbe ben quattro figli. Il progetto di
rafforzare il potere della famiglia continuò con maggior
vigore dopo la sua elezione al soglio pontificio con il
nome di Paolo III, il 13 ottobre del 1534. Fu il
papa, tra le altre cose fu acerrimo nemico
dell'imperatore
Carlo V, promotore del
Concilio
di Trento e della Controriforma e
dell'istituzione dell'ordine dei Gesuiti di Ignazio
da Loyola, di cui faceva parte anche il papa
Francesco.
In campo culturale Paolo III mostrò una forte passione per la scultura
antica, tanto da impossessarsi di molti dei pezzi rinvenuti durante i
continui scavi che venivano intrapresi a Roma. Forte della sua autorità, il
pontefice mise insieme una superba raccolta di antichità, l'unica a Roma in
grado di tenere testa a quella del Vaticano (la raccolta oggi è conservata
nel Museo Nazionale Archeologico di Napoli). Alcuni dei pezzi più
importanti di questa collezione provengono dalle Terme di Caracalla,
dove 1545 si scavò per reperire materiale da impiegare nella costruzione
della nuova
Basilica
di San Pietro. Arbitrariamente Paolo III fece trasportare le
sculture nel palazzo di famiglia,
 dove
furono sistemate in parte nel giardino e in parte sotto le le arcate del
cortile. Fino a qui emerge un gusto collezionistico diretto esclusivamente
la scultura antica. In effetti Paolo III si occupò di pittura solo
occasionalmente e l'acquisizione di opere di eccezionale valore fu un fatto
del tutto casuale. A tale proposito è significativo ricordare come il
pontefice riuscì ad ottenere quadri da Tiziano che, in quel periodo,
era il pittore maggiormente conteso dai sovrani più potenti d'Europa.
L'artista si impegnò a rispettare le commissioni ricevute, in prevalenza
ritratti, purché Paolo III affidasse al figlio Pomponio, che al
mestiere del padre aveva preferito la vita ecclesiastica, una prestigiosa
diocesi veneta. Ma il pontefice venne meno al tacito accordo tanto che
Tiziano interruppe ogni rapporto con lui (nella foto potete vedere un
ritratto di Paolo III dell'artista veneziano ospitato nel Museo di
Capodimonte). All'età di ottantun anni la sua salute peggiorò
improvvisamente: un violento alterco con i nipoti Ottavio e
Alessandro riguardante l'annessione del Ducato di Parma e Piacenza gli
causò una grave infermità dalla quale non si risollevò più. dove
furono sistemate in parte nel giardino e in parte sotto le le arcate del
cortile. Fino a qui emerge un gusto collezionistico diretto esclusivamente
la scultura antica. In effetti Paolo III si occupò di pittura solo
occasionalmente e l'acquisizione di opere di eccezionale valore fu un fatto
del tutto casuale. A tale proposito è significativo ricordare come il
pontefice riuscì ad ottenere quadri da Tiziano che, in quel periodo,
era il pittore maggiormente conteso dai sovrani più potenti d'Europa.
L'artista si impegnò a rispettare le commissioni ricevute, in prevalenza
ritratti, purché Paolo III affidasse al figlio Pomponio, che al
mestiere del padre aveva preferito la vita ecclesiastica, una prestigiosa
diocesi veneta. Ma il pontefice venne meno al tacito accordo tanto che
Tiziano interruppe ogni rapporto con lui (nella foto potete vedere un
ritratto di Paolo III dell'artista veneziano ospitato nel Museo di
Capodimonte). All'età di ottantun anni la sua salute peggiorò
improvvisamente: un violento alterco con i nipoti Ottavio e
Alessandro riguardante l'annessione del Ducato di Parma e Piacenza gli
causò una grave infermità dalla quale non si risollevò più.
Alla morte di Paolo III, nel 1549, la fortuna di Farnese a Roma segnò una
momentanea battuta d'arresto. A riportare alla ribalta quel nome furono i
nipoti del pontefice, entrambi cardinali, il già citato Alessandro,
vissuto tra 1520 il 1589 e Ranuccio vissuto tre 1530 e il 1565. Il
primo mostrò grande sensibilità verso l'arte; fu un fervido sostenitore dei
gesuiti che a lui devono la costruzione della loro chiesa più importante,
quella Chiesa del Gesù oggi considerata come una delle più
significative testimonianze del barocco romano.
 Tutti
Farnese a Roma abitarono nella residenza di
Palazzo Farnese, che è oggi sede dell'ambasciata di Francia. Il
palazzo era stato commissionato da Paolo III, ancora
cardinale, ad Antonio da San Gallo il Giovane nel
1514. Alla morte dell'architetto fiorentino i lavori
proseguirono sotto la direzione di
Michelangelo. Della sua decorazione si occupò il cardinale Odoardo
Farnese vissuto tra il 1573 e il 1626, che nel 1594
chiamò a Roma
Annibale Carracci. A partire
dall'anno successivo l'artista bolognese affrescò la
cappella privata con Cristo e la donna di Cana,
il "camerino" e la celebre galleria con scene ispirate
agli Amori degli dei. Il cardinale Odoardo fu
l'ultimo "inquilino" di palazzo Farnese. Negli anni dopo
la sua morte la residenza fu abbandonata e spogliata
degli arredi più preziosi, in parte chiusi nel
guardaroba e in parte spediti a Parma. Le sculture
antiche, forse per la difficoltà a trasportarle,
continuarono ancora per un secolo ad arredare il
giardino e ad essere oggetto di ammirazione degli
stranieri di passaggio a Roma per quello che sarebbe
divenuto il Grand Tour
(vedere a tal proposito il
Viaggio in Italia di Goethe). Tutti
Farnese a Roma abitarono nella residenza di
Palazzo Farnese, che è oggi sede dell'ambasciata di Francia. Il
palazzo era stato commissionato da Paolo III, ancora
cardinale, ad Antonio da San Gallo il Giovane nel
1514. Alla morte dell'architetto fiorentino i lavori
proseguirono sotto la direzione di
Michelangelo. Della sua decorazione si occupò il cardinale Odoardo
Farnese vissuto tra il 1573 e il 1626, che nel 1594
chiamò a Roma
Annibale Carracci. A partire
dall'anno successivo l'artista bolognese affrescò la
cappella privata con Cristo e la donna di Cana,
il "camerino" e la celebre galleria con scene ispirate
agli Amori degli dei. Il cardinale Odoardo fu
l'ultimo "inquilino" di palazzo Farnese. Negli anni dopo
la sua morte la residenza fu abbandonata e spogliata
degli arredi più preziosi, in parte chiusi nel
guardaroba e in parte spediti a Parma. Le sculture
antiche, forse per la difficoltà a trasportarle,
continuarono ancora per un secolo ad arredare il
giardino e ad essere oggetto di ammirazione degli
stranieri di passaggio a Roma per quello che sarebbe
divenuto il Grand Tour
(vedere a tal proposito il
Viaggio in Italia di Goethe).
I Farnese a Parma
 A
seguito delle complesse vicende politiche, nel 1545
Paolo III investì Parma e Piacenza del titolo di ducato
affidandone il governo all'ambizioso figlio
Pier Luigi Farnese (nel ritratto a sinistra sempre dipinto da
Tiziano, ospitato anch'esso a Capodiponte) vissuto tra
1503 e il 1547. Tuttavia, il nuovo duca non fu mai
riconosciuto dall'imperatore Carlo V che anzi
rivendicò i suoi diritti su quel territorio, una
diatriba che si concluse con l'omicidio di Pier Luigi
Farnese (la cosiddetta Congiura di Piacenza,
ordita da Ferrante Gonzaga). La morte del figlio non
scoraggiò Paolo III che tentò di annettere Parma e
Piacenza allo Stato della Chiesa. Ma il pontefice non
poteva prevedere il voltafaccia del figlio di Pier Luigi
e suo nipote Ottavio Farnese (vissuto tre 1524 e
1586) che a sorpresa si alleò con Carlo V, ottenendone
in cambio l'investitura di duca di Parma. A
seguito delle complesse vicende politiche, nel 1545
Paolo III investì Parma e Piacenza del titolo di ducato
affidandone il governo all'ambizioso figlio
Pier Luigi Farnese (nel ritratto a sinistra sempre dipinto da
Tiziano, ospitato anch'esso a Capodiponte) vissuto tra
1503 e il 1547. Tuttavia, il nuovo duca non fu mai
riconosciuto dall'imperatore Carlo V che anzi
rivendicò i suoi diritti su quel territorio, una
diatriba che si concluse con l'omicidio di Pier Luigi
Farnese (la cosiddetta Congiura di Piacenza,
ordita da Ferrante Gonzaga). La morte del figlio non
scoraggiò Paolo III che tentò di annettere Parma e
Piacenza allo Stato della Chiesa. Ma il pontefice non
poteva prevedere il voltafaccia del figlio di Pier Luigi
e suo nipote Ottavio Farnese (vissuto tre 1524 e
1586) che a sorpresa si alleò con Carlo V, ottenendone
in cambio l'investitura di duca di Parma.
 Con
queste vicende inizia la storia di Farnese a Parma. La
città emiliana che tra '500 e '600 ebbe lustro proprio
grazie a questa potente famiglia. Le prime notizie sulla
consistenza della collezione Farnese a Parma risalgono
al tempo di Ranuccio I (vissuto tre 1569 e il 1622);
nell'inventario del 1587 del Palazzo del Giardino
compaiono prezzi di prim'ordine, come la Zingarella
di Correggio è il ritratto di
Galeazzo Sanvitale del Parmigianino. Nel 1612 alla collezione
si aggiunsero altri capolavori, sequestrati agli
sfortunati nobili giustiziati perché rei di aver ordito,
l'anno precedente, un complotto contro Ranuccio I.
L'inventario del 1680 comprende 1095 dipinti, una
selezione dei quali trovò posto in una quadreria
composta da 53 stanze, allestita nel Palazzo del
Giardino. Solo alla fine del Seicento, sotto
Ranuccio II vissuto tre 1630 1694, fu intrapreso
l'allestimento di una galleria nel cinquecentesco
Palazzo della Pilotta, oggi sede della Galleria Nazionale di Parma,
dal quale, tuttavia, i duchi continuarono ad attingere
per l'arredo di altre residenze. Diverse furono invece
le intenzioni di Ranuccio II quando, nel suo delizioso
Palazzo di Colorno situato tra Parma e
Mantova,
fece allestire una "Galleria Ducale", dove la sequenza
dei quadri rispondeva ad un più moderno raziocinio. La
sistemazione di questo straordinario spazio espositivo
fu continuata dagli ultimi discendenti dei Farnese di
Parma,
Francesco I vissuto tre 1694 1727 e Antonio Farnese vissuto
tra 1679 e il 1731, un lavoro vanificato quando il
palazzo fu spogliato per ordine di Carlo di Borbone,
figlio di Elisabetta Farnese (moglie di Filippo IV di
Spagna), ed erede diretto della famiglia che si era
estinta. Con
queste vicende inizia la storia di Farnese a Parma. La
città emiliana che tra '500 e '600 ebbe lustro proprio
grazie a questa potente famiglia. Le prime notizie sulla
consistenza della collezione Farnese a Parma risalgono
al tempo di Ranuccio I (vissuto tre 1569 e il 1622);
nell'inventario del 1587 del Palazzo del Giardino
compaiono prezzi di prim'ordine, come la Zingarella
di Correggio è il ritratto di
Galeazzo Sanvitale del Parmigianino. Nel 1612 alla collezione
si aggiunsero altri capolavori, sequestrati agli
sfortunati nobili giustiziati perché rei di aver ordito,
l'anno precedente, un complotto contro Ranuccio I.
L'inventario del 1680 comprende 1095 dipinti, una
selezione dei quali trovò posto in una quadreria
composta da 53 stanze, allestita nel Palazzo del
Giardino. Solo alla fine del Seicento, sotto
Ranuccio II vissuto tre 1630 1694, fu intrapreso
l'allestimento di una galleria nel cinquecentesco
Palazzo della Pilotta, oggi sede della Galleria Nazionale di Parma,
dal quale, tuttavia, i duchi continuarono ad attingere
per l'arredo di altre residenze. Diverse furono invece
le intenzioni di Ranuccio II quando, nel suo delizioso
Palazzo di Colorno situato tra Parma e
Mantova,
fece allestire una "Galleria Ducale", dove la sequenza
dei quadri rispondeva ad un più moderno raziocinio. La
sistemazione di questo straordinario spazio espositivo
fu continuata dagli ultimi discendenti dei Farnese di
Parma,
Francesco I vissuto tre 1694 1727 e Antonio Farnese vissuto
tra 1679 e il 1731, un lavoro vanificato quando il
palazzo fu spogliato per ordine di Carlo di Borbone,
figlio di Elisabetta Farnese (moglie di Filippo IV di
Spagna), ed erede diretto della famiglia che si era
estinta.
Il trasferimento della collezione
a Napoli
 La
morte di Antonio Farnese, nel 1731, ultimo duca di Parma
e Piacenza, decretò il passaggio di tutti i possedimenti
dei Farnese a Carlo di Borbone, figlio di
Elisabetta Farnese e di Filippo IV di Spagna. Quando nel
1734 il giovane principe salì al trono di Napoli,
dispose che la parte più significativa del patrimonio
artistico fosse trasferita a Napoli e quella di minore
importanza fosse messa all'asta per pagare i creditori
del defunto duca di Parma. Per anni il giovane sovrano
lasciò nell'incuria quasi totale le casse contenenti le
opere d'arte ereditate, tanto da suscitare
l'indignazione dei visitatori stranieri in visita a
palazzo reale. Furono forse queste continue lamentele
che spinsero il sovrano partenopeo, nel dicembre del
1738, ad affidare ad una commissione di esperti la
progettazione di un museo. Dovettero essere costoro a
suggerire la ricostruzione in spazi museali di alcuni
ambienti del piano nobile della nuova Reggia di
Capodimonte che, dal settembre dello stesso anno,
l'architetto palermitano Giovanni Antonio Madrano,
anch'egli componente della citata commissione, stava
costruendo sulla collina di Capodimonte. Nel 1756 il
"Museo Farneseniano" era quasi completo, tanto che il re
Carlo affidò a padre Giovanni Maria della Torre,
in realtà poco esperto d'arte, l'incarico di occuparsi
dell'allestimento. Il fatto che trasferimento della
collezione Farnesiana in galleria cominciò solo nel 1758
indica che i lavori dovevano andare molto a rilento,
probabilmente perché Carlo di Borbone era completamente
assorbito dalle questioni politiche che, dal 1759, lo
condussero ad assumere la corona di Spagna. La
morte di Antonio Farnese, nel 1731, ultimo duca di Parma
e Piacenza, decretò il passaggio di tutti i possedimenti
dei Farnese a Carlo di Borbone, figlio di
Elisabetta Farnese e di Filippo IV di Spagna. Quando nel
1734 il giovane principe salì al trono di Napoli,
dispose che la parte più significativa del patrimonio
artistico fosse trasferita a Napoli e quella di minore
importanza fosse messa all'asta per pagare i creditori
del defunto duca di Parma. Per anni il giovane sovrano
lasciò nell'incuria quasi totale le casse contenenti le
opere d'arte ereditate, tanto da suscitare
l'indignazione dei visitatori stranieri in visita a
palazzo reale. Furono forse queste continue lamentele
che spinsero il sovrano partenopeo, nel dicembre del
1738, ad affidare ad una commissione di esperti la
progettazione di un museo. Dovettero essere costoro a
suggerire la ricostruzione in spazi museali di alcuni
ambienti del piano nobile della nuova Reggia di
Capodimonte che, dal settembre dello stesso anno,
l'architetto palermitano Giovanni Antonio Madrano,
anch'egli componente della citata commissione, stava
costruendo sulla collina di Capodimonte. Nel 1756 il
"Museo Farneseniano" era quasi completo, tanto che il re
Carlo affidò a padre Giovanni Maria della Torre,
in realtà poco esperto d'arte, l'incarico di occuparsi
dell'allestimento. Il fatto che trasferimento della
collezione Farnesiana in galleria cominciò solo nel 1758
indica che i lavori dovevano andare molto a rilento,
probabilmente perché Carlo di Borbone era completamente
assorbito dalle questioni politiche che, dal 1759, lo
condussero ad assumere la corona di Spagna.
La partenza di Carlo di Borbone rallentò ulteriormente i lavori della
residenza perché il nuovo re, Ferdinando IV, seguì con maggiore entusiasmo
la costruzione della Reggia di Caserta. Tuttavia egli chiamò da Roma
l'architetto Ferdinando Fuga, che diresse i lavori di Capodimonte per
un decennio. A lui si deve la realizzazione, nel 1760, di un nuovo blocco
museale collegato con le sale intorno al primo cortile che già ospitavano
parte della collezione Farnese.
Da reggia napoleonica a museo
nazionale
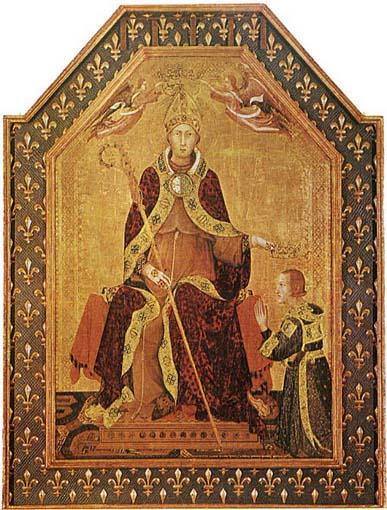 Nel
1799 la Galleria di Capodimonte contava 1783 dipinti. Ma
la dispersione della collezione era ormai prossima. Nel
gennaio del 1799 le truppe francesi entrarono a Napoli
proclamando la Repubblica partenopea. Ferdinando IV
aveva fatto appena in tempo a trasferire nella sua
residenza di
Palermo una
selezione di opere d'arte custodite nel
Palazzo Reale di Portici, ma nulla aveva potuto
per salvaguardare il patrimonio di Capodimonte, dove i
francesi sequestrarono 325 quadri che presero la via di
Roma. Nel 1800, per trattare la restituzione del
maltolto, fu inviato a Roma il direttore della fabbrica
di porcellana borbonica Domenico Venuti. Fu lui
stesso ad occuparsi delle rimpatrio delle opere che,
dietro suo suggerimento, tra il 1801 e il 1805 furono
sistemate nel Palazzo di Francavilla a Chiaia.
A salvare dall'oblio Capodimonte fu Giuseppe
Bonaparte, il fratello di Napoleone, che divenuto re
di Napoli dal 1806 al 1809, elesse il Palazzo di
Capodimonte a principale residenza della corte.
Questa decisione comportò il rimaneggiamento degli
ambienti del totale rinnovo degli arredi. La collezione
Farnese, quindi, fu trasferita a Palazzo degli Studi,
lo stesso luogo che già nel 1778 Ferdinando IV aveva
indicato come sede ideale per il museo. Nel
1799 la Galleria di Capodimonte contava 1783 dipinti. Ma
la dispersione della collezione era ormai prossima. Nel
gennaio del 1799 le truppe francesi entrarono a Napoli
proclamando la Repubblica partenopea. Ferdinando IV
aveva fatto appena in tempo a trasferire nella sua
residenza di
Palermo una
selezione di opere d'arte custodite nel
Palazzo Reale di Portici, ma nulla aveva potuto
per salvaguardare il patrimonio di Capodimonte, dove i
francesi sequestrarono 325 quadri che presero la via di
Roma. Nel 1800, per trattare la restituzione del
maltolto, fu inviato a Roma il direttore della fabbrica
di porcellana borbonica Domenico Venuti. Fu lui
stesso ad occuparsi delle rimpatrio delle opere che,
dietro suo suggerimento, tra il 1801 e il 1805 furono
sistemate nel Palazzo di Francavilla a Chiaia.
A salvare dall'oblio Capodimonte fu Giuseppe
Bonaparte, il fratello di Napoleone, che divenuto re
di Napoli dal 1806 al 1809, elesse il Palazzo di
Capodimonte a principale residenza della corte.
Questa decisione comportò il rimaneggiamento degli
ambienti del totale rinnovo degli arredi. La collezione
Farnese, quindi, fu trasferita a Palazzo degli Studi,
lo stesso luogo che già nel 1778 Ferdinando IV aveva
indicato come sede ideale per il museo.
 Nel
frattempo la ex collezione Borbone andava arricchendosi
delle opere d'arte sacra provenienti dagli enti
ecclesiastici soppressi tre 1806 e il 1815. Queste
acquisizioni aprirono la collezione reale, fino ad
allora composta in prevalenza da dipinti del
Rinascimento e del Seicento veneto ed emiliano, a
significative testimonianze pittoriche napoletane.
Inoltre, sia al tempo di Giuseppe Bonaparte che di
Gioacchino Murat, suo successore al trono dal 1806
al 1815, furono acquistate molte opere di scuola
napoletana, un esperimento questo che servirà molto a
motivare giovani artisti locali che imparavano il
mestiere presso l'Accademia di belle Arti. A questo
contesto va ricondotto il progetto di Gioacchino Murat
di allestire presso il Palazzo degli Studi un museo
interamente dedicato all'arte napoletana, che però
rimase non realizzato a causa dei frenetici avvenimenti
politici che nel giro di pochi anni condussero alla
caduta di Napoleone e, di conseguenza, di tutti i
sovrani da lui imposti. Nel
frattempo la ex collezione Borbone andava arricchendosi
delle opere d'arte sacra provenienti dagli enti
ecclesiastici soppressi tre 1806 e il 1815. Queste
acquisizioni aprirono la collezione reale, fino ad
allora composta in prevalenza da dipinti del
Rinascimento e del Seicento veneto ed emiliano, a
significative testimonianze pittoriche napoletane.
Inoltre, sia al tempo di Giuseppe Bonaparte che di
Gioacchino Murat, suo successore al trono dal 1806
al 1815, furono acquistate molte opere di scuola
napoletana, un esperimento questo che servirà molto a
motivare giovani artisti locali che imparavano il
mestiere presso l'Accademia di belle Arti. A questo
contesto va ricondotto il progetto di Gioacchino Murat
di allestire presso il Palazzo degli Studi un museo
interamente dedicato all'arte napoletana, che però
rimase non realizzato a causa dei frenetici avvenimenti
politici che nel giro di pochi anni condussero alla
caduta di Napoleone e, di conseguenza, di tutti i
sovrani da lui imposti.
 Dopo
la caduta di Gioacchino Murat nel 1815, Ferdinando IV
ritornò a Napoli come primo re del Regno delle Due
Sicilia (Ferdinando I). Affascinato dalle trasformazioni
che i francesi avevano compiuto a Capodimonte, il
Borbone mantenne la medesima residenza reale, lasciando
integro il museo del Palazzo degli Studi che assunse il
nome di Reale Museo Borbonico. Uno dei primi
segnali di ripresa della politica culturale da parte di
Ferdinando I fu il sostegno ai giovani artisti
napoletani, i più promettenti dei quali furono mandati a
Roma a spese del governo. Inoltre, a questi ferventi
anni risale l'acquisto del Museo Borgiano di Velletri,
oggi riunito nel primo piano del museo di Capodimonte,
composto da un'eterogenea collezione messa insieme dal
cardinale Stefano Borgia tra il 1731 al 1804.
Costui, grazie alla sua carica di Segretario della
Congregazione della Propaganda Fide, si era spesso
recato in visita nelle missioni cattoliche sparse per il
mondo, riportando in patria diversi preziosi manufatti.
Nel 1814 gli eredi avevano già avviato delle trattative
con Gioacchino Murat, ma l'affare si concluse solo nel
1817. Oltre a un elevato numero di pezzi di antichità
greche, etrusche e romane, della collezione fanno parte
oggetti d'arte sacra, testimonianze della cultura
islamica, egiziana, copta, medievale, nonché poche
pitture, come il piccolo trittico di Taddeo Gaddi. Dopo
la caduta di Gioacchino Murat nel 1815, Ferdinando IV
ritornò a Napoli come primo re del Regno delle Due
Sicilia (Ferdinando I). Affascinato dalle trasformazioni
che i francesi avevano compiuto a Capodimonte, il
Borbone mantenne la medesima residenza reale, lasciando
integro il museo del Palazzo degli Studi che assunse il
nome di Reale Museo Borbonico. Uno dei primi
segnali di ripresa della politica culturale da parte di
Ferdinando I fu il sostegno ai giovani artisti
napoletani, i più promettenti dei quali furono mandati a
Roma a spese del governo. Inoltre, a questi ferventi
anni risale l'acquisto del Museo Borgiano di Velletri,
oggi riunito nel primo piano del museo di Capodimonte,
composto da un'eterogenea collezione messa insieme dal
cardinale Stefano Borgia tra il 1731 al 1804.
Costui, grazie alla sua carica di Segretario della
Congregazione della Propaganda Fide, si era spesso
recato in visita nelle missioni cattoliche sparse per il
mondo, riportando in patria diversi preziosi manufatti.
Nel 1814 gli eredi avevano già avviato delle trattative
con Gioacchino Murat, ma l'affare si concluse solo nel
1817. Oltre a un elevato numero di pezzi di antichità
greche, etrusche e romane, della collezione fanno parte
oggetti d'arte sacra, testimonianze della cultura
islamica, egiziana, copta, medievale, nonché poche
pitture, come il piccolo trittico di Taddeo Gaddi.
 Nella
metà dell'ottocento, sotto il regno di Ferdinando II, ci
furono altre due importanti acquisizioni: nel 1842 la
raccolta di Domenico Barbaja, impresario del
Teatro San Carlo, chee comprendeva, tra l'altro, la
Sacra conversazione di Palma il Vecchio; nel
1862 la collezione di Alfonso d'Avalos, Marchese
del Vasto e Principe di Pescara, composte in prevalenza
da oggetti d'arte decorativa, come la celebre serie di
arazzi tessuti nel 1525 su cartoni di Bernart van
Orley, oggi al
Louvre,
con storie della Battaglia di Pavia, e di alcune pitture
fra le quali spicca il Sileno ebbro di Jusepe
de Ribera. Nella
metà dell'ottocento, sotto il regno di Ferdinando II, ci
furono altre due importanti acquisizioni: nel 1842 la
raccolta di Domenico Barbaja, impresario del
Teatro San Carlo, chee comprendeva, tra l'altro, la
Sacra conversazione di Palma il Vecchio; nel
1862 la collezione di Alfonso d'Avalos, Marchese
del Vasto e Principe di Pescara, composte in prevalenza
da oggetti d'arte decorativa, come la celebre serie di
arazzi tessuti nel 1525 su cartoni di Bernart van
Orley, oggi al
Louvre,
con storie della Battaglia di Pavia, e di alcune pitture
fra le quali spicca il Sileno ebbro di Jusepe
de Ribera.
 Nel
1860, con l'unità d'Italia, il palazzo di Capodimonte
passò ai Savoia. Sotto i nuovi sovrani il direttore
della Real Casa Annibale Sacco sistemò in alcuni
ambienti del piano nobile la "quadreria moderna",
organizzata avvalendosi anche della consulenza del
pittore Domenico Morelli. Nello stesso piano, nel
1864 trova posto l'Armeria Borbonica, comprendete
anche pezzi farnesiani, nel 1866 il "Salottino di
Porcellana", smontato dal Palazzo Reale di Portici,
e tra il 1878 il 1888 i migliori manufatti della Real
fabbrica di Porcellane di Capodimonte. Tale riordino
delle collezioni non interessò la quadreria Farnese che
fu lasciata nel Real Museo Borbonico di Palazzo degli
Studi, e dopo l'unità d'Italia assunse il nome di Museo
Nazionale (oggi Museo Archeologico). Furono anni
bui per le collezioni del museo, abbandonate sulle scale
e nei magazzini nel disinteresse generale. Per
denunciare tale situazione non mancarono di levarsi voci
autorevoli in campo dell'arte, tanto da indurre il
governo, nel 1904, ad avvalersi della competenza
dell'insigne critico d'arte Adolfo Venturi. Ma i
lavori furono presto abbandonati per mancanza di fondi e
il museo dovette essere chiuso al pubblico. Nel
frattempo il palazzo di Capodimonte divenne per qualche
anno dimora di Vittorio Emanuele III, quindi, nel
1906, passò ai duchi d'Aosta che vi risedettero fino al
1945. Nel
1860, con l'unità d'Italia, il palazzo di Capodimonte
passò ai Savoia. Sotto i nuovi sovrani il direttore
della Real Casa Annibale Sacco sistemò in alcuni
ambienti del piano nobile la "quadreria moderna",
organizzata avvalendosi anche della consulenza del
pittore Domenico Morelli. Nello stesso piano, nel
1864 trova posto l'Armeria Borbonica, comprendete
anche pezzi farnesiani, nel 1866 il "Salottino di
Porcellana", smontato dal Palazzo Reale di Portici,
e tra il 1878 il 1888 i migliori manufatti della Real
fabbrica di Porcellane di Capodimonte. Tale riordino
delle collezioni non interessò la quadreria Farnese che
fu lasciata nel Real Museo Borbonico di Palazzo degli
Studi, e dopo l'unità d'Italia assunse il nome di Museo
Nazionale (oggi Museo Archeologico). Furono anni
bui per le collezioni del museo, abbandonate sulle scale
e nei magazzini nel disinteresse generale. Per
denunciare tale situazione non mancarono di levarsi voci
autorevoli in campo dell'arte, tanto da indurre il
governo, nel 1904, ad avvalersi della competenza
dell'insigne critico d'arte Adolfo Venturi. Ma i
lavori furono presto abbandonati per mancanza di fondi e
il museo dovette essere chiuso al pubblico. Nel
frattempo il palazzo di Capodimonte divenne per qualche
anno dimora di Vittorio Emanuele III, quindi, nel
1906, passò ai duchi d'Aosta che vi risedettero fino al
1945.
Le vicende recenti del museo
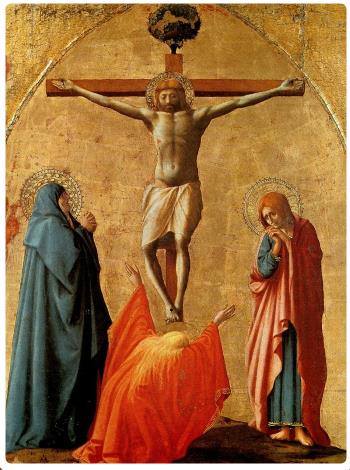 Sicuramente
Napoli è stata la città più penalizzata dall'unità
d'Italia: da grande capitale divenne provincia con gravi
conseguenze per il suo patrimonio artistico. Un
preoccupante disinteresse emerge dalla disinvolta
gestione della contesa fra Napoli e Parma sulla
collezione Farnese. Nel 1921 la città emiliana rivendicò
la restituzione di quei pezzi farnesiani ritenuti
strettamente legati alla propria vicenda culturale. La
contesa si risolse a favore di Parma e Napoli si vide
costretta a restituire grandi capolavori, come il
Ritratto di Ranuccio Farnese del Parmigianino, oggi nella sede della
galleria Nazionale di Parma. Dopo questo saccheggio
legalizzato i musei napoletani per oltre cinquant'anni,
sono stati serbatoio da cui la pubblica amministrazione
attinse per arredare ministeri e ambasciate, uffici
pubblici locali e romani. Sicuramente
Napoli è stata la città più penalizzata dall'unità
d'Italia: da grande capitale divenne provincia con gravi
conseguenze per il suo patrimonio artistico. Un
preoccupante disinteresse emerge dalla disinvolta
gestione della contesa fra Napoli e Parma sulla
collezione Farnese. Nel 1921 la città emiliana rivendicò
la restituzione di quei pezzi farnesiani ritenuti
strettamente legati alla propria vicenda culturale. La
contesa si risolse a favore di Parma e Napoli si vide
costretta a restituire grandi capolavori, come il
Ritratto di Ranuccio Farnese del Parmigianino, oggi nella sede della
galleria Nazionale di Parma. Dopo questo saccheggio
legalizzato i musei napoletani per oltre cinquant'anni,
sono stati serbatoio da cui la pubblica amministrazione
attinse per arredare ministeri e ambasciate, uffici
pubblici locali e romani.
 Durante
la seconda guerra mondiale il patrimonio artistico
napoletano attraversò anni molto difficili. A causa
degli incessanti bombardamenti sulla città, gran parte
delle opere d'arte conservate negli edifici pubblici,
nei musei e nelle chiese fu rimossa per essere posta al
riparo in vari depositi. Molte di tali opere finirono
nell'Abbazia di Montecassino, ma, prima che
questa venisse bombardata, i nazisti avevano già
provveduto alla razzia sia del patrimonio artistico
dell'abbazia che di quello giunto da Napoli. Le casse
erano state spedite a Spoleto, presso la Villa di
Colle Ferretto, dove furono intercettate e riportata
a Roma dagli alleati, appena in tempo prima di
prendessero la strada per la Germania. Alla fine del
conflitto un altro consistente gruppo di capolavori
provenienti dal museo nazionale di Napoli fu ritrovato
nascosto in una cava di sale nei pressi di
Salisburgo. Il
rimpatrio dei dipinti fu risposto solo nel 1947, con
prima sosta a Roma, dove furono messi in mostra, quindi
la definitiva restituzione a Napoli. Durante
la seconda guerra mondiale il patrimonio artistico
napoletano attraversò anni molto difficili. A causa
degli incessanti bombardamenti sulla città, gran parte
delle opere d'arte conservate negli edifici pubblici,
nei musei e nelle chiese fu rimossa per essere posta al
riparo in vari depositi. Molte di tali opere finirono
nell'Abbazia di Montecassino, ma, prima che
questa venisse bombardata, i nazisti avevano già
provveduto alla razzia sia del patrimonio artistico
dell'abbazia che di quello giunto da Napoli. Le casse
erano state spedite a Spoleto, presso la Villa di
Colle Ferretto, dove furono intercettate e riportata
a Roma dagli alleati, appena in tempo prima di
prendessero la strada per la Germania. Alla fine del
conflitto un altro consistente gruppo di capolavori
provenienti dal museo nazionale di Napoli fu ritrovato
nascosto in una cava di sale nei pressi di
Salisburgo. Il
rimpatrio dei dipinti fu risposto solo nel 1947, con
prima sosta a Roma, dove furono messi in mostra, quindi
la definitiva restituzione a Napoli.
 Durante
i lavori della ricostruzione, il soprintendente Bruno
Molajoli si batté, con risultato positivo, affinché
tutta la quadreria reale fosse riunita nel Palazzo di
Capodimonte, che dal 1920 era di proprietà del demanio.
Il passo successivo fu quello del Ministero della
Pubblica Istruzione che nel maggio del 1949 affidò
all'architetto Ezio Bruno de Felice la redazione
del nuovo progetto. Nello stesso tempo il critico d'arte
Ferdinando Bologna si occupò della revisione dei
dipinti. Durante
i lavori della ricostruzione, il soprintendente Bruno
Molajoli si batté, con risultato positivo, affinché
tutta la quadreria reale fosse riunita nel Palazzo di
Capodimonte, che dal 1920 era di proprietà del demanio.
Il passo successivo fu quello del Ministero della
Pubblica Istruzione che nel maggio del 1949 affidò
all'architetto Ezio Bruno de Felice la redazione
del nuovo progetto. Nello stesso tempo il critico d'arte
Ferdinando Bologna si occupò della revisione dei
dipinti.
Dopo cinque anni di lavori, dal 1952 al 1957, il museo di Capodimonte fu
ufficialmente inaugurato il 5 maggio 1957 alla presenza di ministri del
governo italiano e del Presidente della Repubblica Gronchi. Il nuovo
allestimento era così ripartito: al piano nobile le sale storiche mantennero
il loro arredo, mentre nelle 20 stanze del lato occidentale trovò posto la
galleria dell'ottocento; nel mezzanino furono ricavate oltre 50 sale
nelle quali fu sistemata la Pinacoteca.
In anni più recenti il Museo di Capodimonte è stato oggetto di due
riallestimenti: il primo dopo il terribile terremoto del 1980, che
fortunatamente non causò danni strutturali alla reggia, ma che ha comportato
il trasferimento nella Gallerie di molte opere d'arte prelevate dalle chiese
napoletane più danneggiate; nel 1995 riaprì il primo piano, mentre nel 1999
riaprì completamente.
Museo Nazionale di
Capodimonte
Indirizzo: Via Miano, 2, 80137 Napoli
Telefono:081 749 9111
Orari
Aperto tutti i giorni tranne il mercoledì 08:30?
19:30
Costo biglietti
€ 7,50 intero
€ 6,50 dopo le ore 14.00
€ 3,75 ridotto per visitatori di età compresa tra 18 e 24
anni
Gratuito: per minori di anni 18
Infine potete leggere e approfondire prima di partire alcune...guide
di viaggio e libri sul Museo Capodimento di Napoli.
Alcune di queste costano pochi euro, ma con i consigli e il
tempo che fanno risparmiare sono un investimento più che
valido.
Copyright © Informagiovani-italia.com. La
riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con
qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
Dove si trova?
Ostelli Napoli
Ostelli Italia
Auberges de Jeunesse Italie
Hotel Napoli
Carte Naples
Karte von Neaples
Mapa Nápoles
Map of Naples
Carte Campanie
Karte von Kampanien
Mapa Campania Map
of Campania
Carte d'Italie
Karte von Italien
Mapa Italia
Map of Italy |
