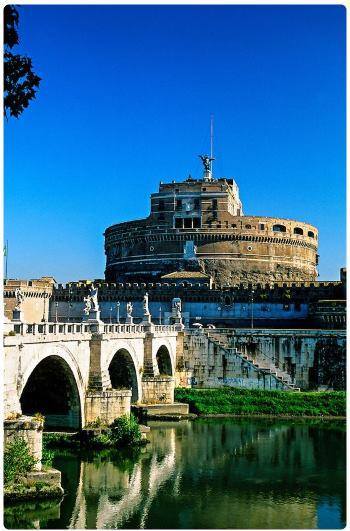|
Castel San'Angelo
|
La fortezza di
Castel Sant'Angelo prende il nome dalla statua dell'arcangelo Michele posta
sulla sua cima. Voluta dall'imperatore Adriano nel 139 d.C. come mausoleo
per se e per i suoi figli, nel 271 d.C venne incorporato nelle Mura aureliane assumendo l'aspetto di un vero avamposto. L'opera originale
era molto diversa da quella che oggi si può vedere. Per opera
dell'imperatore Aureliano ci fu la trasformazione in castello, poi nel XI
secolo fu aggiunta la torre e quando nel 1277 divenne proprietà del
Vaticano, furono aggiunti gli appartamenti pontifici. Inizialmente
la costruzione era stata concepita come mausoleo dell'imperatore
Adriano. |
|
 Si
raggiunge dal Ponte Sant'Angelo, decorato da angeli che vennero
scolpiti da Bernini nel XVII secolo. Venne
trasformato in fortezza per i Papi nel VI secolo, utile in caso di pericolo,
ed è collegato ai palazzi del Vaticano da un passaggio sotterraneo. Il
mausoleo è ora un interessante museo e la sua atmosfera evocativa trae
ancora maggior fascino dal sapere che fu gettandosi da qui che la Tosca di
Puccini trovò la morte. L'Angelo bronzeo del XVIII secolo che da il nome al
castello è protagonista di un'antica leggenda che risale alla terribile peste
del 590. Secondo la storia la peste terminò grazie all'apparizione di un
angelo che si posò sopra il mausoleo e fece il gesto di riporre la spada nel
fodero a simbolo della grazia concessa.
Correva l'anno 590 e Roma era stremata da una terribile epidemia di peste.
Per impetrare la fine del morbo il neo eletto Papa Gregorio Magno (590-604)
chiamò il popolo in processione. Mentre questa si snodava sotto il sepolcro
di Adriano, apparve alla sommità dello stesso l'Arcangelo Michele nell'atto
di rinfoderare la spada come annuncio della fine del flagello, cosa che poi
avvenne. Da questo evento in poi il mausoleo di Adriano prese il nome di Castel Sant'Angelo. Si
raggiunge dal Ponte Sant'Angelo, decorato da angeli che vennero
scolpiti da Bernini nel XVII secolo. Venne
trasformato in fortezza per i Papi nel VI secolo, utile in caso di pericolo,
ed è collegato ai palazzi del Vaticano da un passaggio sotterraneo. Il
mausoleo è ora un interessante museo e la sua atmosfera evocativa trae
ancora maggior fascino dal sapere che fu gettandosi da qui che la Tosca di
Puccini trovò la morte. L'Angelo bronzeo del XVIII secolo che da il nome al
castello è protagonista di un'antica leggenda che risale alla terribile peste
del 590. Secondo la storia la peste terminò grazie all'apparizione di un
angelo che si posò sopra il mausoleo e fece il gesto di riporre la spada nel
fodero a simbolo della grazia concessa.
Correva l'anno 590 e Roma era stremata da una terribile epidemia di peste.
Per impetrare la fine del morbo il neo eletto Papa Gregorio Magno (590-604)
chiamò il popolo in processione. Mentre questa si snodava sotto il sepolcro
di Adriano, apparve alla sommità dello stesso l'Arcangelo Michele nell'atto
di rinfoderare la spada come annuncio della fine del flagello, cosa che poi
avvenne. Da questo evento in poi il mausoleo di Adriano prese il nome di Castel Sant'Angelo.
Nel VI secolo il
mausoleo di Adriano, ormai divenuto fortezza, resistette all'assedio dei
Goti in guerra contro i Bizantini del generale Belisario. Questi, per
respingere gli assedianti, non esitarono a distruggere le statue del
monumento per usarle come proiettili.
Sul finire dello stesso secolo il mausoleo perse anche il suo nome
originario.
 Divenuto ormai la principale roccaforte di Roma, il castello fu, con alterne
vicende, ambita preda di pontefici, famiglie nobiliari (Pierleoni, Orsini,
Borgia) e truppe imperiali.
Nel 1379 venne quasi distrutto dal popolo che si era sollevato contro le
truppe francesi che l'occupavano.
Pochi anni dopo, nel 1395, Bonifacio IX (1389-1404) diede inizio alla sua
ricostruzione, accentuando il carattere militare dell'edificio e progettando
il celebre passetto che costituiva il passaggio protetto per il pontefice
dalla basilica di San Pietro alla fortezza. L'inizio dell'impresa viene
attribuita all'antipapa Giovanni XXIII il 15 giugno 1411. Divenuto ormai la principale roccaforte di Roma, il castello fu, con alterne
vicende, ambita preda di pontefici, famiglie nobiliari (Pierleoni, Orsini,
Borgia) e truppe imperiali.
Nel 1379 venne quasi distrutto dal popolo che si era sollevato contro le
truppe francesi che l'occupavano.
Pochi anni dopo, nel 1395, Bonifacio IX (1389-1404) diede inizio alla sua
ricostruzione, accentuando il carattere militare dell'edificio e progettando
il celebre passetto che costituiva il passaggio protetto per il pontefice
dalla basilica di San Pietro alla fortezza. L'inizio dell'impresa viene
attribuita all'antipapa Giovanni XXIII il 15 giugno 1411.
Nicolò V (1447-1455) fece raggiungere tre bastioni agli angoli del
quadrilatero esterno e due torrette tra il ponte ed il portale d'accesso.
Più tardi, Alessandro VI Borgia incaricò Antonio da Sangallo il Vecchio di ulteriori
lavori di fortificazione. Furono così costruiti quattro torrioni inglobanti
quelli di Nicolò V e chiamati con i nomi dei santi Evangelisti. In
particolare, dal bastione di S. Marco si accede al passetto, in quello di S.
Luca c'era la cappella del Crocifisso o dei condannati. Qui ricevevano gli
ultimi conforti religiosi i condannati a morte prima di essere giustiziati
nell'adiacente cortile delle fucilazioni. La fortezza fu quindi circondata
da un ampio fossato in cui immettere l'acqua del fiume.
Tali opere permisero, 32 anni dopo, a Papa Clemente VII di resistere sette
mesi all'assedio delle truppe di
Carlo V, i famosi Lanzichenecchi, che
diedero inizio, il 5 maggio 1527, al tremendo "sacco di Roma".
L'architetto Giulio Bonatti, su incarico di Urbano VIII, nel 1628, fece
demolire il torrione tra il ponte ed il castello per evitare che ostacolasse
il flusso delle acque del fiume e trasferì sul lato destro il portone
principale.
A Clemente XII (1730-1879) dobbiamo la costruzione dell'ascensore che
portava dall'imbocco della rampa elicoidale alla cappella papale. All'interno
de castello,
dalle celle dei piani inferiori fino agli appartamenti dei papi del
Rinascimento, un museo narra la sua storia. Da non perdere la
Sala Paolina dove vi sono affreschi e trompe d'oeil di Perin del
Vaga e Pellegrino Ribaldi, la vista dalla terrazza e la Scala di Alessandro IV che
attraversa il centro dell'edificio. Gli alloggi
pontifici affacciavano sul cortile d'onore, poi detto dell'Angelo da quando,
nel 1753, vi fu posta la statua marmorea di Raffaello da Montelupo, che si
ergeva dal 1544 sul culmine del castello. Venne sostituita da quella in
bronzo del Verschaffelt, tuttora sul posto.
Gli ambienti del corpo centrale, destinati ai pontefici e più volte
rimaneggiati, comprendono:
1) La sala del camino, così chiamata per il grandioso camino settecentesco.
2) La sala della giustizia, ricavata proprio al di sopra della cella
sepolcrale di Adriano. Vi si svolgeva l'attività giudiziaria durante i
soggiorni papali nel castello.
3) La sala dell'Apollo. Decorata con scene mitologiche, comprende il vano
dell'ascensore papale, del quale ancora si vedono le guide della cabina.
4) la cappella di Leone X, con un pregevole trittico di Taddeo Gaddi del
1336.
5) le due sale di Clemente VII. Costituivano la parte privata
dell'appartamento: lo studio e la camera da letto.
Dalla sala dell'Apollo si passa al cortile del pozzo o del teatro, così
chiamato sia per la presenza del pozzo di Alessandro VI, sia perché sotto
Leone X (1513-1521) vi si svolgevano spettacoli teatrali. Da questo
cortile si accede alla stanza da bagno di Clemente VII, alle prigioni
storiche (che hanno ospitato anche B. Cellini) ed ai magazzini per l'olio e
per il grano.
Attraverso una scaletta si arriva al piano superiore dove, lungo il
corridoio anulare realizzato tra il XVI e il XVII secolo dai Papi Pio IV e
Alessandro VII, si aprono una serie di ambienti contenenti l'armeria
storica.
Continuando il percorso si attraversa la loggia di Paolo III (1534-1549) del
1543, si supera l'appartamento del castellano e si arriva all'ariosa loggia
di Giulio II (1503-1513), attribuita al Sangallo o al Bramante.
Da qui si accede all'appartamento di Paolo III, formato dalla sala Paolina o
del Consiglio, le sale del Perseo e di Amore e Psiche, la sala dell'Adrianeo,
la sala dei Festoni e la biblioteca, che custodiva i documenti dell'archivio
Vaticano.
Infine si trova la sala del Tesoro, sistemata nel vano superiore
dell'originaria mole Adriana, nel punto più inaccessibile: era destinata a
camera blindata per conservare il tesoro Vaticano e i documenti
dell'archivio segreto. Vi si possono ammirare le originarie casse
trecentesche, circondate dagli armadi del '500.
Dalla biblioteca una stretta scala conduce a tre salette dette "la Cagliostra", dal nome di
Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro, che vi fu
tenuto prigioniero nel 1789.
Un'altra scala ricavata nello spessore del muro romano porta alla sommità
del castello ed alla terrazza, dove è posta la campana della misericordia,
che annunciava le esecuzioni capitali.
Qui in origine stava la statua dell'imperatore Adriano su quadriga. Perduta
in circostanze e tempi ignoti, venne sostituita, a partire almeno dal XII
secolo, dalla prima delle tante versioni dell'Angelo. Quella attuale è alta
circa 5 metri e ha un'apertura alare di 6 metri.
Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.
Se questa guida vi è piaciuta e
volete dare una mano a Informagiovani-italia.com aiutateci a
diffonderla.
Dove si trova?
Ostelli
Roma Ostelli Italia
Carte de Rome
Karte von Rom
Mapa Roma
Map of Rome
Carte Latium
Karte von Latium
Mapa Lazio
Map of Lazio
Carte d'Italie
Karte von Italien Mapa Italia Map of Italy |