|
VISITARE
BAGNI DI LUCCA -
INFORMAZIONI E GUIDA.
Incantevole borgo toscano nel cuore della Lunigiana. Immerso tra
storia, natura e tradizioni, Bagnone è la meta ideale per una vacanza
rilassante. Esplora le sue antiche chiese, castelli e sentieri panoramici,
assaporando la rinomata gastronomia locale.
|
Ci
sono tanti luoghi suggestivi e un po' magici persi nello scrigno Italia. Uno
di questi è Bagnone, che si staglia su uno sperone roccioso e che si
estende nell’Alta Lunigiana, un territorio pressoché montuoso, al
confine con l’Emilia-Romagna e poco distante dal limite della Liguria
orientale. Immerso in un fitto bosco di pini e querce, il
paese, sovrastato da una bella rocca, è diviso in ben 20 frazioni, sparse
lungo il torrente Bagnone, affluente del fiume Magra che scorre in direzione
sud verso Licciana. |
|
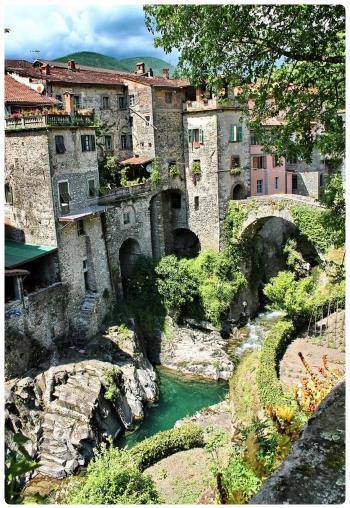 Questa
zona è molto particolare, non è Toscana, né Liguria, né Emilia. È
Lunigiana: una lunga e stretta valle che dal passo della Cisa
arriva giù fino al Tirreno, a
Bocca di Magra, incantevole estuario fra
Carrara
e
La Spezia.
Bizzarro destino, quello di questa terra: marcata da un passato glorioso, e
oggi segnata da un presente opaco, ai margini non soltanto della sviluppo
industriale, ma anche di quei flussi turistici che riempiono le spiagge
della Versilia e arrivano fino ai contrafforti montani di
Lucca
e della Lucchesia. Nel Medioevo e in epoche anche più recenti,
Bagnone ebbe una grande importanza grazie alla posizione strategica,
essendo all’incrocio di vie di comunicazione importanti. Questo è
testimoniato da numerosi luoghi d’interesse artistico come il Castello di
Bagnone e la sua Chiesa, la
Chiesa di San Rocco e la Chiesa di Santa Maria, la
piazza del centro. Tra le frazioni troviamo il bellissimo borgo di
Castiglion del Terziere con il castello,
Treschietto e Iera con gli antichi ruderi dei manieri
dei Malaspina, poi Corlaga e Corvarola. Una zona tutta da
scoprire. Questa
zona è molto particolare, non è Toscana, né Liguria, né Emilia. È
Lunigiana: una lunga e stretta valle che dal passo della Cisa
arriva giù fino al Tirreno, a
Bocca di Magra, incantevole estuario fra
Carrara
e
La Spezia.
Bizzarro destino, quello di questa terra: marcata da un passato glorioso, e
oggi segnata da un presente opaco, ai margini non soltanto della sviluppo
industriale, ma anche di quei flussi turistici che riempiono le spiagge
della Versilia e arrivano fino ai contrafforti montani di
Lucca
e della Lucchesia. Nel Medioevo e in epoche anche più recenti,
Bagnone ebbe una grande importanza grazie alla posizione strategica,
essendo all’incrocio di vie di comunicazione importanti. Questo è
testimoniato da numerosi luoghi d’interesse artistico come il Castello di
Bagnone e la sua Chiesa, la
Chiesa di San Rocco e la Chiesa di Santa Maria, la
piazza del centro. Tra le frazioni troviamo il bellissimo borgo di
Castiglion del Terziere con il castello,
Treschietto e Iera con gli antichi ruderi dei manieri
dei Malaspina, poi Corlaga e Corvarola. Una zona tutta da
scoprire.
 Percorsa
dall'autostrada della Cisa, la Lunigiana viene sempre frettolosamente
attraversata e, purtroppo, raramente visitata. Eppure possiede tutto il
meglio che una terra può offrire, proprio perché in parte dimenticata,
raccolta in se stessa (nei suoi castelli, nei suoi fiumi, nei suoi boschi) e
arrivata nella nostra epoca quasi intatta. Passando dal suo antico passato,
dal medioevo, ha perforato il tempo, indifferente alle trasformazioni, alle
accelerazioni di una civiltà che altrove consuma e divora. Forse questo
stretto lembo di terra, oggi ascritto alla provincia di Massa-Carrara,
risultava poco accessibile, anche ai cambiamenti: troppo difficile accedere
alle sue anguste valli laterali, troppo remote le sue origini, e aspra,
fiera, crudele, anche ostile, la sua storia. Percorsa
dall'autostrada della Cisa, la Lunigiana viene sempre frettolosamente
attraversata e, purtroppo, raramente visitata. Eppure possiede tutto il
meglio che una terra può offrire, proprio perché in parte dimenticata,
raccolta in se stessa (nei suoi castelli, nei suoi fiumi, nei suoi boschi) e
arrivata nella nostra epoca quasi intatta. Passando dal suo antico passato,
dal medioevo, ha perforato il tempo, indifferente alle trasformazioni, alle
accelerazioni di una civiltà che altrove consuma e divora. Forse questo
stretto lembo di terra, oggi ascritto alla provincia di Massa-Carrara,
risultava poco accessibile, anche ai cambiamenti: troppo difficile accedere
alle sue anguste valli laterali, troppo remote le sue origini, e aspra,
fiera, crudele, anche ostile, la sua storia.
 Sono
cariche di mistero le testimonianze dei più antichi abitanti della
Lunigiana: le millenarie statue-stelle, enigmatici spettri di pietra, idoli,
probabilmente, legati ai culti dei liguri-apuani. Di Luni, l'antica
città romana, che ha dato nome alla zona, la Lunigiana appunto, restano
tracce di un importante anfiteatro e altri reperti archeologici, ma il
territorio ha perso l'impronta dell'antico impero. In Lunigiana parla,
cupamente, la voce del Medioevo, di quello più antico e dell'altro
che si affaccia al
Rinascimento. Sono
cariche di mistero le testimonianze dei più antichi abitanti della
Lunigiana: le millenarie statue-stelle, enigmatici spettri di pietra, idoli,
probabilmente, legati ai culti dei liguri-apuani. Di Luni, l'antica
città romana, che ha dato nome alla zona, la Lunigiana appunto, restano
tracce di un importante anfiteatro e altri reperti archeologici, ma il
territorio ha perso l'impronta dell'antico impero. In Lunigiana parla,
cupamente, la voce del Medioevo, di quello più antico e dell'altro
che si affaccia al
Rinascimento.
Non può essere un caso se lungo
i circa 60 chilometri che costeggiano il fiume Magra si susseguono decine
di castelli.
Era troppo importante, nel passato, questo tratto della strada Romea
(che univa la pianura padana al Tirreno) per non difenderlo anche con
fortificazioni imprendibili, se non per fame.
Bagnone è uno degli
oltre 60 castelli della Lunigiana. Oggi è un borgo nettamente distinto in
due nuclei. In alto, sulla sommità di un ripido colle, la rocca; in
basso, il paese vero e proprio affacciato sull'impetuoso torrente che
da il nome alla valle e al paese. Oltre alla storia, qui, protagonista è il
paesaggio: il rigoglio di una natura ancora poco domata e forse indomabile
per l'asprezza repentina dei colli, che rende difficili insediamenti e
spesso del tutto inutili i disboscamenti.
 Bagnone
spunta da una foresta di lecci, pini, quercioli, cerri, arroccata su uno
sperone di roccia in fondo al quale scorre un corso d'acqua, limpido e
tortuoso. Era l'acqua la ricchezza antica del paese; è l'acqua una delle
ricchezze spettacolari di oggi. Più in su, verso l'alta valle, si trovano
ancora i resti dei numerosi mulini che fino a non molto tempo fa
continuavano a macinare; n basso, l'acqua cade in un percorso di roccia
chiara, allargandosi in vaste piscine, perfette per un bagno estivo. Le
fronde, i boschi d'alberi e muschi dappertutto circondano le case ed emanano
un profumo di verde che sa di tempi perduti e purezza. Dal torrente bisogna
guardare verso l'alto per scorgere il nucleo più antico del paese: il
castello, posto in posizione strategica in cima a una ripida collinetta.
Lo si raggiunge a piedi percorrendo un viottolo, oppure, più comodamente, in
automobile. Domina la rocca un imponente torrione cilindrico, una
specie di larga ciminiera che fa da sentinella simbolica della memoria
storica. È il pezzo più antico di questa costruzione che via via è stata
modificata in villa, con interventi ottocenteschi e con l'aggiunta di un
porticato, addirittura novecentesco. Bagnone
spunta da una foresta di lecci, pini, quercioli, cerri, arroccata su uno
sperone di roccia in fondo al quale scorre un corso d'acqua, limpido e
tortuoso. Era l'acqua la ricchezza antica del paese; è l'acqua una delle
ricchezze spettacolari di oggi. Più in su, verso l'alta valle, si trovano
ancora i resti dei numerosi mulini che fino a non molto tempo fa
continuavano a macinare; n basso, l'acqua cade in un percorso di roccia
chiara, allargandosi in vaste piscine, perfette per un bagno estivo. Le
fronde, i boschi d'alberi e muschi dappertutto circondano le case ed emanano
un profumo di verde che sa di tempi perduti e purezza. Dal torrente bisogna
guardare verso l'alto per scorgere il nucleo più antico del paese: il
castello, posto in posizione strategica in cima a una ripida collinetta.
Lo si raggiunge a piedi percorrendo un viottolo, oppure, più comodamente, in
automobile. Domina la rocca un imponente torrione cilindrico, una
specie di larga ciminiera che fa da sentinella simbolica della memoria
storica. È il pezzo più antico di questa costruzione che via via è stata
modificata in villa, con interventi ottocenteschi e con l'aggiunta di un
porticato, addirittura novecentesco.
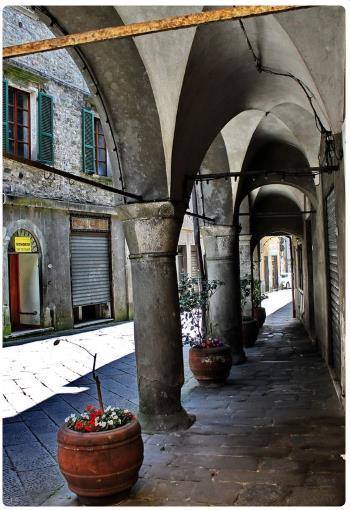 La
cifra propria di Bagnone non sta scritta nel perimetro del suo castello, ma
negli stretti gironi delle case che gli si sono addossate e nei possenti
portici dell'altra parte del paese, quella bassa, che cade in una ripida
discesa verso il fiume. Muri storti, colonne diverse l'una dall'altra,
archi imprecisi, agili ponti gettati a schiena d'asino dal porticato
centrale alla macchia circostante, sono il frutto di un'architettura
dettata dal bisogno, quasi spontanea, nell'uso eterogeneo dei materiali,
nelle geometrie impreviste, nei vistosi compromessi che la natura del luogo
ha dovuto imporre ai progetti. La
cifra propria di Bagnone non sta scritta nel perimetro del suo castello, ma
negli stretti gironi delle case che gli si sono addossate e nei possenti
portici dell'altra parte del paese, quella bassa, che cade in una ripida
discesa verso il fiume. Muri storti, colonne diverse l'una dall'altra,
archi imprecisi, agili ponti gettati a schiena d'asino dal porticato
centrale alla macchia circostante, sono il frutto di un'architettura
dettata dal bisogno, quasi spontanea, nell'uso eterogeneo dei materiali,
nelle geometrie impreviste, nei vistosi compromessi che la natura del luogo
ha dovuto imporre ai progetti.
È sempre difficile stabilire
l'esatta data di nascita di un paese: una delle prime notizie documentate di
Bagnone è contenuta in una bolla papale del 1124. Si riferisce con tutta
probabilità al castello attorno a cui si andava componendo il nucleo
abitato; anche se il feudo vero e proprio fu costruito nel 1351. Nei secoli
successivi, il villaggio si sviluppò in virtù della sua felice posizione a
fondovalle, diventando un centro di raccolta e scambio. Ma la sua vocazione
fu principalmente feudale, nel segno di quello stemma familiare che domina
ancora incontrastato, in tutta la regione: i Malaspina, famiglia
nobile che abbiamo già incontrato nei nostri articoli su
Massa e
Fosdinovo.
Manieri, castelli, borghi della Lunigiana: tutti portano inciso nell'origine
il simbolo della spina secca o fiorita, a seconda dei due rami nei quali la
famiglia si divise il territorio, al di qua e al di là del Magra.
Diversamente da altre dinastie, i Malaspina non attuarono il
maggiorascato, e cioè la linea ereditaria che prevedeva il lascito
dell'intero feudo al figlio primogenito. Preferirono dividere secondo
giustizia fra tutti i figli. Il risultato fu una proliferazione di castelli
e di poteri, di alleanze e di scontri tra fratelli e cugini. Il paesaggio
s'arricchì allora di costruzioni militari. Non c'era valico o strettoia che
non fosse dominato da un maniero: segno inequivocabile che da lì non si
passava senza aver pagato un pedaggio al signore del luogo. D'altra parte,
dichiara Obizzo Malaspina di Villafranca nel 1167 all'imperatore
Federico Barbarossa, "in paesi che nulla producono diventa necessità
vivere di furto".
 Le
valli "incolte e fiere", ricoperte da una macchia ancora oggi fitta e spesso
impenetrabile, rendevano facili gli agguati lungo una strada che era fra le
più praticate dell'antichità. Il medioevo a Bagnone,
Castiglion del Terziere,
Treschietto,
Fosdinovo, Castevoli, Tresana evoca
atmosfere fosche e pericolose. In queste valli, veramente, la storia pare
scritta nel paesaggio. Una storia fatta non solo di lotte politiche fra i
Malaspina e il comune di Lucca, la Repubblica di
Firenze,
il
vescovo di Luni, ma fatta anche di razzie e violenze quotidiane, di
affrancamenti impossibili da una vita consumata nel buio di un Appennino più
povero e più magro che altrove. Una storia segnata anche dalla difficile
convivenza del dominio della potente dinastia dei Malaspina, frammentata con
intento di giustizia ma sofferente per le tante divisioni. Razza guerriera e
predona, i Malaspina, che provenivano dall'antico ceppo longobardo degli
Orbetenghi, resistettero a lungo nei loro territori anche per la
mancanza di un forte contropotere locale. Non bastavano il vescovo di Luni,
centro ormai in decadenza, né il comune di Pontremoli a frenare la
politica da accerchiamento della potente famiglia e dei consorzi ad essa
collegati. Le
valli "incolte e fiere", ricoperte da una macchia ancora oggi fitta e spesso
impenetrabile, rendevano facili gli agguati lungo una strada che era fra le
più praticate dell'antichità. Il medioevo a Bagnone,
Castiglion del Terziere,
Treschietto,
Fosdinovo, Castevoli, Tresana evoca
atmosfere fosche e pericolose. In queste valli, veramente, la storia pare
scritta nel paesaggio. Una storia fatta non solo di lotte politiche fra i
Malaspina e il comune di Lucca, la Repubblica di
Firenze,
il
vescovo di Luni, ma fatta anche di razzie e violenze quotidiane, di
affrancamenti impossibili da una vita consumata nel buio di un Appennino più
povero e più magro che altrove. Una storia segnata anche dalla difficile
convivenza del dominio della potente dinastia dei Malaspina, frammentata con
intento di giustizia ma sofferente per le tante divisioni. Razza guerriera e
predona, i Malaspina, che provenivano dall'antico ceppo longobardo degli
Orbetenghi, resistettero a lungo nei loro territori anche per la
mancanza di un forte contropotere locale. Non bastavano il vescovo di Luni,
centro ormai in decadenza, né il comune di Pontremoli a frenare la
politica da accerchiamento della potente famiglia e dei consorzi ad essa
collegati.
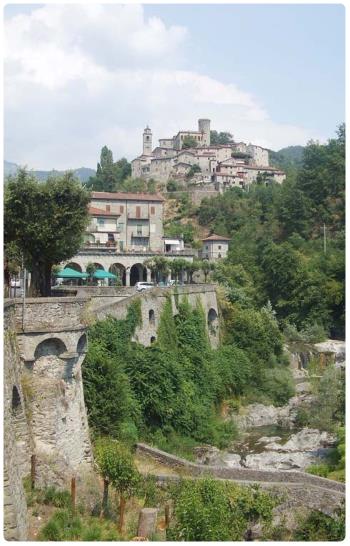 Uno
dei tratti che distingue la storia della Lunigiana, da quella di gran parte
dell'Italia, sta nella mancanza di un grande centro urbano. Il feudalesimo,
qui, non trovando sulla sua strada le nuove formazioni dei comuni, durò più
che altrove. Ma il passo della Cisa, che univa
Parma e
Modena
al Tirreno, la pianura alla costa, era troppo importante.
Rappresentava la via più breve per gli eserciti del Nord, il passaggio
obbligatorio per i prodotti e le mercanzie della Padania.
Milano,
Lucca,
Genova,
Firenze al momento della loro massima potenza, non potevano tollerare
l'assoluto dominio di una famiglia contro le esigenze delle città-stato. Nel
1471 la Repubblica Fiorentina, che vent'anni prima aveva alloggiato i suoi
capitani nel vicino e imponente maniero di Castiglion del Terziere, occupò
borgo e castello di Bagnone. Entrati a Bagnone, i fiorentini imprigionarono
Cristiano Malaspina
annettendosi stabilmente il paese. Uno
dei tratti che distingue la storia della Lunigiana, da quella di gran parte
dell'Italia, sta nella mancanza di un grande centro urbano. Il feudalesimo,
qui, non trovando sulla sua strada le nuove formazioni dei comuni, durò più
che altrove. Ma il passo della Cisa, che univa
Parma e
Modena
al Tirreno, la pianura alla costa, era troppo importante.
Rappresentava la via più breve per gli eserciti del Nord, il passaggio
obbligatorio per i prodotti e le mercanzie della Padania.
Milano,
Lucca,
Genova,
Firenze al momento della loro massima potenza, non potevano tollerare
l'assoluto dominio di una famiglia contro le esigenze delle città-stato. Nel
1471 la Repubblica Fiorentina, che vent'anni prima aveva alloggiato i suoi
capitani nel vicino e imponente maniero di Castiglion del Terziere, occupò
borgo e castello di Bagnone. Entrati a Bagnone, i fiorentini imprigionarono
Cristiano Malaspina
annettendosi stabilmente il paese.
 A
poco a poco, la Lunigiana verrà conquistata e smembrata: un pezzo a Lucca,
l'altro a Firenze, agli Estensi, ai Visconti, agli Sforza. Dopo il
Cinquecento, quando Firenze prevalse in buona parte della regione, i feudi
malaspiniani cominciarono a sgretolarsi sotto la spinta di divisioni
ereditarie e di crisi economiche.
Ortensio Lando, nel Cinquecento appunto, non risparmiava
l'ironia sulle difficoltà del casato, scrivendo che era facile "vedere
nella Lunigiana 30 marchesi a un tratto sopra un fico per sfamarsi". Una
dura vicenda di violenza e di fame logorò così questi luoghi, lasciando
miracolosamente intatto il tratto arcaico negli scenari incolti delle
foreste e delle tetre quinte di pietra dei castelli, che tuttora tramandano
l'eco di una potenza perduta. A
poco a poco, la Lunigiana verrà conquistata e smembrata: un pezzo a Lucca,
l'altro a Firenze, agli Estensi, ai Visconti, agli Sforza. Dopo il
Cinquecento, quando Firenze prevalse in buona parte della regione, i feudi
malaspiniani cominciarono a sgretolarsi sotto la spinta di divisioni
ereditarie e di crisi economiche.
Ortensio Lando, nel Cinquecento appunto, non risparmiava
l'ironia sulle difficoltà del casato, scrivendo che era facile "vedere
nella Lunigiana 30 marchesi a un tratto sopra un fico per sfamarsi". Una
dura vicenda di violenza e di fame logorò così questi luoghi, lasciando
miracolosamente intatto il tratto arcaico negli scenari incolti delle
foreste e delle tetre quinte di pietra dei castelli, che tuttora tramandano
l'eco di una potenza perduta.
 A Mulazzo, dall'autunno del 1306 alla
primavera
dell'anno seguente, Dante fu ospite di Franceschino Malaspina,
magnanimo signore della "spina secca"; più di un secolo prima le aule
signorili dei Malaspina s'erano aperte alla lirica provenzale, e uno di loro
Alberto, si rese protagonista di una famosa tenzone poetica con il trovatore
Rambaldo di Vaqueiras. Ma verso il Quattrocento, con lo sfaldarsi della
dinastia, cominciarono le migrazioni di scrittori, umanisti, notai,
diplomatici, insegnanti. Personaggi colti e/o abbienti, tutti a infittire
quella schiera di nostalgici vagabondi che il ristagno dell'economia, la
durezza dei luoghi, le continue devastazioni, avevano spinto lontano.
Lunigianesi eran gran parte delle Bande nere di Giovanni de'
Medici; lunigianesi i contadini avventizi, i pastori improvvisati che
andavano, come recita un memoriale del 1795, ad "affrontare la morte
nelle Maremme dall'aria infetta e micidiale". Molti fecero fortuna come
venditori ambulanti, scollinando verso la Lombardia, tanto che ancora oggi
nella parlata locale aperta "bersan" designa chi ha scelto di dirigersi a
nord e verso
Brescia.
Parenti e migranti tornano ora ai loro paesi come turisti. A Bagnone le
automobili sono spesso targate
Torino,
Vercelli,
Brescia. Tornano a vedere le foreste selvagge, i castagneti, i ruderi, i
terrazzamenti dove si coltiva la vite, una vite particolare che dà un vino
aspro, selvatico e indomito come le rocche e i castelli dei dintorni,
imprendibili e indistruttibili. A Mulazzo, dall'autunno del 1306 alla
primavera
dell'anno seguente, Dante fu ospite di Franceschino Malaspina,
magnanimo signore della "spina secca"; più di un secolo prima le aule
signorili dei Malaspina s'erano aperte alla lirica provenzale, e uno di loro
Alberto, si rese protagonista di una famosa tenzone poetica con il trovatore
Rambaldo di Vaqueiras. Ma verso il Quattrocento, con lo sfaldarsi della
dinastia, cominciarono le migrazioni di scrittori, umanisti, notai,
diplomatici, insegnanti. Personaggi colti e/o abbienti, tutti a infittire
quella schiera di nostalgici vagabondi che il ristagno dell'economia, la
durezza dei luoghi, le continue devastazioni, avevano spinto lontano.
Lunigianesi eran gran parte delle Bande nere di Giovanni de'
Medici; lunigianesi i contadini avventizi, i pastori improvvisati che
andavano, come recita un memoriale del 1795, ad "affrontare la morte
nelle Maremme dall'aria infetta e micidiale". Molti fecero fortuna come
venditori ambulanti, scollinando verso la Lombardia, tanto che ancora oggi
nella parlata locale aperta "bersan" designa chi ha scelto di dirigersi a
nord e verso
Brescia.
Parenti e migranti tornano ora ai loro paesi come turisti. A Bagnone le
automobili sono spesso targate
Torino,
Vercelli,
Brescia. Tornano a vedere le foreste selvagge, i castagneti, i ruderi, i
terrazzamenti dove si coltiva la vite, una vite particolare che dà un vino
aspro, selvatico e indomito come le rocche e i castelli dei dintorni,
imprendibili e indistruttibili.
 Insomma,
venite da queste parti, non ve ne pentirete. Visiterete uno dei centri più
pittoreschi di questa parte della Toscana. Sentirete correre il torrente
Bagnone che passa tra le strette balze scavate nelle rocce. Ammirerete lo
spettacolo, estremamente suggestivo dalla piazza centrale, Piazza Roma, il
cuore del paese. Alzando guardo vedrete il castello dei conti Noceti, con la
torre del XVI secolo e un po' più il la il suggestivo scenario delle vallate
formate dai contrafforti del monte Sillara (alto 1861 metri). Infine
Bagnone è una base ottima per escursioni in tutta la zona, fino a
Pontremoli, a nord, e Massa, a sud, a partire dal borgo e dal castello di
Castiglione del Terziere. Nei mesi estivi in molti poi non perdono
l'occasione di bagnarsi nelle fredde ma limpidissime acque del torrente
Bagnone nei pressi del paese della fazione di Iera, dove ci sono
pozze dai colori brillanti dove i ragazzi amano farsi il bagno. Insomma,
venite da queste parti, non ve ne pentirete. Visiterete uno dei centri più
pittoreschi di questa parte della Toscana. Sentirete correre il torrente
Bagnone che passa tra le strette balze scavate nelle rocce. Ammirerete lo
spettacolo, estremamente suggestivo dalla piazza centrale, Piazza Roma, il
cuore del paese. Alzando guardo vedrete il castello dei conti Noceti, con la
torre del XVI secolo e un po' più il la il suggestivo scenario delle vallate
formate dai contrafforti del monte Sillara (alto 1861 metri). Infine
Bagnone è una base ottima per escursioni in tutta la zona, fino a
Pontremoli, a nord, e Massa, a sud, a partire dal borgo e dal castello di
Castiglione del Terziere. Nei mesi estivi in molti poi non perdono
l'occasione di bagnarsi nelle fredde ma limpidissime acque del torrente
Bagnone nei pressi del paese della fazione di Iera, dove ci sono
pozze dai colori brillanti dove i ragazzi amano farsi il bagno.
Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
Dove si trova?
Torna su
Ostelli
Bagnone
Ostelli
Italia
Auberges de Jeunesse Italie
Hotel Bagnone
Carte Bagnone
Karte von
Bagnone
Mapa Bagnone
Map of Bagnone
Carte
de Toscane
Karte von
Toskana
Mapa Toscana
Map of Tuscany
Carte d'Italie
Karte von
Italien
Mapa Italia
Map of Italy |
