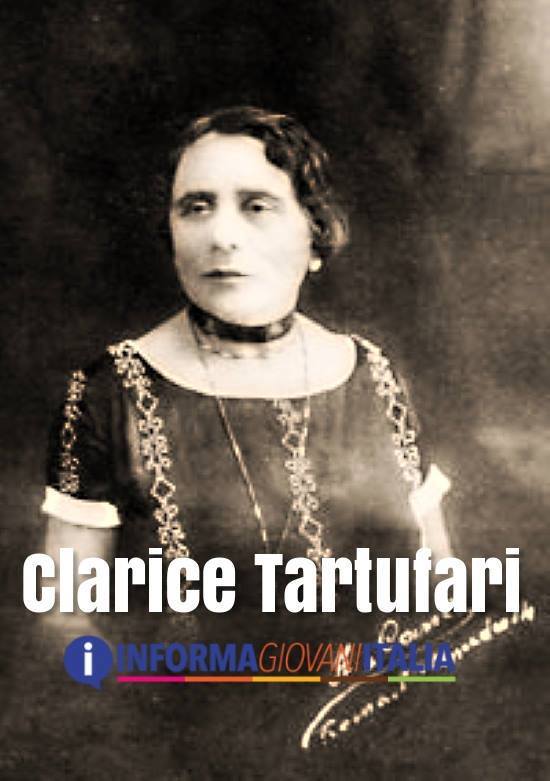Sei qui: Articoli informagiovani
>
Biografie
>Clarice
Tartufari - Biografia e opere
|
Clarice Tartufari (nata Gouzy) è stata una
scrittrice italiana di talento, nonché giornalista,
drammaturga, e viaggiatrice, attiva tra fine Ottocento e primo
Novecento, tra il periodo della Belle Époque ed il
primo dopoguerra. Stimata da Luigi Capuana, da
Luigi Russo, da Adriano Tilgher, divenne popolare
anche in Francia e Germania. Classe 1868, viene ricordata in
particolare per alcuni romanzi dal tratto
verista e
decadentista. Tra le sue opere più conosciute troviamo
Roveto ardente (1905), Rete d’acciaio
(1919), Il dio nero (1921), Il mare e la
vela (1924), Ti porto via!
(1933), e include notevoli pezzi teatrali,
una riscoperta che sicuramente allieta il mondo
culturale odierno.
|
|
Il contribuito alla produzione narrativa italiana fu
di rilievo, tanto che illustri letterati del calibro di
Benedetto Croce non esiteranno a compararla a
Grazie Deledda, premio Nobel della
Letteratura nel 1926 , mentre
Luigi Capuana, altro illustre italiano, non
esiterà a definirla autrice «...di impeto e foga
notevolissimi, che parecchie sue consorelle possono
invidiarle». Ai giorni nostri arriva quasi sconosciuta,
riscoperta autentica di un filone editoriale capace di
recuperare autentiche esperienze letterarie di primo ordine,
e in un periodo, come quello che si avviava al fascismo,
sempre utile da confrontare con il mondo odierno.
Molti dei suoi lavori furono inizialmente pubblicati in
riviste e periodici dell'epoca, così come L'eroe
(1904) o La salamandra (1906) che infatti
costituirono il fortunato repertorio di varie compagnie
teatrali. Nell'arte teatrale, la sua padronanza
del dialogo fu di indubbio talento: tale da "far parlare
il silenzio" e le "cose non dette", l'inespresso come il
sottinteso, diventando il perno dell'espressione
nell'intreccio della trama narrativa.

 La Tartufari nacque a Roma il 14 febbraio 1868 da Giulio
Gouzy e Maria Luisa Servici. Il padre di origine
francese e di
religione protestante, si convertì al cattolicesimo per
poter sposare la madre, la cui famiglia - di piccola nobiltà
- inizialmente fu molto contrariata all'unione dei due. La
piccola passò un'infanzia non facile, perdendo ambedue i
genitori in tenera età e fu accolta insieme ai fratelli
nella casa del nonno e dello zio, Alfonso, nella località di
Novilara, campagna nella provincia di Pesaro.
La giovane Clarice ebbe una prima istruzione scolastica di
tipo privato, iniziando in modo autonomo ad appassionarsi di
letture impegnative, tra cui opere di Metastasio e
Rousseau. Venne quindi iscritta alla scuola normale con
indirizzo magistrale, dove si diplomò giovanissima. Si sposò
presto con Vincenzo Tartufari, un giovane toscano
conosciuto a
Roma, e si trasferì nella località di
Bagnore, in provincia di
Grosseto, zona Monte Amiata, dimora
che terrà per tutta la vita.
La Tartufari nacque a Roma il 14 febbraio 1868 da Giulio
Gouzy e Maria Luisa Servici. Il padre di origine
francese e di
religione protestante, si convertì al cattolicesimo per
poter sposare la madre, la cui famiglia - di piccola nobiltà
- inizialmente fu molto contrariata all'unione dei due. La
piccola passò un'infanzia non facile, perdendo ambedue i
genitori in tenera età e fu accolta insieme ai fratelli
nella casa del nonno e dello zio, Alfonso, nella località di
Novilara, campagna nella provincia di Pesaro.
La giovane Clarice ebbe una prima istruzione scolastica di
tipo privato, iniziando in modo autonomo ad appassionarsi di
letture impegnative, tra cui opere di Metastasio e
Rousseau. Venne quindi iscritta alla scuola normale con
indirizzo magistrale, dove si diplomò giovanissima. Si sposò
presto con Vincenzo Tartufari, un giovane toscano
conosciuto a
Roma, e si trasferì nella località di
Bagnore, in provincia di
Grosseto, zona Monte Amiata, dimora
che terrà per tutta la vita.
 L'inizio
della carriera letteraria arrivò in sordina, tra correzioni
di bozze per riviste e opuscoletti, collaborando con
periodici come Donna, Nuova Antologia e
Fanfulla della domenica; già nel 1887, diciannovenne,
scrisse una novella, Maestra, che racconta la
vita di una donna e dei sacrifici quotidiani per
un'istruzione dignitosa e diventare maestra, tra stanze
anguste senza luce né aria, silenziose rinunce, dignitosa
miseria e Ginevra, figlia di un portalettere e di una
stiratrice.
L'inizio
della carriera letteraria arrivò in sordina, tra correzioni
di bozze per riviste e opuscoletti, collaborando con
periodici come Donna, Nuova Antologia e
Fanfulla della domenica; già nel 1887, diciannovenne,
scrisse una novella, Maestra, che racconta la
vita di una donna e dei sacrifici quotidiani per
un'istruzione dignitosa e diventare maestra, tra stanze
anguste senza luce né aria, silenziose rinunce, dignitosa
miseria e Ginevra, figlia di un portalettere e di una
stiratrice.
La
collaborazione con le riviste si rese sempre più intensa,
tanto da portarla a scrivere diversi articoli di sicuro
interesse su argomenti rivolti al mondo femminile e alla
figura della donna nella società dell'epoca. Tra le sue
pubblicazioni si citano in particolare: Il concetto
della donna nel pensiero del Bonghi; Studio su
Ada Negri; Dal finestrino di un treno
espresso, pagine di un diario di viaggio; più alcuni
componimenti poetici, quali Primavera, E
penso al mare, È morto il sole,
Mentre piove, La fontana del mistero,
Luci e specchi. Un primo volume venne
pubblicato nel 1894, Versi nuovi, una raccolta
di poesie. Due anni dopo seguì Vespri di maggio,
sullo stesso filone.
 Raccolte
di poco successo, ma di sicuro istinto creativo, che
successivamente, e per diversi anni, esprimerà in diverse
opere teatrali, anche firmate con lo pseudonimo, usando
il nome del fratello maggiore, di Carlo Gouzy, morto
prematuramente. Modernissima (1900),
Logica (1901), L'eroe (1904), La salamandra
(1906), vengono rappresentate a teatro nello stesso anno con
la compagnia Maggi. Nel complesso vengono sono presenti
tematiche legate alla tradizione del dramma borghese,
e alle sempre più attuali considerazioni del ruolo femminile
nella società di allora. La scenografia è ben descritta in
modo preciso e dettagliato, tra abiti, portamento,
espressioni di un viso, del fisico, e non ultimi nei
dialoghi.
Raccolte
di poco successo, ma di sicuro istinto creativo, che
successivamente, e per diversi anni, esprimerà in diverse
opere teatrali, anche firmate con lo pseudonimo, usando
il nome del fratello maggiore, di Carlo Gouzy, morto
prematuramente. Modernissima (1900),
Logica (1901), L'eroe (1904), La salamandra
(1906), vengono rappresentate a teatro nello stesso anno con
la compagnia Maggi. Nel complesso vengono sono presenti
tematiche legate alla tradizione del dramma borghese,
e alle sempre più attuali considerazioni del ruolo femminile
nella società di allora. La scenografia è ben descritta in
modo preciso e dettagliato, tra abiti, portamento,
espressioni di un viso, del fisico, e non ultimi nei
dialoghi.
 Nella
dialettica narrativa viene descritta un'epoca quasi come una
fotografia, tale fu la capacità della Tartufari di riportare
l'accuratezza di particolari, nella scenografia, negli abiti
come nelle mode, in un guizzo del viso come appunto nel
dialogo. Legata al tradizionale filone di letteratura al
femminile di fine Ottocento – Primo Novecento, come
accadde a nomi come
Matilde Serao
o
Maria Messina, anche la Tartufari pone al
centro dei suoi dramma le donne, quelle che sfidato o
che desiderano sfidare i pregiudizi di una comunità
tradizionalista, ancora invasa dal bigottismo sociale, ma
che poi si ritrovano ad accettare i ruoli di sempre, come
quello di moglie o di figlia devota.
Nella
dialettica narrativa viene descritta un'epoca quasi come una
fotografia, tale fu la capacità della Tartufari di riportare
l'accuratezza di particolari, nella scenografia, negli abiti
come nelle mode, in un guizzo del viso come appunto nel
dialogo. Legata al tradizionale filone di letteratura al
femminile di fine Ottocento – Primo Novecento, come
accadde a nomi come
Matilde Serao
o
Maria Messina, anche la Tartufari pone al
centro dei suoi dramma le donne, quelle che sfidato o
che desiderano sfidare i pregiudizi di una comunità
tradizionalista, ancora invasa dal bigottismo sociale, ma
che poi si ritrovano ad accettare i ruoli di sempre, come
quello di moglie o di figlia devota.
Il ruolo della donna lo si vede in particolare nel suo
romanzo postumo "L'uomo senza volto", dove
l'unica donna che appare veramente emancipata, la dottoressa
Nice, si laurea in filosofia con una tesi dal titolo 'Noi
ragazze di oggi', e che poi aspira ad un marito amante
ma anche padre e compagno mentore. A differenza di alcune
scrittrici sue contemporanee, nonostante affronti e denunci
tematiche come la discriminazione di genere o quella
sociale, si dimostra infine poco incline alla risoluzione
del conflitto, preferendo adattarsi in modo pragmatico alla
morale corrente. Interessante a tale proposito diventa la
lettura di Le modernissime, commedia in tre
atti, pubblicata con lo pseudonimo di Carlo Gouzy, e
ambientata nel mondo borghese di una grande città: narra di
due giovani sorelle arrampicatrici sociali, Caterina e
Carlotta, che si servono delle loro idee sul ruolo della
donna per migliorare la posizione di entrambe nel mondo
borghese. Riusciranno nell'intento?
É tutto un mondo di aspirazioni quello della Tartufari,
impegnato nell'eterna legge del ciclo sociale, come quello
delle famiglie della sua epoca, spinte dall'impetuosa
volontà di elevarsi al di sopra della propria condizione
(come accade nel suo primo romanzo 'Maestra')
e ascendere alla raffinatezza intellettuale; poi accade però
che ristagnano e cadono. Sono tematiche molteplici quelle
comunque affrontate, e qui sta ancora una volta la vera
forza della Tartufari: tematiche come il contrasto tra l'
eroismo dei pochi giovani sacrificati alla guerra con
impeto, e la vita dei molti, che sul sangue dei primi hanno
poi innalzato la loro privata fortuna. Ci sono poi gli
stimoli autobiografici, seppur rari, che rivivono, nel
Il gomitolo d'oro (1924), con le rievocazioni
del paesaggio campestre dominato dal castello di Novilara,
dove l'autrice rievoca con affetto la stagione della sua
infanzia e prima giovinezza.
Nel 1909 viene pubblicato uno suoi romanzi più conosciuti,
Il Miracolo (“sopra le viuzze tacite di Orvieto,
sopra gli orti fronzuti, sui fastosi palazzi disabitati ed i
vasti giardini sonnolenti, le note delle campane volavano a
sciami, sparpagliandosi e disperdendosi, oltre la cerchia
delle mura tufacee?), che pone a confronto il modernismo
di un epoca agli esordi, contro il cattolicesimo
tradizionalista, conditi dalla classica analisi sociale e
psicologica, delineata con tratto preciso: viene raccontata
la storia di una giovane vedova che vive in un ambiente
provinciale di benpensanti cattolici e moralisti, divorata
dai rimorsi per essersi lasciata andare alla passione.
I quadri paesaggistici non mancano, così come lo stile
narrativo, sempre calibrato ai protagonisti delle vicende
man mano descritte. Con sicuro intuito, la scena dei suoi
romanzi è collocata in piccole città (Orvieto,
Pesaro), che nel presente vivono del passato
e che restano pur sempre asilo sicuro (tra religione e
morale) dalle grandi città moderne, come Roma, a loro volta
rappresentanti di una memoria sempre più incerta. Accade
così per Orvieto, in Il Miracolo, città che vive del
suo Duomo ricco di marmi e ori, del suo seminario severo,
dei suoi antichi vicoli acciottolati, e che partecipa alle
vicende dei suoi abitanti, soffrendo con loro quasi fossero
un'unica anima. Viene ritenuto uno dei romanzi più
rappresentati della Tartufari, che pure catturò l’attenzione
della stampa tedesca. In romanzi come in
Fungaia, 1908 (con Roma e il periodo degli scandali
bancari in sottofondo) e All'uscita del labirinto,
1914 (che narra le vicende di una donna attraversare la
solitudine per conquistare una propria autonomia sociale),
troviamo confermato lo stile narrativo della Tartufari e la
sua capacità di tratteggiare i suoi personaggi, in questo
caso ad includere non solo le figure femminili ma anche gli
anziani, memoria di una società a cui l'autrice si sente
molto legata, pur rappresentandone il confronto con la
modernità che andava comparendo.
I personaggi che incontriamo nelle sue opere sono creati dalla
fantasia, parte di un contesto realistico e storico di vita
vissuta e di aspetti socio-culturali, e che si pone carico
di riflessioni utili al mondo moderno di oggi. Intenso il
dibattito all’interno della Chiesa tra tradizionalisti e
modernisti, da lei espresso, così come quello
sull'emigrazione verso Israele da parte degli
ebrei romani (che leggiamo in Il mare e la vela
– 1924 – dove vengono affrontate le vicende dell’ebreo
Gastone Budrio, mentre si reca in viaggio fuori dalla
capitale e verso luoghi dove «Da un paese all’altro le
campane si chiamano e si rispondono; le massaie rubiconde,
in groppa all’asino, scendono in paese a vendere erbaggi e
ad acquistare frottole dai mercanti girovaghi. Intanto la
luce si diffonde e tutto allieta in vetta ai colli e nel
fondo delle vallate»). Non mancano le tematiche che
fanno da sfondo alla Prima guerra mondiale, così come
quelle che uno sguardo attento ricerca nel periodo
che porta al Fascismo.
I temi affrontati sono vari e liberi da elementi
autobiografici: così accade in Suburra, opera
teatrale, in prima versione del 1909, in cui è descritto
l’ambiente della piccola borghesia romana, e che è anche
noto nella versione tedesca, tradotto nel 1911 da Hans
Barth con il titolo Das Wunder. Tra gli altri
suoi romanzi più importanti troviamo anche Il marchio
(1914), Roveto ardente (1901), che Luigi Capuana già
definì un «lampo schietto di accesa passione»,
All'uscita del labirinto (1914), recensito da La donna
il 5 marzo 1911 come un'opera dove poter "sentire battere
il ritmo inquieto dell’anima femminile di altri romanzi".
Tra le altre opere si citano Logica (1900),
Arboscelli divelti (1901), Dissidio (1901), Il
volo di Icaro (1908), La testa di Medusa (1910),
Eterne leggi (1911), romanzo sociale e filosofico e
che fu subito tradotto in francese, e che narra della legge
imperativa della caducità e del rinnovamento, L'albero
della morte (1912), Il giardino incantato (1912),
Rete d'acciaio (1919), Il Sentiero
(1925), Lampade nel sacrario (1929), L'imperatrice
dei cinque re (1931).
Ti porto via! (1933) fu l'ultima opera che la
Tartufari scrisse. Morì il 3 settembre 1933, nella
sua casa di Bagnore. Negli anni '30 del Novecento, con il
fascismo che andava consolidandosi, le sue opere vennero ben
presto dimenticate; d'altronde prendevano forma altre
tematiche letterarie, rispetto a quelle che esigevano il
confronto sociale del primo Novecento, e che infatti
preferivano trattare di viaggi coloniali nei nuovi territori
italiani, quali l'Etiopia. Oggi, le opere di Clarice
Tartufari sono importanti per sviluppare un punto di
riflessione sul clima culturale della sua epoca, e che si
avviava alla stagione del fascismo, nonché alla chiusura
culturale e all’autarchia del regime.
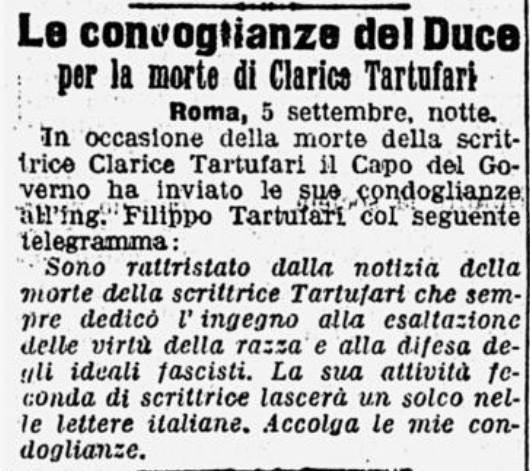 Nel
L'uomo senza volto, romanzo postumo uscito nel
1941, si intuisce ancor di più il talento di Clarice
Tartufari. Prosa e tematica si uniscono in un connubio di
rilievo, psicologico e narrativo. La scelta ricade ancora
una volta sull'universo femminile ma anche, in questo caso,
sul mondo interiore maschile, riconoscendone il giusto
ruolo. Rodolfo, che ritorna dalla guerra e si ricongiunge
alla famiglia, dopo un viaggio dalla Polonia all'Italia, in
cui il cambiamento degli ultimi anni sembra ripercorrere i
meandri della memoria. Il destino sembra improvvisamente
diverso da quello immaginato durante la prigionia, incide
sulla sua identità e una mente confusa e tiranna. Anche qui
fa da sfondo l'ambiente borghese a cui la famiglia
appartiene.
Nel
L'uomo senza volto, romanzo postumo uscito nel
1941, si intuisce ancor di più il talento di Clarice
Tartufari. Prosa e tematica si uniscono in un connubio di
rilievo, psicologico e narrativo. La scelta ricade ancora
una volta sull'universo femminile ma anche, in questo caso,
sul mondo interiore maschile, riconoscendone il giusto
ruolo. Rodolfo, che ritorna dalla guerra e si ricongiunge
alla famiglia, dopo un viaggio dalla Polonia all'Italia, in
cui il cambiamento degli ultimi anni sembra ripercorrere i
meandri della memoria. Il destino sembra improvvisamente
diverso da quello immaginato durante la prigionia, incide
sulla sua identità e una mente confusa e tiranna. Anche qui
fa da sfondo l'ambiente borghese a cui la famiglia
appartiene.
La Tartufari fu anche talentuosa dicitrice nella sua
attività di conferenziera (confermata almeno su tre
appuntamenti, tra il 1911 ed il 1912, a Padova per una
conferenza su Dante, e a Roma e Torino sempre sul ruolo
della donna nella società).

Opere di Clarice
Tartufari
Romanzi
Ebe, Palermo, Sandron, 1902.
Roveto ardente, Torino – Roma, Roux e Viarengo, 1905.
Il volo d’Icaro, Torino, Sten, 1908.
Fungaia, Roma, Voghera, 1908.
Il miracolo, Roma, Romagna, 1909, trad. ted.: Das
Wunder, Stuttgart, 1911.
Eterne leggi, Roma, Romagna, 1911.
All’uscita del labirinto, Bari, Humanitas, 1914.
Rete d’acciaio, Milano, Treves, 1919.
Il dio nero, Firenze, Bemporad, 1921.
Il gomitolo d’oro, Milano, Trevisini, 1924.
Il mare e la vela, Firenze, Bemporad, 1924.
La nave degli eroi, Foligno (Perugia), Campitelli,
1927.
Lampade nel sacrario, Foligno, Campitelli, 1929.
Imperatrice dei cinque re, Roma-Foligno, Campitelli,
1931
«Ti porto via!», Milano – Roma, Rizzoli, 1933.
L’uomo senza volto, Roma, Tosi, 1941.
Novelle
Maestra, Roma, Perino, 1887.
Il giardino incantato, Roma, Armani e Stein, 1912.
L’albero della morte, Roma, Voghera, 1912.
Poesie
Versi nuovi, Roma, Loescher, 1894.
Vespri di maggio, Roma, Loescher, 1897
A Giuseppe Verdi in morte della moglie, Milano, E.
Loescher, 1897.
Teatro
Dissidio, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1901.
Logica, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1901.
Le modernissime, Roma, Società Editrice Dante
Alighieri, 1902.
L’eroe, Torino-Roma, Roux e Viarengo, 1904, Trad. ted.
da J. Mager: Mammon, München, 1906.
L’opinione di Balzac, Scherzo comico in 1 atto, 1904.
Altri tempi. Commedia in tre atti, Roma, 1905.
Salamandra, Commedia in tre atti, 1906
Il marchio, Commedia in tre atti, 1906.
Lucciole sulla neve, Dramma 1 atto, 1907
La testa di Medusa, Torino, Unione Editoriale, 1910.
Arboscelli divelti, Milano, Barbini, 1913.
Altri scritti
Italia Vitaliani, Palermo, Biondo, 1902.
La rivelazione di Beatrice, Firenze, Olschki, 1913.

Lettera
autobiografica di Clarice Tartufari a Onorato Roux
Dai dodici ai quindici anni la mia vita trascorse in modo
assolutamente inusato per una bambina di quella età. Mi
avevano sbalzata, di punto in bianco, alle abitudini
cittadine dall'esistenza quasi selvaggia della campagna,
dov'ero vissuta durante l'infanzia, correndo pei solchi,
inerpicandomi pei greppi, sforacchiandomi le mani ai pruni
delle siepi e incrostandomi di salsedine i piccoli piedi
scalzi, allorché mi sollazzavo, per intieri pomeriggi, sopra
un lembo deserto della spiaggia adriatica.
Dietro le mie spalle s'innalzava a picco il monte Ardizio,
ossuto e nudo come lo scheletro di un gigante; dinanzi ai
miei occhi si distendeva il mare, e io, presso la riva
constellata di pietruzze e conchiglie, attendevo le onde che
si avanzavano dal largo rapide e turgide; poi, quando,
arruffate di spuma sulle creste mobili, si accostavano al
lido per ivi frangersi con voce sonora, io fuggivo a tutta
corsa e mi volgevo, con gioia orgogliosa, a irridere il
mare, che era tanto grande e che pure non sapeva raggiungere
me tanto piccola oltre la zona della sabbia bagnata e si
ritraeva mugghiante, minaccioso, eppure impotente dalla zona
della sabbia asciutta, mentre io, a un tempo spavalda e
pavida, mi avanzavo di nuovo con l'acqua fino ai malleoli e
di nuovo fuggivo al sopraggiungere delle onde ed allo
sparpagliarsi fra l'alghe della spuma sempre rinnovata e
candida.
In città era tutt'altra cosa. Di giorno bisognava
passeggiare e mangiare ad orario fìsso; di notte bisognava
affondarsi dentro un vasto letto troppo morbido e,
destandoci, bisognava ascoltare nel silenzio le voci dei
passanti o il rumore di qualche carrozza, anziché il canto
dell'usignolo o l’affrettato zirlìo acuto dei grilli o,
durante le notti lunari, l'abbaiare furibondo dei cani
irritati contro la luna. Il mare bisognava guardarlo dalla
piattaforma di uno stabilimento e condannarsi a udire, fra
il bisbiglio dei madrigali e il cicaleggio della maldicenza,
l'alta voce delle acque che si muovono perennemente da
opposte plaghe, portando a noi la eco
del vento quando urla e della tempesta quando si sfrena.
Io non sapevo raccapezzarmi. Ero disorientata, ero
melanconica; gli abiti assettati m'impacciavano le membra;
la tirannia dell'orario mi vincolava il pensiero e spesso
scendevo sola in cortile per contemplare il cielo e
invidiare le rondini elle volavano al di sopra dei tetti. Mi
aggrappavo allora ai ferri del cancello e lo scuotevo,
simile a un aquilotto prigioniero che batta rabbioso delle
ali contro le sbarre della sua gabbia. Avrei voluto morire e
in pari tempo sentivo in me una sete ardentissima di vivere,
un bisogno confuso d'impiegare l'esuberanza della mia forza;
avrei voluto che qualcuno m'amasse e mi consolasse, mentre
io stessa, a mia volta, avrei voluto amare e consolare
qualcuno; desideravo con ardore tesori di gioia e di
tenerezza per dispensarli; mi sentivo schiava nelle mie
azioni, libera nel mio pensiero, e la schiavitù delle mie
azioni mi umiliava, dandomi la misura della mia debolezza, e
la tumultuosa in- dipendenza del mio pensiero mi esaltava,
dandomi la misura della mia forza.
Passavo ore ed ore seduta immobile sui gradini della scala,
che da una stanza isolata conduceva ad un cortile silenzioso
angusto. Talora avrei voluto che qualcuno di me più possente
mi avesse preso per mano e mi avesse condotto via, facendomi
camminare interminabilmente lungo a una strada senza fine,
dove la luce avesse scherzato tepida e bionda fra i rami
penduli dei lilla in fiore e i ciuffi del biancospino dall'
odore amarognolo; talvolta avrei voluto esser io a prendere
per mano qualcuno di me più debole e trascinarlo con impeto
attraverso cespi di rovi, saltando burroni, sfidando
torrenti, per attingere la cima di qualche rifugio
inesplorato e quindi deporre in salvezza Tessere di me più
debole, per riprendere da sola il mio cammino aspro, in
mezzo ai pericoli, in mezzo all'orrido degli elementi in
ira per trovare la gioia nell'esercizio pieno del mio
coraggio. Invece nessuno si occupava di me e io non avevo
nessuno di cui occuparmi.
I miei Genitori erano morti da tanti anni; i parenti di mio
Padre vivevano e vivono in Francia, estranei a me per
differenza di religione e di lingua; il mio povero nonno
materno, già così imperioso, languiva in campagna abbattuto
dalla paralisi, come una quercia schiantata dal fulmine; i
miei due fratelli avevano le loro scuole, i loro compagni, i
loro sollazzi; le cuginette a me quasi coetanee, avevano i
genitori da cui farsi amare e proteggere; gli zii, presso i
quali vivevo, avevano i loro proprii figliuoli, a cui
largire il fiore dei loro afi'etti e il meglio dei loro
pensieri. Non ero maltrattata, oh! no dav-
vero, anzi tutt'altro; ma non ero nemmeno accarezzata. Si
aveva gran cura che io non ponessi piede oltre la soglia del
portone di casa, che non mi facessi alla finestra, che
nessuno mi avvicinasse, che io non avvicinassi nessuno, che
non mandassi ne ricevessi alcuna lettera, che non
frequentassi alcuna festa, che nulla, insomma, velasse
nemmeno di un alito l'innocenza de' miei tredici anni; ma,
intanto, le idee mi germogliavano nel cervello con la
fioritura libera dell'erbaglia dentro un recinto incolto,
senza che nessuno al mondo si desse briga di estirparne il
troppo ed il cattivo; e leggevo libri su libri, romanzi,
storie, poemi, trattati di filosofìa, commedie, tragedie,
vite di Santi, biografie di scrittori, senza discernimento
un metodo, passando dalle vicende acrobatiche del Conte di
Montecristo alle prose, spesso per me incomprensibili, di
Giosuè Carducci, dal rivoluzionarismo grossolano, a luce di
bengala, di Eugenio Sue nei “Misteri del popolo? alle pagine
meditate, profonde e lucide di Niccolò Machiavelli.
Ed è strano come tutto mi appassionasse ugualmente. I
romanzi mi appassionavano per la ricca e assurda varietà
delle loro avventure; le storie mi appassionavano perchè io
vedevo gli eserciti muoversi, i cortigiani intrigare, i
sovrani legiferare come attraverso ad una nebbia, che ne
rendeva imprecisi i contorni, abbellendo quei personaggi
realmente vissuti dei colori iridescenti, onde si adornano
le creature belle generate nel mondo dei sogni dalla
commossa fantasia dei poeti. Quantunque io fossi e sia
abitualmente meditativa e mi piaccia fare sosta ad ogni
nuova impressione per indagarne l'origine e misurarne la
portata, pure l'elemento fantastico è quello che predomina
in me. I personaggi dei libri che io leggo vivono
materialmente d'intorno a me; i personaggi dei libri che
scrivo assumono per me una fisonomia, una voce, un accento,
un'andatura e mi accompagnano nelle mie passeggiate e si
frappongono tra me e la realtà delle vicende giornaliere,
oscurando coi loro volti tristi o ridenti i volti delle
persone vive, coprendo con le loro voci il suono delle voci
che nella realtà mi parlano e che spesso io non ascolto. Nel
corso di una conversazione, mentre io sono tutta presa
dall'interesse dell'argomento intorno a cui la conversazione
si aggira o dal fascino personale del mio interlocutore, mi
basta che nel dialogo guizzi una parola evocatrice di
paesaggi lontani, il titolo di un libro a me caro, il nome
di una persona scomparsa, una inflessione di voce udita
altra volta su altre labbra ed in circostanze remote; mi
basta che a me giunga l'alito di un profumo dalla finestra
aperta o il trillo di un canarino echeggiante
fino a me da qualche gabbia invisibile, perchè l'immagine di
cose lontane o mai esistite prenda immediata consistenza e
importanza immediata e cada nel vuoto ogni parola della
conversazione presente.
Mi studio, per gentilezza, di mostrarmi tuttavia attenta al
dialogo, vi prendo anche parte con parole brevi o
interiezioni buttate a caso; ma divengo distratta,
impaziente, apro e chiudo il ventaglio, se è di estate;
stringo forte le mani, al riparo del manicotto, se è
d'inverno; la fisionomia mi si foggia involontariamente a
una espressione dolorosa; se mi trovo in casa d'altri mi
alzo e me ne vado affrettatamente; se mi trovo in casa mia
assumo un tale contegno preoccupato che il visitatore è
costretto, alla sua volta, di alzarsi e di andarsene. È più
forte di me. Il mio pensiero può docilmente, e anche per
lungo tratto, correre sopra le linee di un binario
tracciato, ma se lo coglie l'estro di galoppare senza guida
ne freno attraverso le plaghe sconfinate del sogno, esso mi
trascina, mi travolge e io debbo seguirlo docilmente nel
paese delle nuvole. Se questo mi accade oggi figurarsi quel
che mi doveva accadere a tredici anni.
Passavo nella vita a guisa di sonnambula! Mi davano grande
vanto di docilità, perchè ero indifferente; credevano che io
fossi passiva ed io, intanto, maturavo in me i germi di
future ribellioni, che strabiliarono tutti, quando, all'inprovviso,
mostrai di possedere una tenacia incrollabile, a sostegno
della mia volontà e talora anche de' miei capricci; mi
giudicavano melanconica, taciturna, apatica, e invece,
quando mi trovavo sola, ben certa di non essere né veduta,
ne ascoltata, mi davo a correre sfrenatamente, a cantare, a
parlare ad alta voce, a dire per mio conto mille cose amene,
che mi divertivano e
mi facevano ridere.
Il giorno in cui compivo i miei tredici anni io ero in letto
da oltre un mese, coi poveri piedi sanguinanti e turgidi per
i geloni; ero in letto la oltre un mese nella stanza più
appartata della vasta casa, una stanza tetra, fredda,
illuminata male, e ricordo che nevicava a piccole falde
lievi e le falde danzavano per l'aria opaca e venivano a
posarsi sui vetri della finestra, sciogliendosi subito e
convertendosi in acqua.
Tranne che nell'ora dei pasti, nessuno si preoccupava di me.
Era stato chiamato il medico, il quale aveva sentenziato,
spiritosamente, che, per guarire i geloni, ci vuole la
primavera; tutti avevano riso e tutti, me compresa, avevano
stabilito di aspettare il mese di maggio con rassegnazione.
La mattina, dunque, del mio tredicesimo anniversario, i miei
fratelli si presentarono in camera a portarmi un pacco di
dolci e un canestrino di frutta secche; mia zia mi portò due
lire in argento; le mie immaginette mi portarono la loro
attiva collabora- zione nel rosicchiare canditi e nel
succhiare caramelle; poi la stanza ricadde nello squallore
dell’abituale solitudine. Eppure io ripenso anche oggi a
quella giornata tetra come a una fra le più gaie della mia
vita. Stavo leggendo «Angelo Pitou» di Alessandro Dumas e
vivevo in mezzo agli eroi della rivoluzione francese.
Correvo dalla reggia di Luigi XVI a piazza della Bastiglia;
ne smantellavo i muri fra il clamore della moltitudine;
danzavo la Carmagnola sotto l'albero della libertà; ero ad
un tempo regina e rivoluzionaria, m'infiammavo per il
popolo; congiuravo per il re; ero tutto, ero tutti, e la mia
piccola anima si sentiva tanto ricca, tanto agile, che la
camera tetra diventava ampia, che la solitudine si affollava
di gente in moto e risuonava di grida e di canti.
D'altronde, chi era Luigi XVI? Dov' era Parigi? Quale numero
di anni mi separava da quegli avvenimenti e quale distanza
mi separava dai luoghi dove quegli avvenimenti si erano
svolti? Non sapevo, nè mi curavo di sapere. La mia ignoranza
era talmente fenomenale che a descriverla sembrerebbe
inverosimile. Geografia e cronologia erano per me lettera
morta, e io non avevo idea, nemmeno approssimativa, della
vastità dello spazio. Vedevo fatti e personaggi di epoche e
luoghi disparatissimi sopra una linea sola, priva .li
sfondo, e il passato mi si presentava come un quadro a un
solo ripiano, dove le figure stavano le une accanto alle
altre, nelle proporzioni stesse e con lo stesso rilievo.
Andromaca era per me coetanea di Maria Antonietta ed Oreste
era per me altrettanto vivo e vero quanto Garibaldi.
Avevo letto Omero nella traduzione del Monti, avevo letto
Virgilio nella traduzione del Caro; mi ero appassionata sino
alla frenesia per Ettore ed Achille; avevo odiato Enea, che
io insultavo da sola, chiamandolo sacrestano; avrei voluto
che Lavinia si fosse fatta rapire da Turno magari in
ferrovia; ma non m'importava all'atto di sapere dove o
quando quella gente era vissuta; per me viveva lì, nell'ora
presente, dentro le pareti della mia stanza, e ciò mi
bastava. Avevo letto a quindici anni quello forse che un
uomo discretamente colto non ha letto a trenta, e, non
pertanto, sentendo dire che una signorina di nostra
conoscenza era andata a Como in visita presso certi parenti,
ne rimasi sgomenta, impensierita, quasiché Como fosse un
paese misterioso ai limiti estremi dell'universo, e,
sentendo che la famiglia del maggiore dei carabinieri
abitante al secondo piano della nostra casa era di Napoli,
io attendevo furtiva sulla scala per vedere salire e
scendere le signore, stupita di scorgerle simili a noi nella
foggia delle vesti.
E interpretavo a mio modo molte parole; ad esempio, leggendo
la «Storia delle repubbliche italiane» del Sismondi e
sentendo che i principi tedeschi si erano adunati per una
dieta, io credetti fermissimamente che si fossero uniti
insieme per digiunare. Insomma, l'edificio della mia
istruzione divenne qualcosa d' ibrido e di assurdo,
fabbricato a casaccio, senza disegno, senza misura, senza
linee, senza concetti di praticità. Su taluni punti le
fondamenta di tale edificio si sprofondavano tanto da
toccare e abbarbicarsi all'essenza medesima del mio essere;
in certi altri punti era un edificio campato in aria e
doveva inevitabilmente crollare al primo urto, ingombrandomi
l’intelletto con alti cumuli di macerie; in talune parti
esso era elegante e saldo, in certe altre oscillante e
barocco, dimodoché, quando più tardi, dopo maritata, ho
voluto rimettere in ordine, per utilizzarlo, il materiale
ammassato, mi sono trovata di fronte a una tale confusione
di buono e cattivo, di roba vecchia e nuova, servibile ed
inservibile, che spesso mi sono arrestata, vinta dallo
sconforto, e talvolta ho gettato via qualche ornamentazione
squisita, talvolta ho serbato qualche ferraglia caduta in
disuso e, non ostante la disciplina ferrea che mi sono
imposta e gli studii rigidissimi a cui mi sono sottomessa,
anche oggi trovo lacune nel mio pensiero, anche oggi mi vedo
condannata ad arrestarmi o deviare per la mancanza di
qualche piccolo ponte di passaggio che mi permetta di
varcare difficoltà irrisorie in se stesse e per me
insuperabili. E, quantunque io abbia sortito da natura un
gusto sottilissimo e il mio gusto io abbia affinato con lo
studio indefesso dei classici, scorgo alle volte nell'opera
mia un non so che di eccessivo e di gonfio, che m'irrita, mi
umilia, che io percepisco e di cui non riesco a liberarmi.
Ed è così anche pel mio carattere.
Io posseggo un temperamento arditissimo, di ottima tempra.
Il pericolo mi esalta: dove c'è da combattere io mi sento
allegra e franca. Sembra che il mio passo diventi più svelto
via via che il sentiero diventa più scosceso e che il mio
braccio diventi più forte via via che più inaccessibile
appare la vetta su cui piantare il mio vessillo. Le critiche
più acerbe mi hanno servito di sprone; gli ostacoli non mi
hanno fatto mai indietreggiare, o, seppure, mi hanno fatto
indietreggiare per meglio prendere lo slancio nella mia
corsa. Io mi sento fiacca e triste quando nessuno sta contro
di me; una via larga e piana che mi si apra dinanzi fa
nascere subito in me il desiderio del riposo. Ho bisogno di
guardare in alto, di vedere montagne e dirupi per sentirmi
alacre, e, se vivessi nel mondo delle favole, io sarei la
piccola eroina che va, cantando, tra mostri ed insidie, a
raccogliere i pomi preziosi dentro il giardino guardato dal
drago vomitante fiamme dagli occhi e dalle nari. Ebbene, con
un temperamento così audace, con un'anima così pronta ad
accendersi alla fiaccola dell’orgoglio e del coraggio, io,
nelle minute contingenze della vita, ho timidezze
inconcepibili, strane paure. Un viso nuovo da vedere mi
sgomenta; una visita da fare a persona sconosciuta mi
preoccupa per una intiera giornata.
Se tutto un pubblico mi fischia con furore una commedia, io
rimango assolutamente tranquilla al cospetto degli altri e,
quello che più vale, al cospetto di me stessa; invece, se mi
presento a un capocomico con un copione ovvero a un editore
con un manoscritto, io cerco le parole; il respiro mi vien
meno e per poco che il mio interlocutore mi appaia freddo o
indeciso, io scompagino tutto con l'espressione del mio viso
tra punto e spaurito e con l'insieme del mio contegno fra
intimidito ed offeso. Ciò avviene, perché intellettualmente
e moralmente mi fanno difetto le note medie, quelle
legature, quei passaggi, che servono a dare unità e
morbidezza così alle opere d'arte come nelle vicende della
vita. E simili manchevolezze, di cui ho subito e subisco le
conseguenze gravissime, io le debbo ripetere dalla mia
infanzia troppo selvaggia, dalla mia adolescenza troppo
sfrenatamente libera nelle mie letture, troppo claustrale
nelle mie abitudini.
Clarice Tartufari. (11 aprile 1908)
Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕