|
Sei qui:
Cosa vedere a Firenze
>
Battistero di Firenze
|
Il Battistero dedicato a
San Giovanni Battista è situato di fronte
alla facciata della
Cattedrale di Firenze.
Si tratta della struttura
più antica tra i maggiori monumenti di Piazza del Duomo. Venne costruito
probabilmente intorno al IV o V secolo sopra le fondamenta di
un tempio romano dedicato a Marte, dio della guerra. Spesso, gli storici
dell'arte,
nel dare una data d'inizio al
Rinascimento indicano la data
del
1401 e cioè l'anno in cui i mercanti della lana di Firenze
scelsero tramite concorso colui a cui affidare il progetto delle
porte nord del Battistero,
poi eseguite da Lorenzo Ghiberti.
|
|
La forma ottagonale dei battisteri ha sempre avuto un connotato
puramente simbolico e non estetico. Nella cristianità, il numero
otto indicava la rinascita e la rigenerazione. L'ottagono
serviva a rappresentare i sei giorni della creazione divina dei
cieli e della terra, il settimo giorno dl riposo e l'ottavo
giorno in cui i cristiani "rinascono", cioè si rigenerano
attraverso il battesimo.
 Quelle sud erano state progettate 65 anni prima da
Andrea Pisano.
Tra altri illustri partecipanti (tra cui Donatello e
Brunelleschi)
fu scelto Lorenzo Ghiberti, le cui porte (est e nord)
sono probabilmente le più famose. Tra queste si apprezza in
particolare quella est, nota anche come Porta del Paradiso
(così come inizialmente chiamata dal Michelangelo), formata
da una serie di 10 riquadri bronzei dorati, raffiguranti scene
dell'Antico Testamento. Dalla
Alluvione di Firenze
del 1966 i rilievi originali sono custoditi al
Museo dell'Opera del Duomo. Del Battistero si ammirino anche
i mosaici su fondo dorato della cupola, iniziati nel 1270 e
completati un secolo dopo (sono opere di grandi maestri italiani
come Cimabue e l'anonimo Maestro della Maddalena,
artista dell'epoca tutt'oggi sconosciuto). Quelle sud erano state progettate 65 anni prima da
Andrea Pisano.
Tra altri illustri partecipanti (tra cui Donatello e
Brunelleschi)
fu scelto Lorenzo Ghiberti, le cui porte (est e nord)
sono probabilmente le più famose. Tra queste si apprezza in
particolare quella est, nota anche come Porta del Paradiso
(così come inizialmente chiamata dal Michelangelo), formata
da una serie di 10 riquadri bronzei dorati, raffiguranti scene
dell'Antico Testamento. Dalla
Alluvione di Firenze
del 1966 i rilievi originali sono custoditi al
Museo dell'Opera del Duomo. Del Battistero si ammirino anche
i mosaici su fondo dorato della cupola, iniziati nel 1270 e
completati un secolo dopo (sono opere di grandi maestri italiani
come Cimabue e l'anonimo Maestro della Maddalena,
artista dell'epoca tutt'oggi sconosciuto).
 Il
Battistero, dedicato al patrono della città San Giovanni
Battista, ha origini antichissime ma incerte. Dagli
scavi effettuati nel suo perimetro risulta fondato su
costruzioni romane del I secolo d.C. Si ritiene che la sua
struttura risalga al IV secolo, mentre l'aspetto esterno,
pur includendo motivi paleocristiani, si fa risalire ad
epoca romanica. L'edificio che un tempo si alzava sopra una
gradinata è a pianta ottagonale interamente rivestito di
marmo bianco e verde di Prato. L'attico sovrapposto alla
seconda trabeazione, con la copertura a piramide che
nasconde la cupola e culmina nella lanterna sovrastata da
una sfera dorata con la croce, fu aggiunto nel secolo XIII.
Le strutture architettoniche risultano alleggerite
dall'originale partito decorativo tipico dell'architettura
romanica fiorentina, ispirata a chiarezza e linearità
classicheggianti. Nel corso di importanti ristrutturazioni
effettuate nei primi anni del XIII secolo, a spese della
Corporazione dei Mercanti della Lana, venne chiusa la porta
principale a ponente ove fu eretta l'abside quadrata o
tribuna detta "scarsella". Il
Battistero, dedicato al patrono della città San Giovanni
Battista, ha origini antichissime ma incerte. Dagli
scavi effettuati nel suo perimetro risulta fondato su
costruzioni romane del I secolo d.C. Si ritiene che la sua
struttura risalga al IV secolo, mentre l'aspetto esterno,
pur includendo motivi paleocristiani, si fa risalire ad
epoca romanica. L'edificio che un tempo si alzava sopra una
gradinata è a pianta ottagonale interamente rivestito di
marmo bianco e verde di Prato. L'attico sovrapposto alla
seconda trabeazione, con la copertura a piramide che
nasconde la cupola e culmina nella lanterna sovrastata da
una sfera dorata con la croce, fu aggiunto nel secolo XIII.
Le strutture architettoniche risultano alleggerite
dall'originale partito decorativo tipico dell'architettura
romanica fiorentina, ispirata a chiarezza e linearità
classicheggianti. Nel corso di importanti ristrutturazioni
effettuate nei primi anni del XIII secolo, a spese della
Corporazione dei Mercanti della Lana, venne chiusa la porta
principale a ponente ove fu eretta l'abside quadrata o
tribuna detta "scarsella".
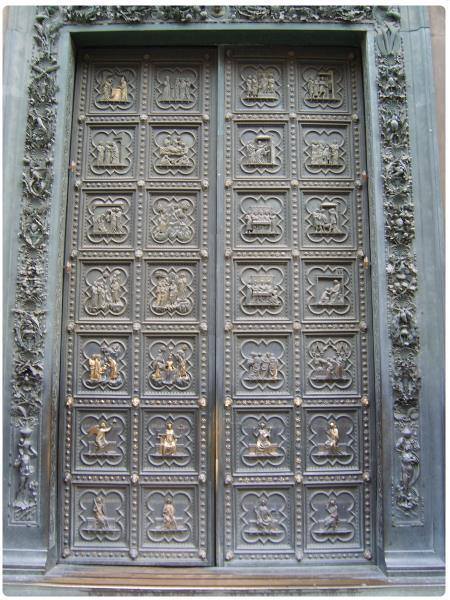 Ulteriore
motivo di interesse di questo monumento è costituito dalle
porte di bronzo che si aprono su tre lati. La più antica è
là Porta Sud verso la Loggia del Bigallo, eseguita da
Andrea Pisano che ne ultimò la modellatura in cera
nel 1330 e venne fusa dal veneziano Leonardo d'Avanzo.
Collocata originariamente sul lato che fronteggia il Duomo,
nel 1338 fu trasferita nella sede attuale per lasciare il
posto alla Porta del Paradiso del Ghiberti. Le
imposte sono ripartite in ventotto riquadri che incorniciano
le formelle gotiche quadrilobate con Storie del Battista,
l'Umiltà, Virtù cardinali e teologali. Il fregio che
incornicia la porta, a motivi vergetali e animali, con
testine putti, di carattere rinascimentale, fu eseguito da
Vittorio Ghiberti (figlio di Lorenzo). Nell'edicola
posta sopra la trabeazione si trovano le statue bronzee
del Battista, del suo carnefice e di Salomè, opera di
Vincenzo Danti. Ulteriore
motivo di interesse di questo monumento è costituito dalle
porte di bronzo che si aprono su tre lati. La più antica è
là Porta Sud verso la Loggia del Bigallo, eseguita da
Andrea Pisano che ne ultimò la modellatura in cera
nel 1330 e venne fusa dal veneziano Leonardo d'Avanzo.
Collocata originariamente sul lato che fronteggia il Duomo,
nel 1338 fu trasferita nella sede attuale per lasciare il
posto alla Porta del Paradiso del Ghiberti. Le
imposte sono ripartite in ventotto riquadri che incorniciano
le formelle gotiche quadrilobate con Storie del Battista,
l'Umiltà, Virtù cardinali e teologali. Il fregio che
incornicia la porta, a motivi vergetali e animali, con
testine putti, di carattere rinascimentale, fu eseguito da
Vittorio Ghiberti (figlio di Lorenzo). Nell'edicola
posta sopra la trabeazione si trovano le statue bronzee
del Battista, del suo carnefice e di Salomè, opera di
Vincenzo Danti.
 La
Porta Nord è la prima delle due eseguite da
Lorenzo Ghiberti con la collaborazione di Paolo
Uccello e Bernardo Cennini negli anni 1403-1424.
In essa il maestro, pur adeguandosi, secondo il gusto del
momento, al modello di Andrea Pisano, attuò una
interpretazione decorativa nuova e personale, secondo i
canoni dei primo Rinascimento. L'osservazione naturalistica
si sviluppa ulteriormente negli stipiti e nelle cornici
nelle quali sono inserite le testine di preciso significato
fisionomico, tra le quali figura anche l'autoritratto del
Ghiberti. Anche questa porta come quella di Andrea Pisano è
suddivisa in ventotto formelle con Storie del Nuovo
testamento, gli Evangelisti e i Dottori dello Chiesa. La
Porta Nord è la prima delle due eseguite da
Lorenzo Ghiberti con la collaborazione di Paolo
Uccello e Bernardo Cennini negli anni 1403-1424.
In essa il maestro, pur adeguandosi, secondo il gusto del
momento, al modello di Andrea Pisano, attuò una
interpretazione decorativa nuova e personale, secondo i
canoni dei primo Rinascimento. L'osservazione naturalistica
si sviluppa ulteriormente negli stipiti e nelle cornici
nelle quali sono inserite le testine di preciso significato
fisionomico, tra le quali figura anche l'autoritratto del
Ghiberti. Anche questa porta come quella di Andrea Pisano è
suddivisa in ventotto formelle con Storie del Nuovo
testamento, gli Evangelisti e i Dottori dello Chiesa.
 La
Porta Est, che per tradizione si dice definita da
Michelangelo "del Paradiso" è il capolavoro assoluto di
Lorenzo Ghiberti che, superati i canoni tardogotici, opera
in piena libertà in ambito rinascimentale. La porta in
bronzo dorato venne commissionata all'artista dall'Arte
dei Mercanti o di Calimala nel 1425, 'come a voler
identificare nel battistero lo scrigno simbolico delle
grandi tradizioni religiose e civili della città e
l'espressione del proprio potere. Le dieci formelle i cui
soggetti biblici furono definiti dall'umanista Leonardo
Bruni, impegnarono l'artista per ventisette anni
nonostante la collaborazione di numerosi aiuti tra i quali
Benozzo Gozzoli e Michelozzo, nel periodo
compreso tra il 1425 e il 1452. Alla committenza dell'Arte
di Calimala si deve anche il prezioso altare d'argento
per il battistero conservato nel Museo dell'Opera del
Duomo, iniziato nel 1336 e alla cui realizzazione
presero parte i più grandi scultori e orafi del
Quattrocento, tra i quali Michelozzo, Bernardo
Cennini, Antonio del Pollaiolo e Andrea del
Verrocchio. La
Porta Est, che per tradizione si dice definita da
Michelangelo "del Paradiso" è il capolavoro assoluto di
Lorenzo Ghiberti che, superati i canoni tardogotici, opera
in piena libertà in ambito rinascimentale. La porta in
bronzo dorato venne commissionata all'artista dall'Arte
dei Mercanti o di Calimala nel 1425, 'come a voler
identificare nel battistero lo scrigno simbolico delle
grandi tradizioni religiose e civili della città e
l'espressione del proprio potere. Le dieci formelle i cui
soggetti biblici furono definiti dall'umanista Leonardo
Bruni, impegnarono l'artista per ventisette anni
nonostante la collaborazione di numerosi aiuti tra i quali
Benozzo Gozzoli e Michelozzo, nel periodo
compreso tra il 1425 e il 1452. Alla committenza dell'Arte
di Calimala si deve anche il prezioso altare d'argento
per il battistero conservato nel Museo dell'Opera del
Duomo, iniziato nel 1336 e alla cui realizzazione
presero parte i più grandi scultori e orafi del
Quattrocento, tra i quali Michelozzo, Bernardo
Cennini, Antonio del Pollaiolo e Andrea del
Verrocchio.
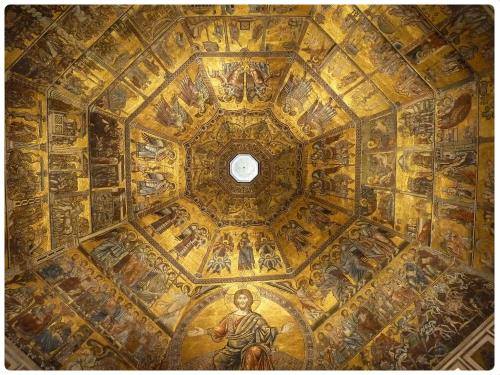 La
struttura interna dell'edificio, in eviden-te rapporto con
quella esterna, è costituita dall'ampia cupola a otto
spicchi impostata su una struttura propria formata da un
ordine di colonne architravate e da un angusto matroneo di
tipologia ricorrente nelle costruzioni tardo romane e
paleocristiane. La cupola è tutta rivestita di mosaici con
temi biblici e Storie del Battista e di Cristo, che
furono eseguiti, tra la prima metà del XIII secolo e la
terza decade del successivo, da mosaicisti veneti che però
si avvalsero anche dei cartoni di artisti fiorentini quali
il Maestro della Maddalena e Coppo di Marcovaldo.
Tra le opere più importanti conservate al-I interno del
battistero, oltre al fonte battesimale marmoreo di scuola
pisana, si segnalano il sepolcro del cardinale
Baldassarre Cossa, l'antipapa Giovanni XXIII, di
Donatello e Michelozzo, e una statua lignea
della Maddalena opera tarda di Donatello, attualmente in
deposito presso il Nuseo dell'Opera del Duomo. La
struttura interna dell'edificio, in eviden-te rapporto con
quella esterna, è costituita dall'ampia cupola a otto
spicchi impostata su una struttura propria formata da un
ordine di colonne architravate e da un angusto matroneo di
tipologia ricorrente nelle costruzioni tardo romane e
paleocristiane. La cupola è tutta rivestita di mosaici con
temi biblici e Storie del Battista e di Cristo, che
furono eseguiti, tra la prima metà del XIII secolo e la
terza decade del successivo, da mosaicisti veneti che però
si avvalsero anche dei cartoni di artisti fiorentini quali
il Maestro della Maddalena e Coppo di Marcovaldo.
Tra le opere più importanti conservate al-I interno del
battistero, oltre al fonte battesimale marmoreo di scuola
pisana, si segnalano il sepolcro del cardinale
Baldassarre Cossa, l'antipapa Giovanni XXIII, di
Donatello e Michelozzo, e una statua lignea
della Maddalena opera tarda di Donatello, attualmente in
deposito presso il Nuseo dell'Opera del Duomo.
Battistero
Piazza del Duomo
Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione
totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto
e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
Dove si trova?
Ostelli Firenze
Ostelli Italia
Auberges de Jeunesse
Italie
Hotel Firenze
Carte de Florance
Karte von Florenz
Mapa Florencia
Map of Florence
Carte de la Toscane
Karte von Toskana
Mapa Toscana
Map of Tuscany
Carte d'Italie
Karte von Italien
Mapa Italia
Map of Italy |
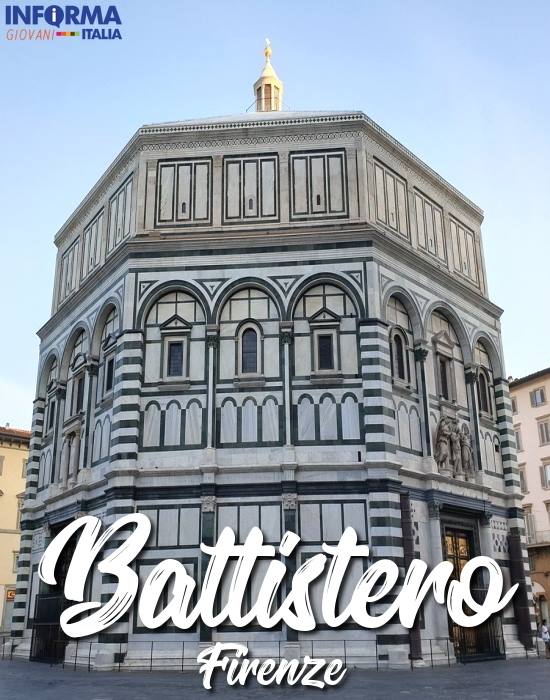

 Quelle sud erano state progettate 65 anni prima da
Andrea Pisano.
Tra altri illustri partecipanti (tra cui Donatello e
Brunelleschi)
fu scelto Lorenzo Ghiberti, le cui porte (est e nord)
sono probabilmente le più famose. Tra queste si apprezza in
particolare quella est, nota anche come Porta del Paradiso
(così come inizialmente chiamata dal Michelangelo), formata
da una serie di 10 riquadri bronzei dorati, raffiguranti scene
dell'Antico Testamento. Dalla
Quelle sud erano state progettate 65 anni prima da
Andrea Pisano.
Tra altri illustri partecipanti (tra cui Donatello e
Brunelleschi)
fu scelto Lorenzo Ghiberti, le cui porte (est e nord)
sono probabilmente le più famose. Tra queste si apprezza in
particolare quella est, nota anche come Porta del Paradiso
(così come inizialmente chiamata dal Michelangelo), formata
da una serie di 10 riquadri bronzei dorati, raffiguranti scene
dell'Antico Testamento. Dalla
 Il
Battistero, dedicato al patrono della città San Giovanni
Battista, ha origini antichissime ma incerte. Dagli
scavi effettuati nel suo perimetro risulta fondato su
costruzioni romane del I secolo d.C. Si ritiene che la sua
struttura risalga al IV secolo, mentre l'aspetto esterno,
pur includendo motivi paleocristiani, si fa risalire ad
epoca romanica. L'edificio che un tempo si alzava sopra una
gradinata è a pianta ottagonale interamente rivestito di
marmo bianco e verde di Prato. L'attico sovrapposto alla
seconda trabeazione, con la copertura a piramide che
nasconde la cupola e culmina nella lanterna sovrastata da
una sfera dorata con la croce, fu aggiunto nel secolo XIII.
Le strutture architettoniche risultano alleggerite
dall'originale partito decorativo tipico dell'architettura
romanica fiorentina, ispirata a chiarezza e linearità
classicheggianti. Nel corso di importanti ristrutturazioni
effettuate nei primi anni del XIII secolo, a spese della
Corporazione dei Mercanti della Lana, venne chiusa la porta
principale a ponente ove fu eretta l'abside quadrata o
tribuna detta "scarsella".
Il
Battistero, dedicato al patrono della città San Giovanni
Battista, ha origini antichissime ma incerte. Dagli
scavi effettuati nel suo perimetro risulta fondato su
costruzioni romane del I secolo d.C. Si ritiene che la sua
struttura risalga al IV secolo, mentre l'aspetto esterno,
pur includendo motivi paleocristiani, si fa risalire ad
epoca romanica. L'edificio che un tempo si alzava sopra una
gradinata è a pianta ottagonale interamente rivestito di
marmo bianco e verde di Prato. L'attico sovrapposto alla
seconda trabeazione, con la copertura a piramide che
nasconde la cupola e culmina nella lanterna sovrastata da
una sfera dorata con la croce, fu aggiunto nel secolo XIII.
Le strutture architettoniche risultano alleggerite
dall'originale partito decorativo tipico dell'architettura
romanica fiorentina, ispirata a chiarezza e linearità
classicheggianti. Nel corso di importanti ristrutturazioni
effettuate nei primi anni del XIII secolo, a spese della
Corporazione dei Mercanti della Lana, venne chiusa la porta
principale a ponente ove fu eretta l'abside quadrata o
tribuna detta "scarsella". 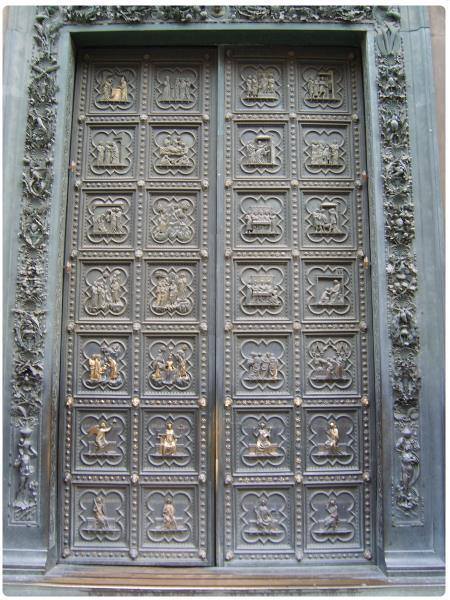 Ulteriore
motivo di interesse di questo monumento è costituito dalle
porte di bronzo che si aprono su tre lati. La più antica è
là Porta Sud verso la Loggia del Bigallo, eseguita da
Andrea Pisano che ne ultimò la modellatura in cera
nel 1330 e venne fusa dal veneziano Leonardo d'Avanzo.
Collocata originariamente sul lato che fronteggia il Duomo,
nel 1338 fu trasferita nella sede attuale per lasciare il
posto alla Porta del Paradiso del Ghiberti. Le
imposte sono ripartite in ventotto riquadri che incorniciano
le formelle gotiche quadrilobate con Storie del Battista,
l'Umiltà, Virtù cardinali e teologali. Il fregio che
incornicia la porta, a motivi vergetali e animali, con
testine putti, di carattere rinascimentale, fu eseguito da
Vittorio Ghiberti (figlio di Lorenzo). Nell'edicola
posta sopra la trabeazione si trovano le statue bronzee
del Battista, del suo carnefice e di Salomè, opera di
Vincenzo Danti.
Ulteriore
motivo di interesse di questo monumento è costituito dalle
porte di bronzo che si aprono su tre lati. La più antica è
là Porta Sud verso la Loggia del Bigallo, eseguita da
Andrea Pisano che ne ultimò la modellatura in cera
nel 1330 e venne fusa dal veneziano Leonardo d'Avanzo.
Collocata originariamente sul lato che fronteggia il Duomo,
nel 1338 fu trasferita nella sede attuale per lasciare il
posto alla Porta del Paradiso del Ghiberti. Le
imposte sono ripartite in ventotto riquadri che incorniciano
le formelle gotiche quadrilobate con Storie del Battista,
l'Umiltà, Virtù cardinali e teologali. Il fregio che
incornicia la porta, a motivi vergetali e animali, con
testine putti, di carattere rinascimentale, fu eseguito da
Vittorio Ghiberti (figlio di Lorenzo). Nell'edicola
posta sopra la trabeazione si trovano le statue bronzee
del Battista, del suo carnefice e di Salomè, opera di
Vincenzo Danti. La
Porta Nord è la prima delle due eseguite da
Lorenzo Ghiberti con la collaborazione di Paolo
Uccello e Bernardo Cennini negli anni 1403-1424.
In essa il maestro, pur adeguandosi, secondo il gusto del
momento, al modello di Andrea Pisano, attuò una
interpretazione decorativa nuova e personale, secondo i
canoni dei primo Rinascimento. L'osservazione naturalistica
si sviluppa ulteriormente negli stipiti e nelle cornici
nelle quali sono inserite le testine di preciso significato
fisionomico, tra le quali figura anche l'autoritratto del
Ghiberti. Anche questa porta come quella di Andrea Pisano è
suddivisa in ventotto formelle con Storie del Nuovo
testamento, gli Evangelisti e i Dottori dello Chiesa.
La
Porta Nord è la prima delle due eseguite da
Lorenzo Ghiberti con la collaborazione di Paolo
Uccello e Bernardo Cennini negli anni 1403-1424.
In essa il maestro, pur adeguandosi, secondo il gusto del
momento, al modello di Andrea Pisano, attuò una
interpretazione decorativa nuova e personale, secondo i
canoni dei primo Rinascimento. L'osservazione naturalistica
si sviluppa ulteriormente negli stipiti e nelle cornici
nelle quali sono inserite le testine di preciso significato
fisionomico, tra le quali figura anche l'autoritratto del
Ghiberti. Anche questa porta come quella di Andrea Pisano è
suddivisa in ventotto formelle con Storie del Nuovo
testamento, gli Evangelisti e i Dottori dello Chiesa.  La
Porta Est, che per tradizione si dice definita da
Michelangelo "del Paradiso" è il capolavoro assoluto di
Lorenzo Ghiberti che, superati i canoni tardogotici, opera
in piena libertà in ambito rinascimentale. La porta in
bronzo dorato venne commissionata all'artista dall'Arte
dei Mercanti o di Calimala nel 1425, 'come a voler
identificare nel battistero lo scrigno simbolico delle
grandi tradizioni religiose e civili della città e
l'espressione del proprio potere. Le dieci formelle i cui
soggetti biblici furono definiti dall'umanista Leonardo
Bruni, impegnarono l'artista per ventisette anni
nonostante la collaborazione di numerosi aiuti tra i quali
Benozzo Gozzoli e Michelozzo, nel periodo
compreso tra il 1425 e il 1452. Alla committenza dell'Arte
di Calimala si deve anche il prezioso altare d'argento
per il battistero conservato nel Museo dell'Opera del
Duomo, iniziato nel 1336 e alla cui realizzazione
presero parte i più grandi scultori e orafi del
Quattrocento, tra i quali Michelozzo, Bernardo
Cennini, Antonio del Pollaiolo e Andrea del
Verrocchio.
La
Porta Est, che per tradizione si dice definita da
Michelangelo "del Paradiso" è il capolavoro assoluto di
Lorenzo Ghiberti che, superati i canoni tardogotici, opera
in piena libertà in ambito rinascimentale. La porta in
bronzo dorato venne commissionata all'artista dall'Arte
dei Mercanti o di Calimala nel 1425, 'come a voler
identificare nel battistero lo scrigno simbolico delle
grandi tradizioni religiose e civili della città e
l'espressione del proprio potere. Le dieci formelle i cui
soggetti biblici furono definiti dall'umanista Leonardo
Bruni, impegnarono l'artista per ventisette anni
nonostante la collaborazione di numerosi aiuti tra i quali
Benozzo Gozzoli e Michelozzo, nel periodo
compreso tra il 1425 e il 1452. Alla committenza dell'Arte
di Calimala si deve anche il prezioso altare d'argento
per il battistero conservato nel Museo dell'Opera del
Duomo, iniziato nel 1336 e alla cui realizzazione
presero parte i più grandi scultori e orafi del
Quattrocento, tra i quali Michelozzo, Bernardo
Cennini, Antonio del Pollaiolo e Andrea del
Verrocchio. 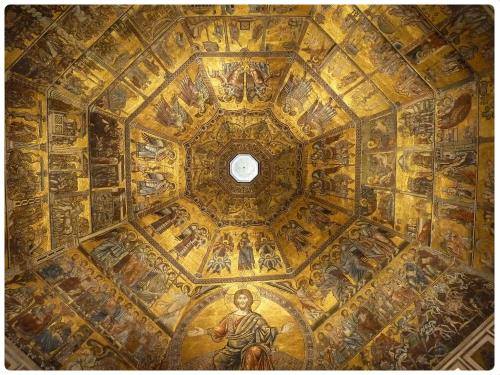 La
struttura interna dell'edificio, in eviden-te rapporto con
quella esterna, è costituita dall'ampia cupola a otto
spicchi impostata su una struttura propria formata da un
ordine di colonne architravate e da un angusto matroneo di
tipologia ricorrente nelle costruzioni tardo romane e
paleocristiane. La cupola è tutta rivestita di mosaici con
temi biblici e Storie del Battista e di Cristo, che
furono eseguiti, tra la prima metà del XIII secolo e la
terza decade del successivo, da mosaicisti veneti che però
si avvalsero anche dei cartoni di artisti fiorentini quali
il Maestro della Maddalena e Coppo di Marcovaldo.
Tra le opere più importanti conservate al-I interno del
battistero, oltre al fonte battesimale marmoreo di scuola
pisana, si segnalano il sepolcro del cardinale
Baldassarre Cossa, l'antipapa Giovanni XXIII, di
Donatello e Michelozzo, e una statua lignea
della Maddalena opera tarda di Donatello, attualmente in
deposito presso il Nuseo dell'Opera del Duomo.
La
struttura interna dell'edificio, in eviden-te rapporto con
quella esterna, è costituita dall'ampia cupola a otto
spicchi impostata su una struttura propria formata da un
ordine di colonne architravate e da un angusto matroneo di
tipologia ricorrente nelle costruzioni tardo romane e
paleocristiane. La cupola è tutta rivestita di mosaici con
temi biblici e Storie del Battista e di Cristo, che
furono eseguiti, tra la prima metà del XIII secolo e la
terza decade del successivo, da mosaicisti veneti che però
si avvalsero anche dei cartoni di artisti fiorentini quali
il Maestro della Maddalena e Coppo di Marcovaldo.
Tra le opere più importanti conservate al-I interno del
battistero, oltre al fonte battesimale marmoreo di scuola
pisana, si segnalano il sepolcro del cardinale
Baldassarre Cossa, l'antipapa Giovanni XXIII, di
Donatello e Michelozzo, e una statua lignea
della Maddalena opera tarda di Donatello, attualmente in
deposito presso il Nuseo dell'Opera del Duomo.