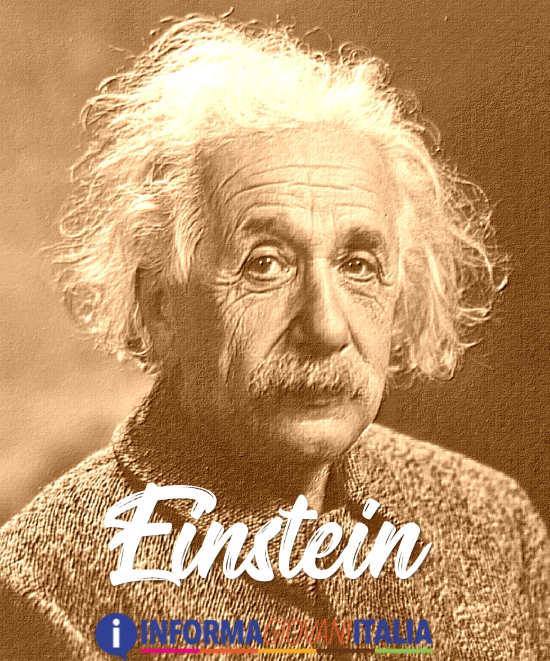|
Sei
qui: Biografie >
Albert Einstein
- Biografia del genio per antonomasia
di Massimo Serra
Quello che
oggi viene giustamente ritenuto uno dei geni della scienza moderna, Albert Einstein,
fu un bambino da qualcuno considerato ritardato, lento nel parlare e, almeno in
apparenza, di comprendonio, sul cui sviluppo mentale i genitori nutrirono, per
qualche tempo, serie apprensioni. Quando nacque, impressionata dalla sua testa
straordinariamente grossa e appuntita, la madre temette di avere partorito un
essere deforme.
Non molto diversa, secondo la sorella, fu la reazione della nonna, che
trovandosi per la prima volta davanti al neonato gli palpò sbalordita il testone
esclamando: "Ma com’è grosso! È troppo grosso!".
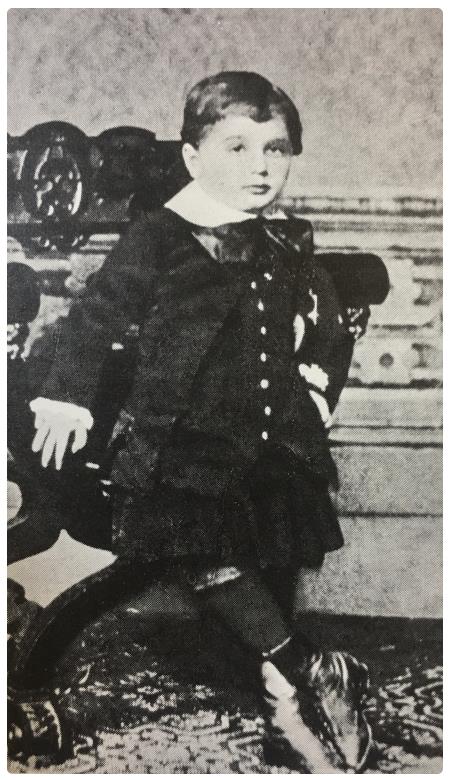 Fino
a tre anni non disse una parola, dai tre ai sette stentò a esprimersi — ripeteva
tutto ciò che gli veniva detto, "anche quando si trattava di frasi
comunissime" — e solo dopo i sette anni cominciò a parlare normalmente.
Molto preciso e meticoloso (riusciva a costruire perfetti castelli di carta alti
fino a quattordici piani), era un bambino bizzoso e irascibile. Gli accessi
d’ira lo rendevano terreo in viso, mentre la punta del naso perdeva ogni colore.
Così dovette apparire, a cinque anni, alla maestra di musica che gli insegnava a
suonare il violino, quando le tirò addosso uno sgabello; e quando, per fortuna
senza riuscirvi, tentò di scoperchiarle la scatola cranica con una paletta da
spiaggia. Fino
a tre anni non disse una parola, dai tre ai sette stentò a esprimersi — ripeteva
tutto ciò che gli veniva detto, "anche quando si trattava di frasi
comunissime" — e solo dopo i sette anni cominciò a parlare normalmente.
Molto preciso e meticoloso (riusciva a costruire perfetti castelli di carta alti
fino a quattordici piani), era un bambino bizzoso e irascibile. Gli accessi
d’ira lo rendevano terreo in viso, mentre la punta del naso perdeva ogni colore.
Così dovette apparire, a cinque anni, alla maestra di musica che gli insegnava a
suonare il violino, quando le tirò addosso uno sgabello; e quando, per fortuna
senza riuscirvi, tentò di scoperchiarle la scatola cranica con una paletta da
spiaggia.
Eppure questo "bambino cattivo", che sembrava precocemente avviato a diventare
qualcosa di simile a un delinquente giovanile, divenne, coll'andar del tempo,
uno degli uomini più buoni, disinteressati e generosi della terra. A dieci anni
Einstein stentava a eseguire le
più elementari operazioni aritmetiche (come, per esempio le addizioni). Da lui, disse uno dei suoi insegnanti ai genitori,
non c’era da "aspettarsi
granché"; quindici anni dopo Albert avrebbe elaborato una teoria che, ancora oggi,
poche persone al mondo possono affermare di aver capito fino in fondo, e che
allora rappresentò, nel campo della fisica, l’equivalente di una rivoluzione.
 Nella scuola di Monaco
frequentata da Einstein negli anni intorno al 1890 vigeva una disciplina ferrea, che aveva lo scopo di preparare i ragazzi al servizio militare. Per la
legge tedesca, infatti, chiunque non fosse emigrato prima di compiere
diciassette anni avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di leva. Per non essere
chiamato sotto le armi — raccolta la sorella — Albert si procurò un certificato
medico e partì per
Milano, dove suo padre aveva aperto una fabbrichetta di
apparecchiature elettriche, un’altra delle sue tante imprese commerciali fallite
o destinate a fallire. Nella scuola di Monaco
frequentata da Einstein negli anni intorno al 1890 vigeva una disciplina ferrea, che aveva lo scopo di preparare i ragazzi al servizio militare. Per la
legge tedesca, infatti, chiunque non fosse emigrato prima di compiere
diciassette anni avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di leva. Per non essere
chiamato sotto le armi — raccolta la sorella — Albert si procurò un certificato
medico e partì per
Milano, dove suo padre aveva aperto una fabbrichetta di
apparecchiature elettriche, un’altra delle sue tante imprese commerciali fallite
o destinate a fallire.
 L’esperienza scolastica tedesca (con le sue nozioni
impartite a suon di bacchettate sulle dita) aveva vaccinato contro il virus del
militarismo il giovane Einstein, che
per tutta la vita sarebbe rimasto un convinto pacifista. Eppure fu proprio
questo pacifista a firmare nell'agosto del 1939, con la storica richiesta al presidente degli Stati
Uniti, Roosevelt, l’atto di nascita della bomba atomica e in pratica dell’era nucleare, e a
mettere in moto il sinistro meccanismo che, sei anni dopo, avrebbe distrutto due
grandi città giapponesi. Nella lettera allarmava il presidente sulla imminenza
della realizzazione della reazione a catena e del possibile impiego di tale
reazione nelle bombe da parte dei tedeschi. Questa lettera è considerata
l'inizio del progetto Manhattan, progetto che portò alla realizzazione della
bomba atomica. L’esperienza scolastica tedesca (con le sue nozioni
impartite a suon di bacchettate sulle dita) aveva vaccinato contro il virus del
militarismo il giovane Einstein, che
per tutta la vita sarebbe rimasto un convinto pacifista. Eppure fu proprio
questo pacifista a firmare nell'agosto del 1939, con la storica richiesta al presidente degli Stati
Uniti, Roosevelt, l’atto di nascita della bomba atomica e in pratica dell’era nucleare, e a
mettere in moto il sinistro meccanismo che, sei anni dopo, avrebbe distrutto due
grandi città giapponesi. Nella lettera allarmava il presidente sulla imminenza
della realizzazione della reazione a catena e del possibile impiego di tale
reazione nelle bombe da parte dei tedeschi. Questa lettera è considerata
l'inizio del progetto Manhattan, progetto che portò alla realizzazione della
bomba atomica.
Figlio di ebrei, nato a
Ulm il 14 marzo 1879, ma vissuto a Monaco (roccaforte non soltanto del
militarismo ma anche del cattolicesimo tedesco) da uno a quindici anni, il
piccolo Albert frequentò le elementari presso un istituto cattolico, al quale i
genitori (non particolarmente osservanti) lo avevano iscritto per pura e
semplice comodità (era vicino a casa). Unico alunno ebreo della sua classe, non
poté che inorridire quando l’insegnante di religione, brandendo un grosso chiodo
arrugginito e mostrandolo alla scolaresca, annunciò enfaticamente: "Ecco uno
dei chiodi che gli ebrei hanno usato per crocifiggere Gesù!". E forse fu questo
grottesco episodio, che lasciò un’impronta indelebile sul piccolo Einstein,
all’origine della decisione, presa a soli quattordici anni, di uscire una
volta per sempre dalla comunità israelitica e di non appartenere mai più a
nessuna confessione religiosa. Tuttavia pur essendo contrario alla
fondazione di uno stato ebraico, Einstein appoggiò così calorosamente la causa da vedersi addirittura proporre la prima
presidenza di Israele.
 Quest’uomo contraddittorio disse poi
che, se
avesse saputo in anticipo dove le sue scoperte lo avrebbero condotto, non soltanto
non avrebbe mai scritto la famosa lettera a Roosevelt, ma sarebbe stato ben lieto di "fare
lo spazzino". Quest’uomo contraddittorio disse poi
che, se
avesse saputo in anticipo dove le sue scoperte lo avrebbero condotto, non soltanto
non avrebbe mai scritto la famosa lettera a Roosevelt, ma sarebbe stato ben lieto di "fare
lo spazzino".
L'interesse più vivo di Einstein era la fisica e un oggetto e due persone,
contribuirono a indirizzarlo.
L’oggetto era una bussola, donatagli dal padre all’età di quattro anni, in occasione di una
malattia, che lo scosse da
un’apatia da tutti fino a quel momento concordemente ritenuta un sintomo di
deficienza mentale e che, spingendolo a chiedersi il motivo per cui l’ago
magnetico puntava sempre nella stessa direzione, rappresentò il suo primo
fecondo e felice incontro con la scienza. Le persone che invece influirono sulla
sua passione per la fisica furono lo zio Jakob, il
fratello ingegnere e socio di suo padre, e uno studente russo che, in ossequio a
un’antica tradizione, la famiglia Einstein ospitava una volta alla settimana. Il
primo, scoperte le particolari attitudini del nipote per la matematica, gli
impartì tra le mura domestiche, in forma di attraenti rompicapo ben diversi dai
normali problemi scolastici, le prime nozioni di algebra (suscitando, per così
dire, una reazione a catena che non si sarebbe più interrotta). Il secondo frequentò casa Einstein per cinque anni, stringendo amicizia col ragazzo e
facendogli leggere vari libri di divulgazione scientifica. Quando il piccolo
Albert compì dodici anni gli regalò un manuale di geometria (oggi conservato all'Università
di Princeton con le note a margine scritte da Einstein bambino) che ebbe il potere
di suscitare in lui una vera e propria passione per la matematica.
 Scartato il
violino, che fino a quel momento, dopo le comprensibili resistenze iniziali, era
sembrato l'unico interesse della sua vita infantile ("Albert va così male a
scuola! " scriveva desolato il padre a un amico. "Non farebbe altro che
suonare. Credo proprio che non riusciremo a cavare da lui niente di buono"),
due anni dopo, a quattordici anni, aveva già assimilato l’algebra, la
geometria analitica, il calcolo differenziale e integrale (roba, questa, da
università). Il bambino "con qualche ritardo" aveva abbondantemente riguadagnato il
tempo perduto. Scartato il
violino, che fino a quel momento, dopo le comprensibili resistenze iniziali, era
sembrato l'unico interesse della sua vita infantile ("Albert va così male a
scuola! " scriveva desolato il padre a un amico. "Non farebbe altro che
suonare. Credo proprio che non riusciremo a cavare da lui niente di buono"),
due anni dopo, a quattordici anni, aveva già assimilato l’algebra, la
geometria analitica, il calcolo differenziale e integrale (roba, questa, da
università). Il bambino "con qualche ritardo" aveva abbondantemente riguadagnato il
tempo perduto.
 Né a Milano né a
Pavia gli affari
del padre di Albert, Hermann, prosperarono. Allora la famiglia, preoccupata per l’avvenire del
figlio, decise di mandarlo al
Politecnico di Zurigo. Ma per venire in
Italia il ragazzo aveva interrotto gli studi secondari, e in Svizzera dovette
sottoporsi a un esame di ammissione. In matematica e fisica mostrò, com’era
prevedibile, una preparazione tale da stupire gli esaminatori. Nelle altre
materie, invece, fu un disastro, e la commissione lo bocciò. Solo ricorrendo a
uno stratagemma (su consiglio dello stesso direttore del politecnico, colpito
dalle eccezionali doti matematiche del candidato respinto, Albert frequentò per
un anno la scuola svizzera di Aarau, che gli rilasciò un diploma di
abilitazione) poté quindi aggirare l’ostacolo e iscriversi alla facoltà di Fisica e Matematica del politecnico di Zurigo. Né a Milano né a
Pavia gli affari
del padre di Albert, Hermann, prosperarono. Allora la famiglia, preoccupata per l’avvenire del
figlio, decise di mandarlo al
Politecnico di Zurigo. Ma per venire in
Italia il ragazzo aveva interrotto gli studi secondari, e in Svizzera dovette
sottoporsi a un esame di ammissione. In matematica e fisica mostrò, com’era
prevedibile, una preparazione tale da stupire gli esaminatori. Nelle altre
materie, invece, fu un disastro, e la commissione lo bocciò. Solo ricorrendo a
uno stratagemma (su consiglio dello stesso direttore del politecnico, colpito
dalle eccezionali doti matematiche del candidato respinto, Albert frequentò per
un anno la scuola svizzera di Aarau, che gli rilasciò un diploma di
abilitazione) poté quindi aggirare l’ostacolo e iscriversi alla facoltà di Fisica e Matematica del politecnico di Zurigo.
Per quattro anni (dai diciassette ai ventuno) Einstein studiò furiosamente,
spaziando da Galileo a
Maxwell, da Keplero e Newton a Kirchoff e Hertz. Lesse i
filosofi e gli evoluzionisti, Darwin, Hume, Kant, Spinoza. Al
Caffè Metropole sulla riva del fiume Limmat a Zurigo,
conobbe una studentessa di matematica, Mileva Maric, di lingua serba e
nazionalità ungherese, che aveva lasciato il suo paese per sfuggire alla
dominazione magiara. Era una donna intelligente, dal carattere forte che divenne
sua compagna.
 Laureatosi nel 1900, Einstein cercò di aggiudicarsi un posto di insegnante di
scuola media che, sperava, gli avrebbe lasciato più tempo per studiare. Nella
domanda d’impiego specificava modestamente di essere in grado di insegnare "anche" la fisica. Scartato, tentò invano di farsi assegnare un posto di
assistente al politecnico di Zurigo. Ma aveva troppi difetti (era ebreo, non
era svizzero, aveva ormai una preparazione superiore a quella della maggior parte
dei suoi professori) per poter sperare di essere preso in considerazione. La
famiglia, d’altronde, non era più in grado di aiutarlo (gli affari paterni
andavano di male in peggio), e per qualche tempo Einstein mangiò poco e dormì in
una stanza miserabile. Poi per fortuna qualcuno lo segnalò al direttore dell’ufficio
brevetti di Berna.
"Che ne sa, lei, di brevetti?" gli chiese quest'ultimo al loro
primo incontro. "Niente" rispose Einstein. Fu una risposta laconica, sincera,
a quanto pare "convincente", visto che fu assunto e nominato capufficio, con uno stipendio
annuo tale da garantirgli un'esistenza più che dignitosa. Laureatosi nel 1900, Einstein cercò di aggiudicarsi un posto di insegnante di
scuola media che, sperava, gli avrebbe lasciato più tempo per studiare. Nella
domanda d’impiego specificava modestamente di essere in grado di insegnare "anche" la fisica. Scartato, tentò invano di farsi assegnare un posto di
assistente al politecnico di Zurigo. Ma aveva troppi difetti (era ebreo, non
era svizzero, aveva ormai una preparazione superiore a quella della maggior parte
dei suoi professori) per poter sperare di essere preso in considerazione. La
famiglia, d’altronde, non era più in grado di aiutarlo (gli affari paterni
andavano di male in peggio), e per qualche tempo Einstein mangiò poco e dormì in
una stanza miserabile. Poi per fortuna qualcuno lo segnalò al direttore dell’ufficio
brevetti di Berna.
"Che ne sa, lei, di brevetti?" gli chiese quest'ultimo al loro
primo incontro. "Niente" rispose Einstein. Fu una risposta laconica, sincera,
a quanto pare "convincente", visto che fu assunto e nominato capufficio, con uno stipendio
annuo tale da garantirgli un'esistenza più che dignitosa.
Onde e corpuscoli
Nel 1901 Albert Einstein si trasferiva a Berna, prendeva la cittadinanza
svizzera e sposava Mileva Maric. Non fu un matrimonio fortunato. Forse i due
coniugi erano troppo presi dai rispettivi interessi scientifici per avere molto
tempo da dedicare ai non facili problemi della vita in comune. In famiglia i
compiti erano divisi, e quando la giovane coppia ebbe il primo figlio,
Hans Albert, Einstein
se ne occupò quanto e forse più della moglie. Il posto all’ufficio brevetti (dove lo scienziato doveva esaminare le invenzioni sottoposte e scrivere per
ognuna di esse una breve relazione) era una pacchia, ed Einstein poteva dedicare
quasi tutto il suo tempo alla ricerca scientifica. Quello stesso anno apparve il suo primo lavoro, uno studio dei fenomeni di
capillarità, seguito, tra il 1902 e il 1904, da altri quattro articoli sulla
teoria cinetica della materia. Ma l'anno più fecondo fu quello successivo. Nel
1905 la rivista scientifica tedesca Annalen der Physik, che aveva già
ospitato i suoi primi contributi, pubblicò i più famosi lavori di Einstein, tra
i quali una ricerca sui moti browniani (caratteristici delle particelle
sospese in un liquido) il cui aspetto più importante consisteva nella conferma
dell’ipotesi atomico-molecolare della struttura della materia, non ancora
generalmente accettata.
 Gli altri lavori del 1905 comprendevano una memoria sull’effetto fotoelettrico
e una ricerca sull'elettrodinamica. Nel documento sull'effetto fotoelettrico
(sviluppo dell'allora recente teoria dei quanti di Max Planck, del 1900) si dimostrava che, accanto all’aspetto
ondulatorio della propagazione
della luce, ce n’era uno corpuscolare e cioè che la luce veniva emessa o
assorbita come una particella (che Einstein chiamò "quanto di luce" o "fotone").
Nella ricerca sull’elettrodinamica dei corpi in moto, che era il suo primo lavoro
nell'ambito della teoria della relatività "speciale" o "ristretta",
lo scienziato dimostrava, in parole povere, che le leggi della meccanica
newtoniana, valide fino a quando i corpi presi in considerazione non superavano
una certa velocità, non potevano più dirsi leggi esatte quando tale velocità si
approssimava a quella della luce. In questo caso le nozioni fondamentali di
spazio e tempo "assoluti", sulle quali posava la dinamica pre-einsteiniana,
venivano meno, e la durata del fenomeno, dipendendo dall’osservatore,
diventava, come lo spazio, una quantità relativa. Gli altri lavori del 1905 comprendevano una memoria sull’effetto fotoelettrico
e una ricerca sull'elettrodinamica. Nel documento sull'effetto fotoelettrico
(sviluppo dell'allora recente teoria dei quanti di Max Planck, del 1900) si dimostrava che, accanto all’aspetto
ondulatorio della propagazione
della luce, ce n’era uno corpuscolare e cioè che la luce veniva emessa o
assorbita come una particella (che Einstein chiamò "quanto di luce" o "fotone").
Nella ricerca sull’elettrodinamica dei corpi in moto, che era il suo primo lavoro
nell'ambito della teoria della relatività "speciale" o "ristretta",
lo scienziato dimostrava, in parole povere, che le leggi della meccanica
newtoniana, valide fino a quando i corpi presi in considerazione non superavano
una certa velocità, non potevano più dirsi leggi esatte quando tale velocità si
approssimava a quella della luce. In questo caso le nozioni fondamentali di
spazio e tempo "assoluti", sulle quali posava la dinamica pre-einsteiniana,
venivano meno, e la durata del fenomeno, dipendendo dall’osservatore,
diventava, come lo spazio, una quantità relativa.
Chiamato a occupare la cattedra di Fisica teorica dell’Università di Zurigo, nel
1909 Einstein (che intanto aveva avuto un altro figlio) lasciò l’ufficio
brevetti di Berna. Il suo nome era già conosciuto in tutto il mondo, ma solo
negli ambienti scientifici e universitari. Si dice che il funzionario al quale
Einstein presentò le dimissioni, motivandole col nuovo incarico che gli era
stato offerto, rosso in faccia gli gridò: "Herr Einstein, non
fate scherzi stupidi! Nessuno potrebbe credere a una simile assurdità".
La vita a Berlino ed
Elsa
La vita accademica di Einstein si spostò ben presto da Zurigo a
Praga
(dove lo scienziato ebbe modo di conoscere Franz Kafka e Max Brod);
da Praga di nuovo a Zurigo ("dove lo sforzo della ricerca scientifica lo
ridusse per settimane intere in uno stato di completa confusione mentale"); infine da Zurigo a
Berlino (dove Einstein
si trasferì alla fine del 1913 per diventare direttore delle ricerche sulla
fisica teorica al nuovissimo Kaiser Wilhelm Institut, membro
dell’Accademia delle scienze di Prussia e professore all’Università di Berlino
).
Berlino, in quegli anni, era una specie di Olimpo intellettuale, dove Einstein
si trovò, non senza una punta di disagio per un uomo dai gusti semplici come i
suoi, gomito a gomito con i più bei nomi della fisica contemporanea: Max
Planck, Gustav L. Hertz, Jacob Franck, Max von Laue.
Gli accordi presi con il Kaiser Wilhelm Institut prevedevano che egli
dedicasse quasi tutto il suo tempo alla ricerca e lo scienziato ne era felice. Nella
capitale tedesca viveva una cugina, Elsa, divisa dal marito e in attesa del
divorzio. Elsa ed Albert erano stati bambini insieme. Molti ricordi affettuosi
li legavano. Finirono per sposarsi, nel 1915, subito dopo la pronuncia delle
rispettive sentenze di divorzio.
La Prima guerra
mondiale, scienziati senza cervello
Lo scoppio della prima guerra mondiale accentuò la diffidenza che Einstein aveva
sempre nutrito per i suoi ex connazionali: "Questi individui biondi e freddi
"
diceva, "mi mettono a disagio. Non hanno la minima comprensione per gli altri". La scienza tedesca si lasciò subito piegare a scopi militari.
Walter H. Nernst (che con Planck aveva invitato Einstein a Berlino) inventò i gas
asfissianti. Fritz Haber realizzò esplosivi particolarmente efficaci. Il
"Manifesto dei Novantatrè" tracciando una preoccupante equazione tra cultura tedesca e militarismo tedesco, fu la goccia che fece traboccare il
vaso. Dopo essersi rifiutato di firmarlo, definendolo "la capitolazione
dell’indipendenza intellettuale dei tedeschi", Einstein sottoscrisse un
contro-manifesto pacifista. Al romanziere Romain Rolland, da lui conosciuto la
questo periodo, disse di aver assistito pieno di sgomento a quel passaggio "dalla follia religiosa alla follia nazionale". E aggiunse:
"Anche gli
scienziati, qui e a casa vostra, li agitano come se qualcuno avesse loro
amputato il cervello".
Il premio Nobel nel
1921, Hitler e la fuga in America
Praticamente isolato, approfittò di quei drammatici anni di guerra per dare una
formulazione definitiva alla Teoria della relatività generale. Il 29 marzo 1919
un’eclisse totale di sole fornì ad alcuni scienziati inglesi l’occasione per
verificarne sperimentalmente un aspetto. "Non si tratta", dichiarava qualche
tempo dopo, a
Londra, il fisico Joseph J. Thomson, "della scoperta di una sola
isola, ma di un intero continente di idee scientifiche. È la più grande scoperta
sulla gravitazione che sia stata fatta da quando Newton enunciò i suoi principi". Nel 1921 l’assegnazione del premio
Nobel per la fisica sanzionava la fama di
Einstein che, dando prova ancora una volta di un assoluto disinteresse per le
cose materiali, si affrettò a versarne una metà
alla prima moglie e l’altra ai poveri di Berlino.
Per qualche anno non fece che viaggiare: tornò in Italia e a Praga, visitò
l’Olanda, l’Austria, gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Francia, il Medio e
l’Estremo Oriente. L’appoggio pubblicamente accordato al sionismo, mentre sulla
Germania si abbatteva una nuova ondata di antisemitismo, gli fruttò velenosi
attacchi sul piano scientifico. Nell’autunno del 1932, pochi mesi prima che
Hitler andasse al potere, Einstein lasciava per sempre la Germania (della quale
era ridiventato cittadino una decina di anni prima) e, dopo un anno trascorso in
Belgio, si trasferiva definitivamente negli Stati Uniti.
La sua opposizione al nazismo fu
immediata e decisa. "Fino a quando mi sarà possibile", disse allorché Hitler
divenne cancelliere, "non risiederò che in un paese dove regnino per tutti i
cittadini la libertà politica, la tolleranza e l’uguaglianza davanti alla legge.
(...) Attualmente queste condizioni non si verificano in Germania". Dopodiché
si dimise dall’Accademia delle scienze di Prussia, a vent’anni giusti dalla sua
ammissione. Tutti i suoi beni rimasti in Germania vennero confiscati, e i suoi
scritti bruciati pubblicamente a Berlino. L’organizzazione nazista, che mise
sulla sua testa una taglia di ventimila marchi, riuscì solo a strappargli un
commento divertito: "Non sapevo che la mia testa valesse tanto!". Quando,
infine, accettò l’offerta dell’Istituto
di Studi Superiori di Princeton, e partì per l’America, i giornali tedeschi
pubblicarono la sua foto con la seguente didascalia: "Einstein. Ha scoperto una
teoria della relatività molto discussa. Fu molto acclamato dalla stampa ebraica
e dall’innocente popolo tedesco, che ringraziò con una menzognera propaganda di
atrocità contro Hitler all’estero. (Non ancora impiccato! )".
A Princeton, nel 1936, Einstein rimase solo. Sconvolta dal dolore per la morte di
una delle due figlie avute dal primo marito, Elsa la seguì nella tomba. Il
vuoto lasciato dalla seconda moglie dello scienziato fu parzialmente riempito
dalla figlia superstite di Elsa che, avendo a sua volta divorziato dal marito,
venne a stabilirsi a Princeton col patrigno; e da Maya Einstein, che nel 1939
raggiunse il fratello negli Stati Uniti. La solitudine, d’altronde,
non doveva pesare allo scienziato, se un giorno, poté dire: "Vivo in quella
solitudine che è penosa durante la giovinezza ma deliziosa nell’età matura". A
Princeton, avvalendosi della collaborazione di vari fisici, tra i quali Leopold Infeld, un polacco che divenne il suo braccio destro, Einstein, proseguì nella
sua critica alla meccanica quantistica e tentò di formulare la cosiddetta "teoria del campo unificato", nell’ambito della quale i fenomeni
elettromagnetici avrebbero dovuto trovare la stessa spiegazione che i fenomeni
gravitazionali trovavano in quello della teoria della relatività. Ma la morte lo
sorprese prima che avesse potuto completare questi studi.
La famosa lettera a Roosevelt, che Einstein scrisse per le insistenze di Eugene Wigner e
Leo Szilard, sbigottiti dalla possibilità che i nazisti costruissero la bomba atomica prima degli americani,
fin per far associare definitivamente il
nome dello scienziato (pacifista fino al midollo) a quello che, fra tutti gli
strumenti di morte, sarebbe stato considerato il re.
L’esplosione di Hiroshima risvegliò in Einstein l’antica avversione per i
militari. "Se avessi saputo che i nazisti non sarebbero riusciti a fabbricare
la bomba prima degli Alleati", disse allora lo scienziato, "mi sarei astenuto da qualsiasi azione".
Ma ormai la frittata era fatta, e da allora, quasi per
farsi perdonare, Albert Einstein dedicò tutta la forza del suo prestigio al
tentativo di sventare il pericolo atomico. "Devo confessare francamente",
scrisse nel 1947, "che la politica estera degli Stati Uniti, dalla fine delle
ostilità, mi ha ricordato, talvolta in maniera irresistibile, l’atteggiamento
della Germania sotto l’imperatore Guglielmo II...".
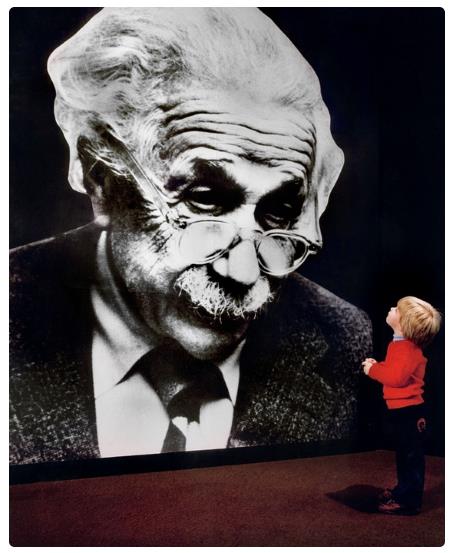 Einstein si batté vigorosamente per convincere inglesi e americani a svelare all’Unione Sovietica il
segreto della bomba atomica, col risultato di essere accusato di tradimento e
filo-comunismo. Si apriva negli Stati Uniti la sinistra parentesi del
maccartismo; Einstein ebbe parole di protesta per la caccia alle streghe
sovversive scatenata dal senatore Joseph MacCarthy, e invitò i colleghi a
rifiutarsi di testimoniare davanti alla famigerata commissione. Nell’aprile del
1945 Einstein abbandonava l'attività scientifica e finì per trascorrere
gli ultimi dieci anni della sua vita sognando un governo mondiale capace di scongiurare la possibilità di
un nuovo catastrofico conflitto. Albert Einstein morì a Princeton, serenamente, il 18 aprile 1955, a 76 anni. Le sue ultime parole furono in
tedesco. Ma l’infermiera che lo assisteva, ,americana, non le capì.
Dopo la morte, il suo pregiatissimo cervello è stato asportato da parte del
medico Thomas Stoltz Harvey che lo fece a fettine e le inviò a studiosi
di tutto il mondo per studiarne i segreti... Einstein si batté vigorosamente per convincere inglesi e americani a svelare all’Unione Sovietica il
segreto della bomba atomica, col risultato di essere accusato di tradimento e
filo-comunismo. Si apriva negli Stati Uniti la sinistra parentesi del
maccartismo; Einstein ebbe parole di protesta per la caccia alle streghe
sovversive scatenata dal senatore Joseph MacCarthy, e invitò i colleghi a
rifiutarsi di testimoniare davanti alla famigerata commissione. Nell’aprile del
1945 Einstein abbandonava l'attività scientifica e finì per trascorrere
gli ultimi dieci anni della sua vita sognando un governo mondiale capace di scongiurare la possibilità di
un nuovo catastrofico conflitto. Albert Einstein morì a Princeton, serenamente, il 18 aprile 1955, a 76 anni. Le sue ultime parole furono in
tedesco. Ma l’infermiera che lo assisteva, ,americana, non le capì.
Dopo la morte, il suo pregiatissimo cervello è stato asportato da parte del
medico Thomas Stoltz Harvey che lo fece a fettine e le inviò a studiosi
di tutto il mondo per studiarne i segreti...
di M Serra per Infomagiovani Italia
Copyright © Informagiovani-italia.com. La
riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e
con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
Ostelli Ulm
Ostelli Germania
Hotel Ulm
Carte d'Allemagne
Karte von
Deutschland
Mapa Alemania
Map of Germany
Carte Ulm
Karte von Ulm
Mapa Ulm
Map of Ulm
|