|
Sei qui:
Cosa vedere a Firenze
>
Basilica di Santa Maria Novella a
Firenze
|
La Basilica di Santa
Maria Novella è un altro dei simboli di
Firenze
conosciuti in tutto il mondo. Venne inizialmente
edificata nel 1279 dai fratti domenicani e si caratterizza per
una serie di chiostri presenti al suo interno. La facciata, completata
da Leo Battista Alberti nel 1470, è semplicemente fantastica
ed è considerata una delle opere più importanti del Rinascimento
fiorentino.
|
|
All'interno, i chiostri si riuniscono quasi
a formare un museo a se, si ammirino infatti gli affreschi nel Cappellone degli Spagnoli su progetto di fra' Jacoppo
Talenti e affrescato da Andrea Bonaiuti (1367), e
chiamata 'degli spagnoli' in quanto utilizzata da Eleonora di Toledo
(moglie di Cosimo I); la splendida Cappella Strozzi,
con affreschi di Nardo di Cione e una vetrata molto
bella
disegnata da Filippino Lippi; la Trinità di
Masaccio;
la Cappella dei Bardi e il cimitero interno.
Breve
storia della Basilica
 La
grande basilica domenicana eretta, insieme con l'annesso convento,
tra la metà del XIII secolo e la metà del successivo,
costituisce il più compiuto esempio di architettura gotica
fiorentina, sul quale si innestò una vasta serie di
interventi quattro-cinquecenteschi rappresentativi di tutta
l'evoluzione artistica del Rinascimento toscano. La sua
origine risale a una piccola chiesa dedicata alla Madonna, fuori
del secondo cerchio delle mura di Firenze, tra i campi e le vigne, detta
perciò Santa Maria delle Vigne e appartenente, come
patronato, ai Canonici del Duomo. Nel 1221 fu concessa al
Beato Giovanni da Salerno, il quale con i suoi confratelli
vi continuò la sua missione di domenicano iniziata due anni
prima. Lunga circa la metà della navata centrate attuale, la
primitiva chiesa aveva come parete di fondo quella della odierna
sagrestia. La
grande basilica domenicana eretta, insieme con l'annesso convento,
tra la metà del XIII secolo e la metà del successivo,
costituisce il più compiuto esempio di architettura gotica
fiorentina, sul quale si innestò una vasta serie di
interventi quattro-cinquecenteschi rappresentativi di tutta
l'evoluzione artistica del Rinascimento toscano. La sua
origine risale a una piccola chiesa dedicata alla Madonna, fuori
del secondo cerchio delle mura di Firenze, tra i campi e le vigne, detta
perciò Santa Maria delle Vigne e appartenente, come
patronato, ai Canonici del Duomo. Nel 1221 fu concessa al
Beato Giovanni da Salerno, il quale con i suoi confratelli
vi continuò la sua missione di domenicano iniziata due anni
prima. Lunga circa la metà della navata centrate attuale, la
primitiva chiesa aveva come parete di fondo quella della odierna
sagrestia.
 Il
18 ottobre 1279 fu posta la prima pietra della nuova basilica
dal cardinale fra Latino Malabranca, nipote di papa
Niccolò III. I lavori furono diretti da due frati
architetti, Sisto da Firenze e Ristoro da Campi, e
poi da altri religiosi. Fra Jacopo Talenti terminò la
chiesa nella sua struttura generale, insieme al campanile di
stile romanico-gotico, verso la metà del secolo XIV. Il
18 ottobre 1279 fu posta la prima pietra della nuova basilica
dal cardinale fra Latino Malabranca, nipote di papa
Niccolò III. I lavori furono diretti da due frati
architetti, Sisto da Firenze e Ristoro da Campi, e
poi da altri religiosi. Fra Jacopo Talenti terminò la
chiesa nella sua struttura generale, insieme al campanile di
stile romanico-gotico, verso la metà del secolo XIV.
Facciata e interno
L'ampia
facciata riecheggia, nella sua parte inferiore, i motivi
romanici del
Battistero di
Firenze e la facciata della
Basilica di San
Miniato a Monte. Tra le due semicolonne mediane
si trova il portale di Leon
Battista Alberti che disegnò anche la parte superiore della
facciata a partire dalla trabeazione (la struttura orizzontale
sostenuta dalle colonne). Questa reca intarsiati nel
fregio le vele araldiche dei Rucellai, il nome del
committente e la data 1470.
 La
fronte della parte superiore della navata mediana, tripartita
da paraste bicolori (le paraste sono pilastri che emergono solo
leggermente dalla parete) emerge al di sopra di un'alta fascia ornata
da riquadri, coronata dal timpano con il monogramma di Cristo e
il fregio con il nome di Giovanni di Paolo Rucellai,
committente dell'opera. Nel rosone si trova la vetrata con l'Incoronazione
di Maria, su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto.
I raccordi laterali a volute nascondono gli spioventi dei tetti
delle navate minori. I due strumenti astronomici nella parte
inferiore furono aggiunti nel 1572 dal domenicano Egnazio
Danti, astronomo di Cosimo I de'Medici. La
fronte della parte superiore della navata mediana, tripartita
da paraste bicolori (le paraste sono pilastri che emergono solo
leggermente dalla parete) emerge al di sopra di un'alta fascia ornata
da riquadri, coronata dal timpano con il monogramma di Cristo e
il fregio con il nome di Giovanni di Paolo Rucellai,
committente dell'opera. Nel rosone si trova la vetrata con l'Incoronazione
di Maria, su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto.
I raccordi laterali a volute nascondono gli spioventi dei tetti
delle navate minori. I due strumenti astronomici nella parte
inferiore furono aggiunti nel 1572 dal domenicano Egnazio
Danti, astronomo di Cosimo I de'Medici.
Antico
cimitero
Sulla destra della facciata ha inizio il recinto dell'antico
cimitero, che prosegue sulla via laterale, con le tombe di
famiglie fiorentine sulle quali sono scolpiti gli stemmi
gentilizi affiancati dalla croce del Popolo. La chiesa,
concepita, secondo lo spirito di questo ordine di predicatori,
come un vasto spazio coperto capace di raccogliere grandi folle
di popolo, aveva pareti in gran parte affrescate che
costituivano una sorta di libro, aperto alle letture edificanti
dei fedeli. La pianta è a T greco, con tre a navate, cappelle di
testata, pilastri snelli e archi a sesto acuto di larghezza
degradante verso il fondo. Originariamente la parte riservata al
popolo era quella compresa tra l'ingresso e il coro dei frati,
dal quale era separata da un tramezzo affrescato dal Beato
Angelico e poi distrutto durante il rifacimento attuato dal
Vasari tra il 1565 e il 1571. Le maggiori famiglie fiorentine
scelsero questa chiesa come luogo per le loro sepolture,
contribuendo generosamente alla costruzione delle relative
cappelle.
Nella navata destra si trova la tomba della Beata Villana, di
Bernardo Rossellino. Nel braccio destro del transetto si trova
Cappella Rucellai dove si trovava la Madonna di Duccio
da Buoninsegna attualmente agli
Uffizi e sostituita con la statua della
Madonna col Bambino di Nino Pisano. Nel mezzo del
pavimento di questa cappella si trova la lastra tombale di
fra Leonardo Dati, generale dei domenicani, di Lorenzo Ghiberti.
 La
Cappella dei Bardi o del Sacramento nel transetto a
destra della Maggiore, apparteneva al primitivo oratorio. Ad
essa segue la Cappella di Filippo Strozzi decorata con
affreschi di Filippino Lippi raffiguranti Storie di
San Filippo Apostolo e San Giovanni Evangelista. La tomba di
Filippo Strozzi ad arcosolio (sepolcro arcato) è opera di
Benedetto da Maiano. La
Cappella dei Bardi o del Sacramento nel transetto a
destra della Maggiore, apparteneva al primitivo oratorio. Ad
essa segue la Cappella di Filippo Strozzi decorata con
affreschi di Filippino Lippi raffiguranti Storie di
San Filippo Apostolo e San Giovanni Evangelista. La tomba di
Filippo Strozzi ad arcosolio (sepolcro arcato) è opera di
Benedetto da Maiano.
Di particolare importanza il ciclo pittorico eseguito nella
Cappella Maggiore eseguito da Domenico Ghirlandaio per
Giovanni Tornabuoni e comprendente Storie evangeliche
riferite in particolare alla vita di Maria, con le figure
genuflesse del committente e della moglie. Sul grande altare
ottocentesco si trova il Crocifisso in bronzo del Giambologna,
mentre il coro ligneo retrostante e il leggio furono eseguiti da
Baccio d'Agnolo e rimaneggiati dal Vasari.
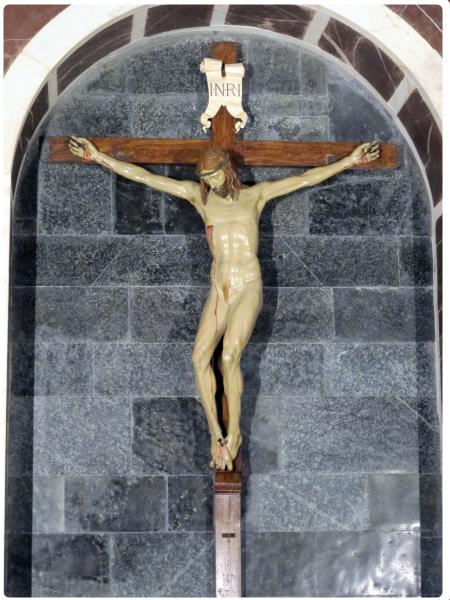 Filippo
Brunelleschi eseguì il famoso Crocifisso ligneo posto
originariamente nel braccio destro del transetto e poi
trasferito nella Cappella Gondi, a sinistra della
Cappella Maggiore, rivestita da un paramento architettonico di
Giuliano da Sangallo. Tra le più importanti seguono a
questa la Cappella Gaddi tardo cinquecentesca e, nella
testata del braccio sinistro del transetto vicina alla sagrestia,
la soprastante Cappella Strozzi con gli affreschi staccati
restaurati, di Nardo di Cione comprendenti il commento figurato
dell’Inferno di Dante. Nell'altare si trova una tavola di Andrea
Orcagna raffigurante il Redentore e Santi e tre
storie nella predella. Nella terza campata della navata sinistra
si trova la celebre Trinità, Maria e San Giovanni di Masaccio
con le figure, del committente Lenzi e della sua compagna. Filippo
Brunelleschi eseguì il famoso Crocifisso ligneo posto
originariamente nel braccio destro del transetto e poi
trasferito nella Cappella Gondi, a sinistra della
Cappella Maggiore, rivestita da un paramento architettonico di
Giuliano da Sangallo. Tra le più importanti seguono a
questa la Cappella Gaddi tardo cinquecentesca e, nella
testata del braccio sinistro del transetto vicina alla sagrestia,
la soprastante Cappella Strozzi con gli affreschi staccati
restaurati, di Nardo di Cione comprendenti il commento figurato
dell’Inferno di Dante. Nell'altare si trova una tavola di Andrea
Orcagna raffigurante il Redentore e Santi e tre
storie nella predella. Nella terza campata della navata sinistra
si trova la celebre Trinità, Maria e San Giovanni di Masaccio
con le figure, del committente Lenzi e della sua compagna.
Gli interventi quattrocenteschi attuati nella chiesa e nel
complesso conventuale testimoniano l'importanza assunta dall'Ordine
Domenicano attraverso i suoi rapporti commerciali. Nel 1419,
a spese degli operai di Santa Maria del Fiore, venne ricavato
nel Convento di Santa Maria Novella un appartamento nel
quale dimorarono papa Martino V, che l'anno seguente
avrebbe consacrato la chiesa, e il successore Eugenio IV.
All'inizio della scala d'accesso dell'appartamento pontificio
disegnata dal Ghiberti venne collocato il Marzocco in
pietra eseguito da Donatello, oggi al
Museo del
Bargello.
 Nel
Cinquecento, periodo di reazione al Gotico,
Giorgio Vasari,
ripetendo l'intervento già attuato in Santa Croce, demolì il
coro e rialzò il pavimento distruggendo le pietre tombali che lo
coprivano. Imbiancò inoltre quasi tutti gli affreschi o li
nascose addossando alle pareti grandi e pesanti altari in
pietra, scomparsi per le successive trasformazioni ottocentesche
in falso stile gotico. A sinistra della facciata della chiesa,
attraverso un portale barocco, si accede al Chiostro Verde,
così chiamato per il colore della "terra" impiegata per gli
affreschi sovrapposti, da Paolo Uccello e dai suoi
seguaci, ad una decorazione precedente di tema analogo. Le
campate, concordemente riferite a Paolo Uccello, sono quelle con
le Storie della Genesi e le Storie di Noè comprendenti il
Diluvio Universale, considerato il capolavoro
dell'artista. Nel
Cinquecento, periodo di reazione al Gotico,
Giorgio Vasari,
ripetendo l'intervento già attuato in Santa Croce, demolì il
coro e rialzò il pavimento distruggendo le pietre tombali che lo
coprivano. Imbiancò inoltre quasi tutti gli affreschi o li
nascose addossando alle pareti grandi e pesanti altari in
pietra, scomparsi per le successive trasformazioni ottocentesche
in falso stile gotico. A sinistra della facciata della chiesa,
attraverso un portale barocco, si accede al Chiostro Verde,
così chiamato per il colore della "terra" impiegata per gli
affreschi sovrapposti, da Paolo Uccello e dai suoi
seguaci, ad una decorazione precedente di tema analogo. Le
campate, concordemente riferite a Paolo Uccello, sono quelle con
le Storie della Genesi e le Storie di Noè comprendenti il
Diluvio Universale, considerato il capolavoro
dell'artista.
 Nell'ampio
refettorio e nell'antirefettorio, con accesso dall'ala nord del
chiostro, è stato allestito recentemente un importante Museo
degli arredi sacri della basilica. Nell'andito del refettorio si
apre l'accesso al Chiostro Grande da cui si sale alla
Cappella dei Papi affrescata dal Pontormo. Sul lato
nord del Chiostro Verde si accede al Cappellone degli
Spagnuoli, l'antica sala capitolare del convento costruita
da Jacopo Talenti e destinata dalla duchessa Eleonora
di Toledo, verso il 1540, alle funzioni religiose degli
Spagnoli del suo seguito. Gli affreschi di Andrea di Bonaiuto
svolgono una complessa allegoria ispirata al concetto svolto da
Jacopo Passavanti nello Specchio dello vera penitenza
e i cui temi principali riguardano la Passione e Resurrezione
di Gesù, la Chiesa Militante e Trionfante e il
Trionfo dello dottrina cattolica personificata da San Tommaso
d'Aquino. Nell'ampio
refettorio e nell'antirefettorio, con accesso dall'ala nord del
chiostro, è stato allestito recentemente un importante Museo
degli arredi sacri della basilica. Nell'andito del refettorio si
apre l'accesso al Chiostro Grande da cui si sale alla
Cappella dei Papi affrescata dal Pontormo. Sul lato
nord del Chiostro Verde si accede al Cappellone degli
Spagnuoli, l'antica sala capitolare del convento costruita
da Jacopo Talenti e destinata dalla duchessa Eleonora
di Toledo, verso il 1540, alle funzioni religiose degli
Spagnoli del suo seguito. Gli affreschi di Andrea di Bonaiuto
svolgono una complessa allegoria ispirata al concetto svolto da
Jacopo Passavanti nello Specchio dello vera penitenza
e i cui temi principali riguardano la Passione e Resurrezione
di Gesù, la Chiesa Militante e Trionfante e il
Trionfo dello dottrina cattolica personificata da San Tommaso
d'Aquino.
Basilica di Santa Maria
Novella
Piazza di Santa Maria Novella
Area: Centro storico (Santa Maria Novella)
Tel: + 39 055 21 59 18
Firenze
Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
Dove si trova?
Ostelli Firenze
Ostelli Italia
Auberges de Jeunesse Italie
Hotel Firenze
Carte de Florance
Karte von Florenz Mapa
Florencia
Map of Florence
Carte de la Toscane
Karte von Toskana
Mapa Toscana Map of
Tuscany
Carte
d'Italie
Karte von Italien
Mapa Italia
Map of Italy |


 La
grande basilica domenicana eretta, insieme con l'annesso convento,
tra la metà del XIII secolo e la metà del successivo,
costituisce il più compiuto esempio di architettura gotica
fiorentina, sul quale si innestò una vasta serie di
interventi quattro-cinquecenteschi rappresentativi di tutta
l'evoluzione artistica del Rinascimento toscano. La sua
origine risale a una piccola chiesa dedicata alla Madonna, fuori
del secondo cerchio delle mura di Firenze, tra i campi e le vigne, detta
perciò Santa Maria delle Vigne e appartenente, come
patronato, ai Canonici del Duomo. Nel 1221 fu concessa al
Beato Giovanni da Salerno, il quale con i suoi confratelli
vi continuò la sua missione di domenicano iniziata due anni
prima. Lunga circa la metà della navata centrate attuale, la
primitiva chiesa aveva come parete di fondo quella della odierna
sagrestia.
La
grande basilica domenicana eretta, insieme con l'annesso convento,
tra la metà del XIII secolo e la metà del successivo,
costituisce il più compiuto esempio di architettura gotica
fiorentina, sul quale si innestò una vasta serie di
interventi quattro-cinquecenteschi rappresentativi di tutta
l'evoluzione artistica del Rinascimento toscano. La sua
origine risale a una piccola chiesa dedicata alla Madonna, fuori
del secondo cerchio delle mura di Firenze, tra i campi e le vigne, detta
perciò Santa Maria delle Vigne e appartenente, come
patronato, ai Canonici del Duomo. Nel 1221 fu concessa al
Beato Giovanni da Salerno, il quale con i suoi confratelli
vi continuò la sua missione di domenicano iniziata due anni
prima. Lunga circa la metà della navata centrate attuale, la
primitiva chiesa aveva come parete di fondo quella della odierna
sagrestia.  Il
18 ottobre 1279 fu posta la prima pietra della nuova basilica
dal cardinale fra Latino Malabranca, nipote di papa
Niccolò III. I lavori furono diretti da due frati
architetti, Sisto da Firenze e Ristoro da Campi, e
poi da altri religiosi. Fra Jacopo Talenti terminò la
chiesa nella sua struttura generale, insieme al campanile di
stile romanico-gotico, verso la metà del secolo XIV.
Il
18 ottobre 1279 fu posta la prima pietra della nuova basilica
dal cardinale fra Latino Malabranca, nipote di papa
Niccolò III. I lavori furono diretti da due frati
architetti, Sisto da Firenze e Ristoro da Campi, e
poi da altri religiosi. Fra Jacopo Talenti terminò la
chiesa nella sua struttura generale, insieme al campanile di
stile romanico-gotico, verso la metà del secolo XIV.  La
fronte della parte superiore della navata mediana, tripartita
da paraste bicolori (le paraste sono pilastri che emergono solo
leggermente dalla parete) emerge al di sopra di un'alta fascia ornata
da riquadri, coronata dal timpano con il monogramma di Cristo e
il fregio con il nome di Giovanni di Paolo Rucellai,
committente dell'opera. Nel rosone si trova la vetrata con l'Incoronazione
di Maria, su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto.
I raccordi laterali a volute nascondono gli spioventi dei tetti
delle navate minori. I due strumenti astronomici nella parte
inferiore furono aggiunti nel 1572 dal domenicano Egnazio
Danti, astronomo di Cosimo I de'Medici.
La
fronte della parte superiore della navata mediana, tripartita
da paraste bicolori (le paraste sono pilastri che emergono solo
leggermente dalla parete) emerge al di sopra di un'alta fascia ornata
da riquadri, coronata dal timpano con il monogramma di Cristo e
il fregio con il nome di Giovanni di Paolo Rucellai,
committente dell'opera. Nel rosone si trova la vetrata con l'Incoronazione
di Maria, su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto.
I raccordi laterali a volute nascondono gli spioventi dei tetti
delle navate minori. I due strumenti astronomici nella parte
inferiore furono aggiunti nel 1572 dal domenicano Egnazio
Danti, astronomo di Cosimo I de'Medici.  La
Cappella dei Bardi o del Sacramento nel transetto a
destra della Maggiore, apparteneva al primitivo oratorio. Ad
essa segue la Cappella di Filippo Strozzi decorata con
affreschi di Filippino Lippi raffiguranti Storie di
San Filippo Apostolo e San Giovanni Evangelista. La tomba di
Filippo Strozzi ad arcosolio (sepolcro arcato) è opera di
Benedetto da Maiano.
La
Cappella dei Bardi o del Sacramento nel transetto a
destra della Maggiore, apparteneva al primitivo oratorio. Ad
essa segue la Cappella di Filippo Strozzi decorata con
affreschi di Filippino Lippi raffiguranti Storie di
San Filippo Apostolo e San Giovanni Evangelista. La tomba di
Filippo Strozzi ad arcosolio (sepolcro arcato) è opera di
Benedetto da Maiano.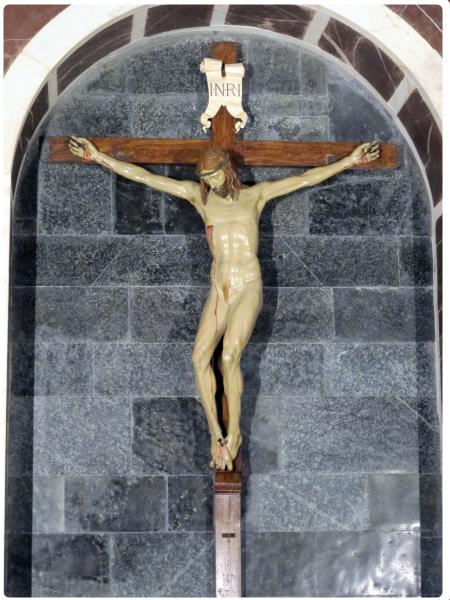 Filippo
Brunelleschi eseguì il famoso Crocifisso ligneo posto
originariamente nel braccio destro del transetto e poi
trasferito nella Cappella Gondi, a sinistra della
Cappella Maggiore, rivestita da un paramento architettonico di
Giuliano da Sangallo. Tra le più importanti seguono a
questa la Cappella Gaddi tardo cinquecentesca e, nella
testata del braccio sinistro del transetto vicina alla sagrestia,
la soprastante Cappella Strozzi con gli affreschi staccati
restaurati, di Nardo di Cione comprendenti il commento figurato
dell’Inferno di Dante. Nell'altare si trova una tavola di Andrea
Orcagna raffigurante il Redentore e Santi e tre
storie nella predella. Nella terza campata della navata sinistra
si trova la celebre Trinità, Maria e San Giovanni di Masaccio
con le figure, del committente Lenzi e della sua compagna.
Filippo
Brunelleschi eseguì il famoso Crocifisso ligneo posto
originariamente nel braccio destro del transetto e poi
trasferito nella Cappella Gondi, a sinistra della
Cappella Maggiore, rivestita da un paramento architettonico di
Giuliano da Sangallo. Tra le più importanti seguono a
questa la Cappella Gaddi tardo cinquecentesca e, nella
testata del braccio sinistro del transetto vicina alla sagrestia,
la soprastante Cappella Strozzi con gli affreschi staccati
restaurati, di Nardo di Cione comprendenti il commento figurato
dell’Inferno di Dante. Nell'altare si trova una tavola di Andrea
Orcagna raffigurante il Redentore e Santi e tre
storie nella predella. Nella terza campata della navata sinistra
si trova la celebre Trinità, Maria e San Giovanni di Masaccio
con le figure, del committente Lenzi e della sua compagna. Nel
Cinquecento, periodo di reazione al Gotico,
Nel
Cinquecento, periodo di reazione al Gotico,
 Nell'ampio
refettorio e nell'antirefettorio, con accesso dall'ala nord del
chiostro, è stato allestito recentemente un importante Museo
degli arredi sacri della basilica. Nell'andito del refettorio si
apre l'accesso al Chiostro Grande da cui si sale alla
Cappella dei Papi affrescata dal Pontormo. Sul lato
nord del Chiostro Verde si accede al Cappellone degli
Spagnuoli, l'antica sala capitolare del convento costruita
da Jacopo Talenti e destinata dalla duchessa Eleonora
di Toledo, verso il 1540, alle funzioni religiose degli
Spagnoli del suo seguito. Gli affreschi di Andrea di Bonaiuto
svolgono una complessa allegoria ispirata al concetto svolto da
Jacopo Passavanti nello Specchio dello vera penitenza
e i cui temi principali riguardano la Passione e Resurrezione
di Gesù, la Chiesa Militante e Trionfante e il
Trionfo dello dottrina cattolica personificata da San Tommaso
d'Aquino.
Nell'ampio
refettorio e nell'antirefettorio, con accesso dall'ala nord del
chiostro, è stato allestito recentemente un importante Museo
degli arredi sacri della basilica. Nell'andito del refettorio si
apre l'accesso al Chiostro Grande da cui si sale alla
Cappella dei Papi affrescata dal Pontormo. Sul lato
nord del Chiostro Verde si accede al Cappellone degli
Spagnuoli, l'antica sala capitolare del convento costruita
da Jacopo Talenti e destinata dalla duchessa Eleonora
di Toledo, verso il 1540, alle funzioni religiose degli
Spagnoli del suo seguito. Gli affreschi di Andrea di Bonaiuto
svolgono una complessa allegoria ispirata al concetto svolto da
Jacopo Passavanti nello Specchio dello vera penitenza
e i cui temi principali riguardano la Passione e Resurrezione
di Gesù, la Chiesa Militante e Trionfante e il
Trionfo dello dottrina cattolica personificata da San Tommaso
d'Aquino.