|
Ugo Ojetti (1871-1946) è stato uno scrittore, critico d'arte e giornalista
italiano. È stato uno dei più influenti e prolifici critici d'arte del XX
secolo, nonché uno dei fondatori del giornalismo culturale in Italia. Ojetti
ha scritto numerosi libri e articoli sulla letteratura, l'arte e la cultura
in generale, oltre ad essere stato il fondatore della rivista "La Ronda",
che ha avuto un grande impatto sulla cultura italiana degli anni '20 e '30.
|
Ugo Ojetti, per buona
parte del 1900 è stato considerato uno dei massimi letterati, giornalisti e
critici d'arte italiani. In seguito è stato letteralmente dimenticato. Ne riscopriamo
in questo articolo il talento, la storia personale e professionale. Come
scrisse Guido Piovene "Il mondo era, o sembrava, per lui una casa
sicura, e la sua fede era l'intelligenza."
|
|

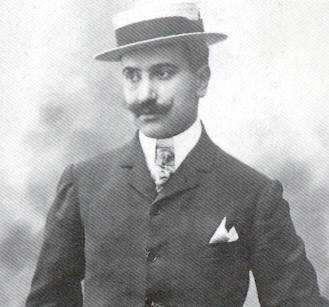 Ugo Ojetti è stato
uno dei massimi divulgatori dell'arte e della
letteratura. Nacque a Roma il 15 luglio
1871. Il padre Raffaele, era un noto architetto, la madre
Veronica Carosi, era originaria di
Spoleto. Ebbe la fortuna di crescere in un ambiente vivace e
mostrò
subito amore per l'arte e per la storia. Dopo aver frequentato la Scuola dei
Gesuiti, seguì gli studi in legge, nella prospettiva di una
possibile carriera nel mondo diplomatico. Le sue vere passioni non tardarono
tuttavia a ripresentarsi. Riuscì comunque a laurearsi in giurisprudenza nel
1892. Nello stesso anno, all'età di 21 anni, pubblicò una
raccolta di poesie intitolata "Paesaggi",
ispirata alla campagna umbra dove soggiornò presso la famiglia della
madre. Ugo Ojetti è stato
uno dei massimi divulgatori dell'arte e della
letteratura. Nacque a Roma il 15 luglio
1871. Il padre Raffaele, era un noto architetto, la madre
Veronica Carosi, era originaria di
Spoleto. Ebbe la fortuna di crescere in un ambiente vivace e
mostrò
subito amore per l'arte e per la storia. Dopo aver frequentato la Scuola dei
Gesuiti, seguì gli studi in legge, nella prospettiva di una
possibile carriera nel mondo diplomatico. Le sue vere passioni non tardarono
tuttavia a ripresentarsi. Riuscì comunque a laurearsi in giurisprudenza nel
1892. Nello stesso anno, all'età di 21 anni, pubblicò una
raccolta di poesie intitolata "Paesaggi",
ispirata alla campagna umbra dove soggiornò presso la famiglia della
madre.
Nel 1893, iniziò a collaborare con la Nuova Rassegna di Luigi Lodi,
la Tribuna, il Fanfulla della domenica, giornali dell'epoca. Pubblicò un volume di
novelle di ispirazione verista, Senza Dio (1894) a cui seguirono
altre opere: L’onesta viltà (1897), Il vecchio (1898), Il
gioco dell’amore (1899), Le vie del peccato (1902), Il cavallo
di Troia (1904), la raccolta di racconti Mimì e la gloria
(1908), Donne, uomini e burattini (1912) e L’amore e suo figlio
(1913).
 Il
giornalismo fu importante per Ojetti che collaborò con il
quotidiano La Tribuna, di Emilio Luzzato, come inviato del giornale
in Egitto. Da qui fiorirono le collaborazioni con altri editori, tra cui
Il Giornale d'Italia, l’Avanti!, La Stampa e il
Resto del Carlino. Il
giornalismo fu importante per Ojetti che collaborò con il
quotidiano La Tribuna, di Emilio Luzzato, come inviato del giornale
in Egitto. Da qui fiorirono le collaborazioni con altri editori, tra cui
Il Giornale d'Italia, l’Avanti!, La Stampa e il
Resto del Carlino.
Nel 1895 dopo aver conosciuto Gabriele D’Annunzio ebbe il suo primo e
importante successo letterario: una fortunata inchiesta destinata a
lasciare il segno, un volume che raccoglieva una serie di
colloqui con i maggiori scrittori del tempo. L'opera si chiamava
Alla scoperta dei letterati, e riportava colloqui e interviste che
avevano come oggetto lo stato della
letteratura italiana. Tanti i letterati famosi del tempo che furono
ascoltati: Verga, Carducci, Fogazzaro,
Capuana,
Matilde Serao, Pascoli,
De Roberto,
De Amicis, lo stesso D’Annunzio e altri. Si
trattava di un'opera per un verso visionaria, anticipatrice del
reportage moderno, e allo stesso tempo rappresentativa del mondo letterario che
andava affermandosi nella situazione politica e socio-economica di fine
Ottocento. Un documento importante a livello storico, innovativo e
illuminante.
Nell’introduzione all'opera venivano trattati temi che avrebbero
caratterizzato la prima fase della produzione di Ojetti: la contaminazione tra
giornalismo e letteratura, attraverso il modello anglosassone dell’"interview";
l’attenzione alla formazione di un pubblico ampio e non specialistico; la
presa di posizione antinaturalistica, a favore di un dichiarato idealismo
letterario e l’impegno per una rinascita della letteratura nazionale.
Il tema della rinascita letteraria
 Il tema della rinascita letteraria "italiana" ebbe risonanza e fu riproposto
a Venezia nel discorso L’avvenire della letteratura italiana (1896),
dove Ojetti teneva una posizione idealistica e cosmopolita – ostile al
patriottismo culturale (La grande illusione, in Il Marzocco,
22 marzo 1896), e all’imitazione superficiale di modelli di successo (Il
contagio dannunziano, 20 febbraio 1898). In questo discorso abbracciava in sintesi le
posizioni del filosofo, storico e critico letterario francese Hippolyte
Taine, che postulava le condizioni per una "letteratura nazionale"
legandole a un
complesso di valori condivisi da un popolo.
Una letteratura nazionale che, secondo Ojetti, si sarebbe potuta sviluppare
solo con l'affermazione di un nuovo idealismo, da innestare nella tradizione
italiana già presente. In questo senso, si era andata configurando, secondo
il suo pensiero, una battaglia culturale dei "nati dopo il 1870",
i disillusi dagli effetti dell'Unità d'Italia, contro il vecchio establishment
risorgimentale. Ojetti, in questo frangente storico di fine secolo, si allineò
anche alla proposta dannunziana di un adeguamento dello stile giornalistico
al registro "alto" alla tradizione letteraria nazionale. Il tema della rinascita letteraria "italiana" ebbe risonanza e fu riproposto
a Venezia nel discorso L’avvenire della letteratura italiana (1896),
dove Ojetti teneva una posizione idealistica e cosmopolita – ostile al
patriottismo culturale (La grande illusione, in Il Marzocco,
22 marzo 1896), e all’imitazione superficiale di modelli di successo (Il
contagio dannunziano, 20 febbraio 1898). In questo discorso abbracciava in sintesi le
posizioni del filosofo, storico e critico letterario francese Hippolyte
Taine, che postulava le condizioni per una "letteratura nazionale"
legandole a un
complesso di valori condivisi da un popolo.
Una letteratura nazionale che, secondo Ojetti, si sarebbe potuta sviluppare
solo con l'affermazione di un nuovo idealismo, da innestare nella tradizione
italiana già presente. In questo senso, si era andata configurando, secondo
il suo pensiero, una battaglia culturale dei "nati dopo il 1870",
i disillusi dagli effetti dell'Unità d'Italia, contro il vecchio establishment
risorgimentale. Ojetti, in questo frangente storico di fine secolo, si allineò
anche alla proposta dannunziana di un adeguamento dello stile giornalistico
al registro "alto" alla tradizione letteraria nazionale.
Dopo il successo ottenuto in ambito giornalistico, Ojetti entrò a far
parte nel 1898 della redazione del Corriere della Sera, diventandone
uno dei giornalisti più importanti per quasi mezzo secolo. Per il Corriere
scrisse anche sotto lo pseudonimo di Tantalo, "Cose viste",
da cui ricavò in seguito anche un libro. Nel 1926, per un breve
periodo, divenne direttore della stessa testata giornalistica, succedendo a
Luigi Albertini, che lasciava per la sua insofferenza al processo di
fascistizzazione della stampa italiana.
Il primo periodo di impegno giornalistico attivo di Ojetti
coincise con gli anni dell'attivismo politico in Umbria, regione
d'origine della madre. Partecipò a un gruppo di matrice socialista. Con
questa militanza arrivò a fondare il periodico regionale "La giovane
Umbria" e nel 1896 si candidò alle elezioni del comune di
Spoleto, senza riuscire però a ottenere un seggio. Continuò l'attività
giornalistica e venne inviato a
Parigi nel 1904, mentre nel 1905 pubblicò il primo lavoro
teatrale, "Un garofano", messo in scena da Ettore Petrolini.
In campo teatrale, precedentemente, oltre a traduzioni (sua la
versione italiana di Oltre il potere nostro di Bjørnstjerne
Bjørnson del 1895 e La toga rossa di Eugène Brieux,
1900) aveva recensito le opere di Henrik Ibsen, di
cui era un ammiratore. In collaborazione con Renato Simoni, scrisse la
commedia Il matrimonio di Casanova (1910).
 Nel
1905 sposò Fernanda Gobba, stabilendosi
definitivamente a Fiesole, in un'antica villa sulle colline sopra
Firenze.
La grande villa cinquecentesca era chiamata
il Salviatino e vantava ben cinquantasei stanze oltre a uno stupendo giardino; oggi
è una residenza alberghiera di lusso. La villa di Fiesole fu
restaurata secondo il suo gusto personale e diventò negli anni
un vero e proprio salotto culturale, ospitando scrittori, artisti, intellettuali e politici
dell'epoca. Dalla villa in seguito si spostò per raggiungere la località di Santa
Marinella, nei pressi di Roma, che diventò anch'essa luogo ideale per
nutrire la sua fame letteraria. Nella dimora fiorentina ebbe modo di
raccogliere una ricchissima collezione d'arte, purtroppo andata dispersa
alla sua morte, con opere di
Jacopo della Quercia, Poussin,Casorati,
Boldini, De Nittis, Fattori, tra i tanti. La sua unica
figlia, Paola Ojetti, nacque nel 1911 (diventerà
sceneggiatrice, traduttrice e critica cinematografica italiana). Nel
1905 sposò Fernanda Gobba, stabilendosi
definitivamente a Fiesole, in un'antica villa sulle colline sopra
Firenze.
La grande villa cinquecentesca era chiamata
il Salviatino e vantava ben cinquantasei stanze oltre a uno stupendo giardino; oggi
è una residenza alberghiera di lusso. La villa di Fiesole fu
restaurata secondo il suo gusto personale e diventò negli anni
un vero e proprio salotto culturale, ospitando scrittori, artisti, intellettuali e politici
dell'epoca. Dalla villa in seguito si spostò per raggiungere la località di Santa
Marinella, nei pressi di Roma, che diventò anch'essa luogo ideale per
nutrire la sua fame letteraria. Nella dimora fiorentina ebbe modo di
raccogliere una ricchissima collezione d'arte, purtroppo andata dispersa
alla sua morte, con opere di
Jacopo della Quercia, Poussin,Casorati,
Boldini, De Nittis, Fattori, tra i tanti. La sua unica
figlia, Paola Ojetti, nacque nel 1911 (diventerà
sceneggiatrice, traduttrice e critica cinematografica italiana).
Una letteratura unitaria italiana
 Se
da una parte, con le "interviste" agli scrittori della sua epoca
Ojetti si avvicinò
al pensiero di
Gabriele D'Annunzio (per il quale nutriva grande
ammirazione), con le stesse interviste, pose l'accento sul
sentimento post-unitario italiano, constatando che ancora non esisteva
alcuna letteratura – per motivi sia linguistici e culturali – che potesse
definirsi come unitariamente italiana. La
successiva convivenza con le atmosfere della cultura parigina, lo
avvicinarono ai movimenti filosofici dell'epoca, tra il
naturalismo e positivismo di Taine e le dottrine evoluzionistiche e
sociologiche di Guyau. Si convinse che la posizione
storica di un'artista dipendeva dall'opera d'arte che lo rappresentava,
e che tale posizione potesse definirsi moderna se er acapace di rappresentare e comunicare l’essenza
dell’anima umana del suo tempo. In questo si riteneva un convinto precursore della
necessità di individuare l'artista soprattutto dalle qualità
interiori, quelle dell'anima, e non solo dalle tecniche stilistiche. Se
da una parte, con le "interviste" agli scrittori della sua epoca
Ojetti si avvicinò
al pensiero di
Gabriele D'Annunzio (per il quale nutriva grande
ammirazione), con le stesse interviste, pose l'accento sul
sentimento post-unitario italiano, constatando che ancora non esisteva
alcuna letteratura – per motivi sia linguistici e culturali – che potesse
definirsi come unitariamente italiana. La
successiva convivenza con le atmosfere della cultura parigina, lo
avvicinarono ai movimenti filosofici dell'epoca, tra il
naturalismo e positivismo di Taine e le dottrine evoluzionistiche e
sociologiche di Guyau. Si convinse che la posizione
storica di un'artista dipendeva dall'opera d'arte che lo rappresentava,
e che tale posizione potesse definirsi moderna se er acapace di rappresentare e comunicare l’essenza
dell’anima umana del suo tempo. In questo si riteneva un convinto precursore della
necessità di individuare l'artista soprattutto dalle qualità
interiori, quelle dell'anima, e non solo dalle tecniche stilistiche.
Le influenze principali su di lui, furono quelle esercitate
dalle opere di J. A. McNeill Whistler, di Giovanni Segantini o ancora di Auguste Rodin. Nota è la
sua classificazione di artisti in “pittori che pensano, pittori che
sentono e pittori che non pensano e non sentono", espressa durante la
Biennale a
Venezia, nella
quale ottenne anche il secondo posto nel premio della critica d’arte con “L’arte
moderna a Venezia", una raccolta di articoli pubblicati su Il Resto
del Carlino. Il lavoro di inviato all'estero divenne più intenso negli anni a
cavallo tra l'Ottocento ed il Novecento. Fu un periodo importante per la
sua vita,
necessario alla comprensione analitica nella comunicazione dei fatti che
accadevano nel mondo. Da inviato in Egitto, Albania,
Norvegia, Francia, Asia e soprattutto Stati Uniti,
raccontò i costumi in voga nel periodo storico. In particolare narrò i
costumi
americani confrontandoli con quelli europei nel volume “L’America
vittoriosa" (1899).
Gli Stati Uniti rinverdirono in lui
l'interesse per la modernità di quella società. Apprezzava la determinazione
dell'America, sia
individuale che collettiva, di imporsi negli affari nello scenario internazionale. Di contro realizzava quanto l'Italia avesse
la necessità di un rinnovamento dello spirito nazionale in senso
attivistico, la necessità di essere ottimista circa le proprie capacità di autoaffermazione, al
fine di scongiurare il destino di decadenza riservato ai popoli latini. Più
tardi, dopo viaggi e soggiorni, prese forma la raccolta
L’America e l’avvenire (1905).
Ojetti amava definirsi un "cronista" al servizio dei
lettori, occupandosi di arte, cultura, viaggi e politica. Effettivamente è
stato uno dei più grandi critici d'arte italiani. Scrisse, non
tanto per il gusto di compiacere gli addetti ai lavori, bensì proprio per
dare valore all'arte italiana, per "difendere e diffondere tutta l’arte", da
quella antica a quella contemporanea. Per Ojetti non esisteva
un'epoca migliore dell'altra, ma c'erano solo uomini e valori
nelle opere che rimanevano per sempre.
 Del
1911 è la pubblicazione dei primi "Ritratti d’artisti italiani",
che ebbe un meritato successo. Poco prima, nel cinquantenario dell’Unità
d’Italia, Ojetti aveva organizzato una mostra fortunatissima,
"Ritratto in Palazzo Vecchio", a Firenze. Fu una delle prime mostre organizzate nel capoluogo toscano, parte di un programma di
mostre biennali d’arte antica, curate dallo stesso Ojetti in tutti i minimi
particolari (e non solo quelli prettamente artistici). L'artista viaggiò tantissimo
nei primi anni del Novecento, passando almeno 6 mesi all'anno
all'estero, tra Parigi e Londra. Riuscì ad esportare il suo
particolare modello espositivo anche all’estero, riscuotendo un enorme
successo. Una sua esposizione venne fatta alla Royal Academy di
Londra nel 1930; a
Parigi rimane ancora oggi ben nota negli annali, la mostra da
lui organizzata nel 1935; mentre in Italia, tra tutte viene ricordata la
mostra organizzata nel 1922 a Firenze, intitolata "Mostra della pittura italiana del Seicento e del
Settecento", considerata nel suo genere una delle più importanti del XX
secolo (contribuì tra l'altro a consacrare definitivamente l'importanza di
Caravaggio).
L’avvenimento principale di questa mostra fu infatti la presentazione di
diciotto tele di Caravaggio, a cui venne dato grande spazio nel catalogo della
mostra, pubblicato due anni dopo. Tra le altre mostre organizzate da Ojetti, quella su
Giotto nel 1937 "Mostra
Giottesca", sempre a Firenze. Del
1911 è la pubblicazione dei primi "Ritratti d’artisti italiani",
che ebbe un meritato successo. Poco prima, nel cinquantenario dell’Unità
d’Italia, Ojetti aveva organizzato una mostra fortunatissima,
"Ritratto in Palazzo Vecchio", a Firenze. Fu una delle prime mostre organizzate nel capoluogo toscano, parte di un programma di
mostre biennali d’arte antica, curate dallo stesso Ojetti in tutti i minimi
particolari (e non solo quelli prettamente artistici). L'artista viaggiò tantissimo
nei primi anni del Novecento, passando almeno 6 mesi all'anno
all'estero, tra Parigi e Londra. Riuscì ad esportare il suo
particolare modello espositivo anche all’estero, riscuotendo un enorme
successo. Una sua esposizione venne fatta alla Royal Academy di
Londra nel 1930; a
Parigi rimane ancora oggi ben nota negli annali, la mostra da
lui organizzata nel 1935; mentre in Italia, tra tutte viene ricordata la
mostra organizzata nel 1922 a Firenze, intitolata "Mostra della pittura italiana del Seicento e del
Settecento", considerata nel suo genere una delle più importanti del XX
secolo (contribuì tra l'altro a consacrare definitivamente l'importanza di
Caravaggio).
L’avvenimento principale di questa mostra fu infatti la presentazione di
diciotto tele di Caravaggio, a cui venne dato grande spazio nel catalogo della
mostra, pubblicato due anni dopo. Tra le altre mostre organizzate da Ojetti, quella su
Giotto nel 1937 "Mostra
Giottesca", sempre a Firenze.
 Durante
la prima guerra mondiale come volontario, svolse l'incarico di
proteggere dai bombardamenti aerei le opere d'arte custodite a Venezia. Fu
anche incaricato di scrivere il testo del volantino lanciato il 9 agosto
1918 nei cieli di Vienna da D'Annunzio e dalla sua squadra (circa
350.000 copie stampate in italiano e in tedesco). In questo periodo ebbe
modo di rappresentare le vicende umane della guerra sia attraverso delle
mostre (come la mostra fotografica sui monumenti italiani martirizzati,
del 1917), che attraverso gli scritti, in particolare in Lettere alla moglie
(1915-1919). Durante
la prima guerra mondiale come volontario, svolse l'incarico di
proteggere dai bombardamenti aerei le opere d'arte custodite a Venezia. Fu
anche incaricato di scrivere il testo del volantino lanciato il 9 agosto
1918 nei cieli di Vienna da D'Annunzio e dalla sua squadra (circa
350.000 copie stampate in italiano e in tedesco). In questo periodo ebbe
modo di rappresentare le vicende umane della guerra sia attraverso delle
mostre (come la mostra fotografica sui monumenti italiani martirizzati,
del 1917), che attraverso gli scritti, in particolare in Lettere alla moglie
(1915-1919).
Il suo prestigio andava sempre più consolidandosi
nell'ambiente culturale così come nella vita pubblica italiana, avendo
assunto vari incarichi istituzionali in campo storico-artistico. Tra questi,
nel 1920 ci fu anche l'incarico nella commissione del Ministero
della Pubblica Istruzione italiano di riformare l’insegnamento artistico
e di co-dirigere la sezione artistica dell’Istituto per l’Enciclopedia
Italiana, mentre nel 1930 ricevette la nomina ad Accademico d’Italia.
 Fu nel 1920 che Ojetti
ebbe il suo più prestigioso riconoscimento in campo artistico, con
la pubblicazione del primo numero di "Dedalo", rivista
che si occupava di storia dell'arte antica e moderna e che viene ancora
oggi considerata come una delle riviste d’arte divulgative più
prestigiose della prima metà del Novecento, capace di catturare da una
parte le attenzioni degli intellettuali più importanti dell'epoca, e
dall'altra di avvicinare all'arte il vasto pubblico meno erudito. Fu nel 1920 che Ojetti
ebbe il suo più prestigioso riconoscimento in campo artistico, con
la pubblicazione del primo numero di "Dedalo", rivista
che si occupava di storia dell'arte antica e moderna e che viene ancora
oggi considerata come una delle riviste d’arte divulgative più
prestigiose della prima metà del Novecento, capace di catturare da una
parte le attenzioni degli intellettuali più importanti dell'epoca, e
dall'altra di avvicinare all'arte il vasto pubblico meno erudito.
 Quelle
di Dedalo, sono pagine impregnate di riflessioni ojettiane, tra
valori morali ed estetici, e sempre finalizzate alla divulgazione,
considerata la massima priorità, a vantaggio del vasto pubblico,
non solo agli addetti ai lavori. Nel 1919 Ojetti aveva spiegato bene la sua
posizione, scrivendo nel
Corriere della sera, “le stelle non sono degli astronomi". La
rivista venne pubblicata fino al 1933, interrotta (come altre, tra cui il
mensile Pegaso) a seguito di alcuni contrasti con l'editore Treves.
Fu così che, nel 1933, Ojetti decise di rivolgersi all'editore Rizzoli
per la pubblicazione della rivista "Pan", rassegna di lettere, musica e
arte, che restò attiva grosso modo un biennio. Da Rizzoli venne pubblicata anche la collana de
I classici, una
edizione pregiata di autori della letterature italiana, francese, tedesca e
inglese. Quelle
di Dedalo, sono pagine impregnate di riflessioni ojettiane, tra
valori morali ed estetici, e sempre finalizzate alla divulgazione,
considerata la massima priorità, a vantaggio del vasto pubblico,
non solo agli addetti ai lavori. Nel 1919 Ojetti aveva spiegato bene la sua
posizione, scrivendo nel
Corriere della sera, “le stelle non sono degli astronomi". La
rivista venne pubblicata fino al 1933, interrotta (come altre, tra cui il
mensile Pegaso) a seguito di alcuni contrasti con l'editore Treves.
Fu così che, nel 1933, Ojetti decise di rivolgersi all'editore Rizzoli
per la pubblicazione della rivista "Pan", rassegna di lettere, musica e
arte, che restò attiva grosso modo un biennio. Da Rizzoli venne pubblicata anche la collana de
I classici, una
edizione pregiata di autori della letterature italiana, francese, tedesca e
inglese.
Nel 1922, poco prima della Marcia su Roma, venne
pubblicato il romanzo Mio figlio ferroviere, che affrontava
tematiche sociali, evidenziando le idee politiche dell'autore. Nel 1925
fu
tra i 250 firmatari, insieme a Gabriele D'Annunzio, Giuseppe
Ungaretti e
Luigi Pirandello, del Manifesto degli intellettuali
fascisti, redatto da Giovanni Gentile, pubblicato in diversi
quotidiani italiani, e definito il primo documento ideologico
degli intellettuali italiani che aderirono al regime fascista.
Del Fascismo italiano, Ojetti, pur condannandone la
violenza e la retorica, finì per accettare l'ideologia. Nel 1924 rifiutò
la nomina a senatore per solidarietà all’amico poeta Salvatore di Giacomo,
a cui fu negata per motivi di censo. Fu anche presidente dell'Alfa
Romeo tra la prima grande guerra e i primi anni Venti.
 Dalla
fine degli anni Trenta del 1900 la produzione di Ojetti subì una certa
flessione. Uscì nel frattempo la biografia su Italo Balbo (1941) e il saggio
L’arte ha da essere italiana del 1942. In quel periodo Ojetti era
già stato colpito dai primi sintomi di una lunga malattia, che gli sottrasse
progressivamente lucidità mentale. Nel 1943, dopo l'armistizio dell’8
settembre, venne nominato vicepresidente dell’Accademia d’Italia nella
Repubblica Sociale Italia. Dalla
fine degli anni Trenta del 1900 la produzione di Ojetti subì una certa
flessione. Uscì nel frattempo la biografia su Italo Balbo (1941) e il saggio
L’arte ha da essere italiana del 1942. In quel periodo Ojetti era
già stato colpito dai primi sintomi di una lunga malattia, che gli sottrasse
progressivamente lucidità mentale. Nel 1943, dopo l'armistizio dell’8
settembre, venne nominato vicepresidente dell’Accademia d’Italia nella
Repubblica Sociale Italia.
Morì subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 1°
gennaio 1946 nella sua villa di Fiesole, con poca considerazione postuma da
parte degli editori più conosciuti, e con i quali aveva a lungo collaborato.
Ebbe la considerazione invece di intellettuali quali Antonio Gramsci e Indro Montanelli.
Prima di morire aveva
perso la qualifica di giornalista, essendo stato cancellato
dall’albo dei giornalisti nel 1944, per via della sua partecipazione al regime fascista.
Fu
sepolto nella Badia Fiesolana. Sulla sua lapide vi è scritto "Qui riposa
Ugo Ojetti, Romano. Amò e servì le Arti e la Lingua d'Italia. Le più limpide
e umane sulla terra e per questo care a Dio".
Nel 1977 la figlia Paola, ha donato la ricca biblioteca paterna al
Gabinetto Viesseux di Firenze.
Chi accumula libri, accumula desideri, e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a
ottant'anni. (Ugo Ojetti)
Opere
Letteratura
Paesaggi (1892)
Alla scoperta dei letterati: colloquii con Carducci, Panzacchi,
Fogazzaro, Lioy, Verga, D'Annunzio, De Roberto, Matilde Serao e altri
(Milano, 1895);
Ad Atene per Ugo Foscolo. Discorso pronunciato ad Atene per il centenario
della morte, Milano, Fratelli Treves Editori, 1928.
D'Annunzio. Amico · Maestro · Soldato, Firenze, Sansoni, 1957.
Storia e critica d'arte
L'esposizione di Milano (1906),
Ritratti d'artisti italiani (in due volumi, 1911 e 1923),
Il martirio dei monumenti, 1918
I nani tra le colonne, Milano, Fratelli Treves Editori, 1920
Raffaello e altre leggi (1921),
La pittura italiana del Seicento e del Settecento (1924),
Il ritratto italiano dal 1500 al 1800 (1927),
Tintoretto, Canova, Fattori (1928),
Atlante di storia dell'arte italiana, con Luigi Dami (due volumi,
1925 e 1934),
Paolo Veronese, Milano, Fratelli Treves Editori, 1928,
La pittura italiana dell'Ottocento (1929),
Bello e brutto, Milano, Treves, 1930
Ottocento, Novecento e via dicendo (Mondadori, 1936),
Più vivi dei vivi (Mondadori, 1938).
In Italia, l'arte ha da essere italiana?, Milano, Mondadori, 1942.
Romanzi
L'onesta viltà (Roma, 1897),
Il vecchio, Milano, 1898
Il gioco dell'amore, Milano, 1899
Le vie del peccato (Baldini e Castoldi, Milano, 1902),
Il cavallo di Troia, 1904
Mimì e la gloria (Treves, 1908),
Mio figlio ferroviere (Treves, 1922).
Racconti
Senza Dio, 1894
Mimì e la gloria, 1908
Donne, uomini e burattini, Milano, Treves, 1912
L'amore e suo figlio, Milano, Treves, 1913
Teatro
Un Garofano (1902)
U. Ojetti-Renato Simoni, Il matrimonio di Casanova: commedia in
quattro atti (1910)
Reportages
L'America vittoriosa (Treves, 1899),
L'Albania (Treves, 1902);
L'America e l'avvenire (1905).
Raccolte di articoli
Articoli scritti fra il 1904 e il 1908 per L'Illustrazione Italiana:
I capricci del conte Ottavio (due voll., usciti rispettivamente
nel 1908 e nel 1910)
Articoli per il Corriere della Sera nell'arco d'oltre quindici anni, dal
1923 al 1939:
Cose viste (7 voll.: I. 1921-1927; II. 1928-1943). L'opera è stata
anche tradotta in lingua inglese.
Memorie e taccuini
Vita vissuta, a cura di Arturo Stanghellini, Milano, Mondadori, 1942.
I Taccuini 1914-1943, a cura di Fernanda e Paola Ojetti, Firenze,
Sansoni, 1954.
Ricordi di un ragazzo romano. Note di un viaggio fra la vita e la morte,
Milano, 1958.
Copyright ©
Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque
forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza
autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
.
Torna su
Ostelli
Roma Ostelli Italia
Carte de Rome
Karte von Rom
Mapa Roma
Map of Rome
Carte Latium
Karte von Latium
Mapa Lazio
Map of Lazio
Carte d'Italie
Karte von Italien Mapa Italia Map of Italy |
