|
Sei
qui: Biografie
>
Niccolò
Paganini ha definito i più alti standard nel mondo del violino. Fu personaggio a
tutto tondo, definito molto negativamente dai suoi detrattori, tra cui Stendhal,
come brutto d'aspetto, quasi demoniaco, e addirittura assassino. I suoi
ammiratori, come per esempio nel libro pubblicato a Lipsia nel 1893, "I più
grandi violinisti del presente e del passato", lo descrivono virile, simpatico,
quasi gioviale. Il biografo russo Anatoly Vinogradov, lo descrisse viceversa di una
bruttezza che faceva "venire i brividi" a chi lo guardava. Una palese
esagerazione. Altre fonti lo descrivevano come un uomo dalla fronte alta, dai
tratti fini, dagli gli occhi luminosi ed espressivi. Chi era il vero Paganini?
|
Quello che è certo è
che l'eccentrica personalità di Paganini, le sue capacità naturali di
suonare gli strumenti, la sua pratica tenace fino alla
perfezione e la brillantezza delle sue composizioni sono la
ricetta della sua grandezza. Non a caso, grandi compositori
successivi, come Schumann, Brahms, Liszt e Rachmaninoff,
Frédéric Chopin, hanno basato diverse
composizioni sulle sue melodie. Insieme alla competenza e
all'efficacia di Paganini nell'esecuzione, ciò che ha reso
speciale il compositore genovese è il mix unico di disegno,
creazione e innovazione della sua musica.
|
|
Niccolò Paganini è considerato uno dei più grandi
compositori italiani, oltre ad essere considerato uno dei più grandi
virtuosi del violino mai esistiti, nato il 27 ottobre 1782 e morto il 27
maggio 1840. Ha giocato un ruolo fondamentale nello stabilire le moderne
tecniche violinistiche. Fu ispirato come musicista da numerosi compositori,
tra cui
Mozart,
Lizt
e
Beethoven. 24 Capricci per violino solo Op. 1 è la sua opera più
famosa. Questa e altre sue composizioni hanno avuto una grande influenza sui
compositori contemporanei e successivi.
"Se non studio per un giorno, me ne accorgo. Se non
studio per due giorni, il pubblico lo nota." Niccolò Paganini
Biografia
Infanzia
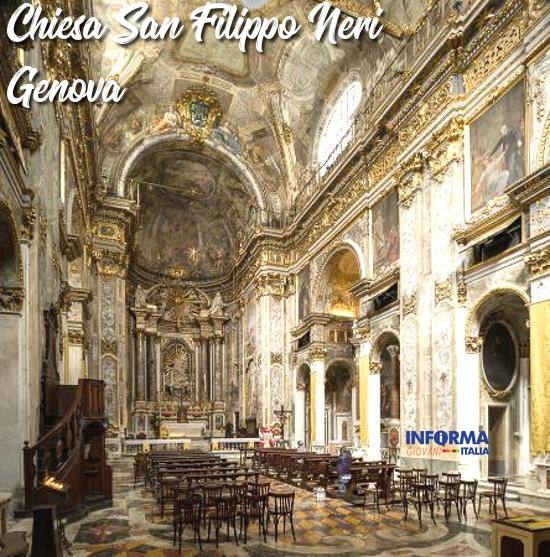 Una domenica sera, il 27 ottobre 1782, nacque in un'umile famiglia di
Genova, ancora per
pochi anni capitale
dell'omonima Repubblica, Niccolò Paganini, terzo dei sei figli di Antonio
Paganini e
Teresa Bocciardo. Niccolò, fu battezzato il 28
ottobre nella Chiesa di San Salvatore in Piazza Sarzano. Tra i suoi
fratelli sopravvissuti c'erano Biagio, Carlo e Teresa. Non si sa nulla degli
altri due. Sembra che tra i suoi antenati ci fossero persone che in un modo
o nell'altro erano coinvolte nella musica. Si dice anche che la madre ebbe
un sogno premonitore di carattere divino, in cui un angelo le annunciò che
suo figlio sarebbe diventato un uomo grande e famoso e avrebbe realizzato le
sue ambizioni. Una domenica sera, il 27 ottobre 1782, nacque in un'umile famiglia di
Genova, ancora per
pochi anni capitale
dell'omonima Repubblica, Niccolò Paganini, terzo dei sei figli di Antonio
Paganini e
Teresa Bocciardo. Niccolò, fu battezzato il 28
ottobre nella Chiesa di San Salvatore in Piazza Sarzano. Tra i suoi
fratelli sopravvissuti c'erano Biagio, Carlo e Teresa. Non si sa nulla degli
altri due. Sembra che tra i suoi antenati ci fossero persone che in un modo
o nell'altro erano coinvolte nella musica. Si dice anche che la madre ebbe
un sogno premonitore di carattere divino, in cui un angelo le annunciò che
suo figlio sarebbe diventato un uomo grande e famoso e avrebbe realizzato le
sue ambizioni.
Suo padre, lavorava al porto. Ci sono state molte
supposizioni circa il suo lavoro, ma sembra che facesse il facchino.
Un uomo meritevole, ma sempre in condizioni disagiate, che trovava spesso
sfogo nel gioco d'azzardo, e passava ora dopo ora a dipanare elaborati
"sistemi" connessi con attività di gioco di ogni tipo. Il suo sogno costante
sembra essere stato quello di scoprire una via alla ricchezza che avrebbe
ovviato alla fastidiosa necessità di dover lavorare. Scoprire di aver generato un genio musicale
in suo figlio Niccolò poteva fare avverare il suo sogno. Pare che Antonio racimolasse qualche soldo anche come suonatore di mandolino nell'orchestra
locale. Era un musicista insomma, ed anche grazie a questo notò subito il talento musicale del figlio,
cominciando a insegnargli il mandolino all'età di cinque anni e il violino
da quando ne aveva sette. Antonio probabilmente insegnò anche a Carlo, il
figlio maggiore.
L'infanzia di Niccolò trascorse in un periodo in cui
l'Europa era spazzata dai venti della rivoluzione francese prima e delle
guerre napoleoniche poi. La sua famiglia viveva in un popoloso sobborgo di
artigiani. Da adulto, Paganini non ricordò questo periodo della sua vita
come un periodo felice. I suoi genitori erano abbastanza religiosi, fece la
sua prima comunione in età molto giovane e tutta la famiglia frequentava
regolarmente la parrocchia locale. Di quando andava a messa, ricordò in
seguito che i toni dell'organo lo colpivano molto violentemente, e lo
facevano addirittura tremare e piangere: era una persona ipersensibile ai
suoni, che, insieme al suo fisico delicato, gli davano forti esperienze
spirituali ed emotive.
La sua salute risultò precaria fin da giovanissimo.
All'età di sette anni si ammalò di scarlattina, una malattia benigna nei
bambini, ma che in Niccolò assunse una virulenza insolita che fece temere
per la sua stessa vita. Quello che è certo è che il padre si prese cura del
figlio in modo appassionato e totalizzante e svolse il ruolo di mentore al
meglio delle sue possibilità. Fece tutto il possibile per rafforzare
l'educazione di Niccolò, gli fornì i migliori insegnanti per l'apprendimento
musicale e lasciò persino il suo lavoro e la sua famiglia per molti mesi per
accompagnare il giovane violinista.
Molti anni dopo, a Vienna, Paganini raccontò che da
bambino suonava il violino dalla mattina alla sera. Il severo genitore lo faceva esercitare lasciandolo all'occorrenza senza mangiare. Il suo
spirito ribelle ne soffrì, ma il suo amore per la musica gli fece sopportare
questa disciplina ferrea, a cui più tardi attribuì smodatamente le sue
frustrazioni e la sua infelicità.
Il suo talento musicale progredì rapidamente, tanto
che un giovanissimo Paganini produsse una composizione, Variazioni sulla Carmagnola,
all'età di nove anni. Il padre lasciò che Niccolò imparasse il violino
rispetto al mandolino, mandandolo a lezione da Giovanni Servetto, un
violinista dell'orchestra locale. Anche prima del nuovo maestro, Niccolò
aveva iniziato a sperimentare le sue prime composizioni: sonate, capricci e
persino concerti. Servetto si rese conto che il suo allievo aveva un talento
straordinario, e che era necessario un maestro più capace: lo indirizzò
quindi a Francesco Gnecco. Quest'ultimo portò Niccolò dal marchese
Gian Carlo di Negro, un giovane aristocratico genovese, un entusiasta
mecenate delle arti, che decise di sostenere finanziariamente Niccolò.
Gnecco a sua volta lo presentò al maestro
Giacomo Costa. Paganini ricorderà con affetto quest'ultimo maestro che,
a quanto pare, non fu in grado di insegnargli molto, poiché il giovane
Niccolò seguiva le proprie inclinazioni.
Nel 1793, per sei mesi, Paganini ricevette 30 lezioni da Costa,\ che dopo sei mesi lasciò che Niccolò si esibisse in diverse chiese di Genova.
Secondo i documenti esistenti, Paganini si presentò per la prima volta
davanti al pubblico il 26 maggio 1794, in un concerto nella Chiesa di San
Filippo Neri. La sua seconda esibizione pubblica fu nella Chiesa di
Nostra Signora delle Vigne per la festa di Sant'Eligio, il 1 dicembre
1794. Questa esibizione fu presentata sul giornale Avvisi
(inizialmente Foglio di notizie ed avvisi diversi), un giornale che
stampava gli eventi del giorno a Genova nel periodo tra il 1777 e 1797.
Paganini, che continuò ad esibirsi in concerti pubblici, suonò di nuovo alla
Chiesa di San Filippo Neri nel maggio 1795. Il 30 maggio 1795,
Avvisi, scriveva in un suo articolo che il pubblico aveva assistito a "un
armonioso concerto eseguito da un piacevole ragazzo di 12 anni, il signor
Niccolò Paganini, allievo del signor Giacomo Costa, professore di violino,
che si è concluso con l'universale ammirazione e approvazione".
Parma,
Lucca, Alessandro
Rolla, Gasparo Ghiretti, Ferdinando Paer
 Nel 1795 Paganini aveva fatto così tanti progressi che
suo padre dovette trovare un maestro di maggior levatura, che lo aiutasse a
spiccare definitivamente in volo; oltre alla musica il nuovo tutore doveva
fare in modo di ampliare i suoi orizzonti valoriali e doveva aiutarlo a
imparare a distinguere tra idee estetiche buone e cattive. Questa figura
era, secondo lui, il Maestro Alessandro Rolla, primo violino della
Reale Orchestra di Parma.
Antonio Paganini per supportare le spese del figlio a
Parma,
decise di raccogliere denaro con un concerto al Teatro di Sant'Agostino
nel luglio 1795, cosa che ebbe un grande successo. Nel 1795 Paganini aveva fatto così tanti progressi che
suo padre dovette trovare un maestro di maggior levatura, che lo aiutasse a
spiccare definitivamente in volo; oltre alla musica il nuovo tutore doveva
fare in modo di ampliare i suoi orizzonti valoriali e doveva aiutarlo a
imparare a distinguere tra idee estetiche buone e cattive. Questa figura
era, secondo lui, il Maestro Alessandro Rolla, primo violino della
Reale Orchestra di Parma.
Antonio Paganini per supportare le spese del figlio a
Parma,
decise di raccogliere denaro con un concerto al Teatro di Sant'Agostino
nel luglio 1795, cosa che ebbe un grande successo.
Nel marzo 1796, le truppe rivoluzionarie francesi
invasero il nord Italia, e Genova non era un posto sicuro. La famiglia di
Paganini, con gli echi rivoluzionari alle porte, aveva preferito spostarsi nella loro proprietà di campagna a Romairone,
nell'attuale quartiere di San Quirico, vicino al quartiere di Bolzaneto. In
questo periodo Paganini avrebbe suonato per la prima volta la
chitarra. Dopo aver acquisito la padronanza dello strumento, preferiva
suonare di fronte a conoscenti piuttosto che in concerti pubblici, e più
tardi, durante il suo tour di concerti, descrisse la chitarra come la sua
"compagna costante".
Antonio e suo figlio partirono per Parma all'inizio del 1796 per
vedere Rolla. Niccolò racconta che quando arrivarono a casa del maestro,
questi mandò a dire che non poteva riceverli perché era indisposto. Durante
l'attesa, avevano visto un violino e un manoscritto su un tavolo; Antonio
esortò Niccolò a cogliere l'occasione per catturare l'interesse del maestro
suonando. Il compositore malato, sentendo Niccolò suonare, si destò subito
interessato, e chiese chi stesse suonando in quel modo subito. Non poteva
credere che fosse un ragazzo. Tuttavia, quando si convinse, spiegò che
Niccolò aveva bisogno di un diverso tipo di insegnante e lo mandò dal
Maestro Ferdinando Paër, un distinto compositore parmense di origine
tedesca, molto ben inserito negli ambienti musicali, e che in seguito sarebbe
stato molto apprezzato da Napoleone tanto da diventare "compositore di corte
di Sua Maestà Imperiale" per 28.000 franchi che nel 1812 lo nominò
successore di Gaspare Spontini come direttore del Théâtre-Italien di
Parigi
carica che tenne fino al 1827.
Secondo Rolla, Niccolò aveva bisogno di un insegnante di composizione
esperto, perché aveva raggiunto un'abilità melodica e una maturità inventiva
sorprendente. Paër inizialmente non poteva occuparsi del giovane perché era
immerso nella composizione di un'opera. Così Rolla mandò Niccolò dal suo
maestro, Gasparo Ghiretti, secondo violoncellista dell'Orchestra
Reale. Quando Paër finì di scrivere la sua opera, mandò a chiamare il
giovane e lo istruì personalmente durante il suo periodo a Parma. Con il
nuovo maestro, il giovane scrisse ventiquattro fughe per quattro
mani, senza l'aiuto di alcuno strumento, solo con carta, inchiostro e penna.
In un'occasione Paër chiese a Niccolò di scrivere un duetto, che, una volta
finito, vide con grande piacere e disse che non poteva trovare alcun errore
della forma pura nella scrittura della composizione musicale. Nello stesso
periodo continuò a prendere lezioni anche da Gasparo Ghiretti ed ebbe nuovi
problemi di salute, dopo quelli, serissimi, avuti durante la sua infanzia,
contraendo questa volta una polmonite.
Questi erano anche i tempi in cui l'impero napoleonico si stava
espandendo in tutta Europa, compresa l'Italia. Anche se Napoleone aveva
appena firmato un armistizio con il Duca di Parma, il luogo non era adatto a
un giovane malato come Niccolò, che così tornò temporaneamente a Genova con
suo padre.
Quando Paganini si riprese dalla polmonite, si preparò per iniziare a dare
concerti nelle città d'Italia, scegliendo
Livorno per la sua
prima uscita. Il concerto doveva iniziare alle otto di sera, la sala era
piena, ma i musicisti che dovevano accompagnare Niccolò non si erano
presentati. Alla fine, solo alcuni di loro arrivarono. Il giovane decise di
accettare la sfida di suonare da solo per il suo pubblico, riuscendo a
intrattenerlo per tre ore. Quando finì, ricevette un sonoro e lunghissimo
applauso.
Nel periodo 1800-1801 poiché era difficile trovare sale da concerto a
Milano,
Bologna
e Firenze,
si dedicò a suonare in città più piccole. Questo è il periodo in cui Niccolò
cominciò a cercare di rendersi definitivamente indipendente da suo padre. Il
ragazzo si rese conto di dover avere il tempo per pensare, la libertà di
provare la vita in diverse sfaccettature; in altre parole, doveva essere
libero di determinare il proprio destino, nel bene e nel male. Dopo la sua
esperienza livornese, il giovane Paganini si diresse verso la città di
Lucca
nel 1801; questa volta viaggiando col fratello maggiore Carlo, completamente
libero dalla presenza paterna. Presto avrebbe compiuto diciannove anni.
 Paganini si esibì con successo al Festa di Santa Croce di
Lucca il 14
settembre 1801, e fu nominato primo violino dell'Orchestra della Repubblica
di Lucca. Nella città toscana arrivò a guadagnare in modo significativo dal
lavoro come libero esecutore e dai concerti. Continuò anche a comporre, e nel 1802
iniziò a comporre 24 Capricci per violino solista.
Tuttavia, mentre la sua vita diventava più libera sfuggendo al controllo
paterno, iniziò anche a giocare d'azzardo, e più tardi dovette vendere il
suo violino per ripagare i debiti accumulati. Aveva nel frattempo sviluppato
altri vizi, bevendo e conducendo una vita che potremo definire "libertina",
costruendosi una solida reputazione di donnaiolo. Paganini si esibì con successo al Festa di Santa Croce di
Lucca il 14
settembre 1801, e fu nominato primo violino dell'Orchestra della Repubblica
di Lucca. Nella città toscana arrivò a guadagnare in modo significativo dal
lavoro come libero esecutore e dai concerti. Continuò anche a comporre, e nel 1802
iniziò a comporre 24 Capricci per violino solista.
Tuttavia, mentre la sua vita diventava più libera sfuggendo al controllo
paterno, iniziò anche a giocare d'azzardo, e più tardi dovette vendere il
suo violino per ripagare i debiti accumulati. Aveva nel frattempo sviluppato
altri vizi, bevendo e conducendo una vita che potremo definire "libertina",
costruendosi una solida reputazione di donnaiolo.
Il suo temperamento era stato represso durante tutta
l'adolescenza, non aveva conosciuto nessuna ragazza di cui invaghirsi, e
così, staccandosi da suo padre, fu coinvolto in una serie di relazioni
amorose, restando sempre abbastanza risoluto nella sua avversione al
matrimonio. A Lucca visse con Francesco e Anna Bucchianeri. Una delle
figlie di questa famiglia, Eleonora, divenne il suo primo amore. Le dedicò
la sua opera 3, scritta tra il 1802 e il 1809.
Nel 1805, Lucca fu annessa ai domini di Napoleone, e la sorella di
quest'ultimo Elisa Baciocchi, divenne le principessa di Lucca e
Piombino, la quale, nello stesso
anno nominò Paganini primo violinista della sua corte lucchese. Lo nominò
anche insegnante di violino per suo marito, Felice Baciocchi. In
questo periodo Paganini compose una quantità significativa di musica da
camera, in particolare la Sonata Napoleone, oltre a quartetti per archi e chitarre, e
il conosciuto Duetto Amoroso.
Nel 1809, Elisa Baciocchi divenne la Granduchessa di Toscana e la sua
corte fu trasferita a Firenze. Poiché Paganini era un membro del suo
entourage, si trasferì a sua volta in riva all'Arno come violinista solista.
Tuttavia non passò molto che lasciò l'incarico per intraprendere nuovamente
una attività autonoma.
Questo fu anche il periodo in cui Niccolò scrisse la versione finale dei
suoi Capricci. I ventiquattro Capricci furono le opere più
importanti pubblicate durante la sua vita. Diversi compositori che vennero
in seguito furono influenzati profondamente da queste composizioni, Schumann
e Liszt fra tutti.
Paganini raccontò di questo periodo che: "In molte
città mi è stato chiesto di rimanere, in alcune come concertista, in altre
come direttore d'orchestra. Ma il mio temperamento rifuggiva da una
posizione fissa. Mi piaceva viaggiare ed era impossibile per me rimanere a
lungo in un solo posto". Questa citazione deve essere presa anche in
riferimento ai suoi primi anni a Lucca, quando godeva del "profumo" della
libertà, termine a cui gli sarà associata una parola della fonetica simile:
libertinaggio.
Una volta raccontò a un amico il seguente aneddoto, che dà un'idea
della popolarità e della bravura che aveva ormai raggiunto: "Una delle
mie escursioni, un viaggio di piacere, mi portò a Livorno, dove mi fu
chiesto di dare un concerto. Un ricco uomo d'affari e amante della musica,
il signor Livron, mi prestò un Guarneri (un violino prestigioso al pari
degli Stradivari, costruito dal famoso liutaio Giuseppe Guarneri) perché
non avevo con me il mio violino. Tuttavia, quando finita la mia performance
si rifiutò di riprenderlo... Ebbi un'esperienza simile a Parma. Il signor
Pasini, un eccellente pittore, aveva sentito parlare della mia abilità nella
lettura musicale a vista. Mi presentò un concerto piuttosto difficile e mi
disse che mi avrebbe regalato un violino di valore se avessi potuto eseguire
in modo soddisfacente ciò che avevo visto. Anche in quel caso il violino è
diventato di mia proprietà".
Paganini non era interessato alla politica, vivendo alla giornata,
concentrato sui propri interessi e sugli obbiettivi che si era prefissato.
Tuttavia, i nobili volevano ascoltarlo e lui doveva ascoltare le loro
richieste, così come fece con la monarca di Lucca.
Probabilmente Paganini ebbe una relazione con Elisa Baciocchi, ma i suoi
biografi ipotizzano anche una relazione tra il violinista e la principessa
Paolina Borghese, l'altra bellissima sorella di Napoleone, immortalata dal
Canova
in una memorabile scultura. Durante un tour di concerti che da Livorno lo
portò fino a Torino, Paganini contrasse il primo attacco di colite cronica
che lo avrebbe disturbato da allora in poi.
Reputazione internazionale e
vita bohemienne
 Negli anni successivi, Paganini si esibì in concerti nelle aree
circostanti Parma e Genova. Il 29 ottobre 1813, si esibì per la prima
volta in un concerto alla
Scala di Milano. Questo concerto fu un grande successo, attirando
l'attenzione di musicisti importanti in tutta Europa, e nelle successive
dieci settimane, tenne altri sei concerti nella stessa sede. Negli anni successivi, Paganini si esibì in concerti nelle aree
circostanti Parma e Genova. Il 29 ottobre 1813, si esibì per la prima
volta in un concerto alla
Scala di Milano. Questo concerto fu un grande successo, attirando
l'attenzione di musicisti importanti in tutta Europa, e nelle successive
dieci settimane, tenne altri sei concerti nella stessa sede.
Ben presto cominciò ad essere considerato come uno dei migliori, se non il
miglior violinista d'Europa, dando più di 100 concerti in molte città italiane,
tra cui Genova, Parma, Firenze, Torino,
Napoli,
Bologna,
Venezia e
Roma. Per ora la sua attività concertistica era ancora limitata
all'Italia. In questo periodo cominciò ad avere problemi di salute, dovuti
in parte allo stile di vita dissoluto. All'inizio dei suoi 30 anni, si dedicò a un tipo di esistenza che
includeva molto le apparenze e l'esteriorità da esporre; sviluppò qualità
esteriori che costruirono il personaggio che conosciamo, la sua iconografia:
pose e affetti, che contribuirono molto alla sua fama e lo trasformarono in
un musicista da palcoscenico, una figura che oggi potremo definire come "showman";
qualcosa che i critici o gli ammiratori consideravano diabolico nella
teatralità dei suoi gesti, l'incredibile destrezza, la prontezza di
sfruttare, senza rivelare la sua personalità: l'istinto innato dell'uomo di
spettacolo. Tutto questo, insieme alla sua tendenza a scendere dal dignitoso
parallelo in cui si muove un autentico artista al basso livello del
prestigiatore, configurarono un concetto che oggi chiameremo di costruzione
del proprio personaggio, un'immagine sostenuta anche dal suo abbigliamento
stravagante.
Paganini si guadagnava da vivere in caffè, sale da
ballo, teatri, club, casinò. In questi ultimi poi vinceva o perdeva fortune
in un giorno. Cedeva alla tentazione di questi posti durante tutto l'anno e
giocava solo quando aveva bisogno di soldi, in una vana e illusione ricerca
di riscatto finanziario. Per sua fortuna i concerti gli permettevano di guadagnare
molto bene. A Milano si "prese" un piacere dopo l'altro: ogni sera belle
donne venivano nel suo camerino al Teatro alla Scala. Cominciava proprio
allora a diffondersi la sua fama di uomo dalla figura diabolica e malvagia.
A quei tempi i concerti strumentali erano una cosa rara; uno strumentista,
per attirare il pubblico, doveva combinare il suo concerto con un balletto e
alcuni numeri vocali; o suonare un concerto nell'intervallo di un'opera.
In senso creativo, per tredici lunghi anni, dal 1800 al 1813, compose solo opere minori: la Sonata Napoleone, il Duetto amoroso,
scritto poche settimane prima del suo soggiorno a Milano nel 1813, solo
alcuni quartetti e piccole opere per chitarra e pezzi occasionali.
Angelina
Cavanna
Nel 1814 il trentunenne Paganini incontrò tra i carruggi, le strade e i
vicoli di Genova, Angelina (o Angiolina) Cavanna. Figlia di un
sarto, poco più che ventenne, Angelina a dispetto di un viso grazioso e
innocente e dei suoi modi impeccabili, ha frequentazioni molto libere per i
suoi tempi, frequentazioni di cui il padre è all’oscuro e anche Paganini.
Dopo un corteggiamento serrato la giovane rende noto al padre la sua
frequentazione con il musicista, il quale non è affatto contrariato della
cosa, anzi. Si procede a un fidanzamento "ufficiale" in base al quale
Angelina si concederà solo dopo il matrimonio. In tutto questo c'era il
fatto che Angelina, come detto, era di frequentazioni libere, e che Paganini
continuava nella sua vita libertina.
 Paganini chiesa ad Angelina di trasferirsi con lui a
Parma. Lei accettò con il consenso del padre e i due partirono per la città
emiliana. Nella città emiliana trascorsero diverse settimane di grande
romanticismo, finché un giorno, osservando le frequenti nausee che
presagivano la gravidanza, lui disse che sarebbe uscito in strada per bere
qualcosa. Passò tutto il giorno fuori. A quel punto anche gli accordi
precedenti vennero meno e i due "fidanzati" vissero a Parma per tre mesi
"more uxorio" fino a quando la ragazza si accorse di essere incinta. Paganini chiesa ad Angelina di trasferirsi con lui a
Parma. Lei accettò con il consenso del padre e i due partirono per la città
emiliana. Nella città emiliana trascorsero diverse settimane di grande
romanticismo, finché un giorno, osservando le frequenti nausee che
presagivano la gravidanza, lui disse che sarebbe uscito in strada per bere
qualcosa. Passò tutto il giorno fuori. A quel punto anche gli accordi
precedenti vennero meno e i due "fidanzati" vissero a Parma per tre mesi
"more uxorio" fino a quando la ragazza si accorse di essere incinta.
Appresa la notizia, Paganini non la prese bene, partì e
si trasferì a Milano. La Cavanna si trasferì a sua volta a Fumeri. nel comune
di Mignanego (nell'alta Valpolcevera), da una sorella dove Paganini promise di
raggiungerla. Venne raggiunta invece dal padre che vista la situazione
denunciò il musicista per "mancata promessa di matrimonio", "rapimento e
violenza di una minorenne" (allora si raggiungeva la maggiore età a 21
anni) e
"tentativo di procurato aborto" avendo convinto la ragazza a ingurgitare una
pozione venefica. Paganini tornò a Genova il 6 maggio e per lui scattarono
le manette e un po' di notti insonni nelle anguste prigioni nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. Il 13 maggio al processo si difenderà davanti
ai giudici proclamando la sua innocenza: lui non aveva
costretto la ragazza a seguirlo e neppure l'aveva costretta ad avere
rapporti sessuali. Sul matrimonio prometterà di mantenere il patto e di
affidare il prossimo nascituro alle cure della propria famiglia.
Paganini fu scagionato e liberato dietro il pagamento
di 1.200 lire quale indennità di rimborso al padre della giovane. Quando Angelina
diede alla luce un bambino nato morto i legami tra i due si dissolsero
rapidamente.
A Milano
Anche se come virtuoso del violino Paganini aveva pochi
rivali o forse non ne aveva affatto, era sempre ansioso di misurare le sue
capacità sfidando gli artisti che potevano eseguire assoli di violino,
specialmente i concertisti russi o francesi. In un'occasione gli fu offerta
l'opportunità di ascoltare il violinista francese Charles Philippe Lafont.
Paganini propose un "duello" musicale. Fu un evento storico, che ebbe luogo
alla
Scala di Milano nel 1816 e andò oltre i limiti del programma.
Entrambi eccellevano, ma Paganini vinse la sfida.
Più tardi, dopo alcuni concerti alla Scala, Lafont poté
apprezzare le qualità musicali di Paganini e gli chiese di esibirsi insieme
in un concerto. Suonarono Rodolphe Kreutzer; nella parte "solista"
Paganini diede libero sfogo alla sua immaginazione suonando alla maniera
italiana, uno stile che gli era naturale. Lafont suonò poi un tema russo,
con una formidabile gamma di variazioni, concludendo con una sua
composizione, Le Streghe. Entrambi ricevettero ovazioni e
acclamazioni.
Nel dicembre 1816 Paganini incontrò Lord Byron,
il poeta inglese, che lo aveva precedentemente sentito in un teatro di
Venezia. I due passarono insieme l'ultimo mese del 1816 e i primi
mesi del 1817. In un'occasione Byron disse al virtuoso qualcosa di molto
personale sul successo che il musicista cercava di inseguire ogni giorno con
una ostinazione ossessiva: "Le acclamazioni della folla, la ricchezza,
l'amore, la popolarità, vi sembrano deliziose, ma anche quando attraverso il
genio e il duro lavoro avete assaggiato tutte queste delizie, presto le
troverete stucchevoli. Questo lascerà in voi un vuoto timido e spaventoso, e
allora direte con me, nonostante tutto questo sforzo e questa ansia: non
sono contento di questo mondo."
Antonia Bianchi,
Marietta Banti e Dida
Al suo ritorno a Milano Paganini ricevette la notizia
della morte di suo padre avvenuta il 1° aprile 1817, che apparentemente non lo scosse
più di tanto. In quel periodo fondò la sua compagnia, composta da
un'orchestra e da diversi cantanti e si innamorò di un'altra donna,
Marietta Banti. Paganini scrisse di lei: "Mio unico e grande amore!
La mia penna non può descrivere la mia gioia nel ricevere la vostra gentile
lettera. È vero che la vostra partenza mi ha causato un grande dolore, il
più grande dolore che un uomo innamorato come me possa avere. Ma pazienza!
Vi prego di fare di tutto per tornare a Bologna il più presto possibile, il
che mi darà il più grande piacere... Addio, mio grande amore, mio tutto."
Scrisse anche che ciò che desiderava di più era il matrimonio con la
Banti, dichiarandosi l'uomo più innamorato di tutti.
 Cambiò ancora una volta idea sulla sua amata e sul matrimonio e andò a
Roma. Qui ebbe difficoltà a ottenere un teatro perché fuori dai
giri che contavano nella società chiusa della città, dove il Vaticano
controllava gli eventi musicali e tutte le altre manifestazioni. Dovette
aspettare molto tempo prima che gli alti gerarchi ecclesiastici dessero la
loro approvazione affinché il musicista avesse accesso al famoso teatro
Argentina. Paganini cercò di affittare il teatro San Carlo,
sostenendo che il suo prestigio internazionale lo meritava. Cambiò ancora una volta idea sulla sua amata e sul matrimonio e andò a
Roma. Qui ebbe difficoltà a ottenere un teatro perché fuori dai
giri che contavano nella società chiusa della città, dove il Vaticano
controllava gli eventi musicali e tutte le altre manifestazioni. Dovette
aspettare molto tempo prima che gli alti gerarchi ecclesiastici dessero la
loro approvazione affinché il musicista avesse accesso al famoso teatro
Argentina. Paganini cercò di affittare il teatro San Carlo,
sostenendo che il suo prestigio internazionale lo meritava.
L'imperatore austriaco, Francesco II,
accompagnato dal cancelliere Metternich e dalla sua ultima figlia, la
contessa Esterhazy, arrivò a Roma alla fine del marzo 1819. L'ambasciatore
austriaco presso la Santa Sede diede un grande ricevimento in onore del
monarca e incluse Paganini tra i seicento ospiti. Questo rappresentò la
prima apparizione dell'ormai famoso virtuoso nei circoli della diplomazia e
della società romana. Fu anche presentato al potente cancelliere. Quando gli
fu chiesto di suonare, Niccolò si scusò di non avere con sé il suo violino,
opportunità che ebbe modo di mostrare, insieme al suo talento, qualche tempo
dopo.
Fu a Roma che cominciò ad ammalarsi di esaurimento nervoso e sviluppò una
tosse acuta che non lo lasciava mai. Il suo medico gli raccomandò di
prendere un po' d'aria fresca in campagna. La sua salute, tuttavia, peggiorò
e si diffuse la voce che aveva contratto la tisi, la tubercolosi polmonare.
Il suo padrone di casa era così allarmato dalla sua condizione che lo
sfrattò, buttandolo letteralmente in strada. Proprio in quel momento passava
il suo pupillo, Gaetano Ciandelli, che lo portò a vivere con lui in
una comoda periferia.
Sua madre, Teresa Bocciardo, cominciò nello stesso periodo a pretendere
sempre più insistentemente che il figlio si sistemasse mettendo su famiglia
e dandole dei nipoti. Questo ravvivò il suo desiderio d'amore, tanto che
alla fine di giugno del 1821 scriveva alla madre: "Ho finalmente deciso
di seguire i dettami del mio cuore e prendere come moglie una giovane donna
affascinante, figlia di una famiglia molto eccellente; una giovane donna che
unisce la bellezza all'educazione più completa. Mi ha incantato e, anche se
non ha una dote, mi piace molto e l'ho scelta per essere felice al suo
fianco. Sì, se il cielo approva, non posso desiderare una felicità più
grande."
Nervoso, impulsivo, ardente di desiderio, amante
impaziente, i cui precedenti amori non lo avevano abituato ad aspettare, si
comportava come in modo che potremo definire immaturo. Incontrò la sua
Giulietta durante un soggiorno a
Napoli, dove si era stabilito prendendo casa nei quartieri Spagnoli,
nello stesso periodo in cui erano di casa anche Gioacchino Rossini e
Gaetano Donizetti. La fanciulla si chiamava Carolina Banchieri,
figlia dei coniugi Teresa Ruiz e Romualdo Banchieri. All'epoca
della lettera alla madre, la futura sposa di Nicolò Paganini, allora
trentanovenne, avrebbe avuto dodici anni e sette mesi (era nata a Napoli il
9 novembre 1808), età nella quale sarebbe stato a dir poco difficile
riconoscere le qualità di una "fanciulla piena di tutte le grazie fisiche
e morali". Un’ipotesi, a dire il vero non del tutto remota, seppure non
supportata da fonti documentarie, potrebbe lasciare spazio alla supposizione
per la quale la Banchieri potesse essere in attesa di un figlio, spingendo
quindi il violinista verso la via immediata del matrimonio.
Improvvisamente, però, l'amore si fermò anche in questa
circostanza. Sembra che Niccolò avesse chiesto a Carolina di andare in
tournée con lui all'inizio di novembre 1821, ma come accadde con
Angelina Cavanna, il tormentato musicista la abbandonò dopo averla portata
con sé prima viaggiando verso Roma e fermandosi a Velletri, quindi
proseguendo da solo e arrivando a Parma un giorno di novembre.
All'età di 40 anni, la sua salute era sempre più carenti. Consultò il
dottor Sira Borda dell'Università di Pavia, che gli diede una cura di
oppio e mercurio per un'infezione da sifilide. Questo trattamento avrebbe
aggravato ulteriormente la situazione e avuto in seguito gravi conseguenze
sul suo corpo. Fu un periodo in cui i suoi disturbi cominciarono a causargli
gravi disagi a cui dovette rassegnarsi con pazienza. Il dottor Borda gli
consigliò di rimanere a
Pavia. Qui compose una serie di brevi opere per un'altra donna,
Dida, che aveva già incontrato nel 1801. Paganini la chiamava Dida ma il
suo vero nome è a tutt'oggi sconosciuto. Secondo i suoi biografi, ebbe una
relazione con lei. Chiunque fosse, rimase, nella vita del maestro, una delle
figure più romantiche e misteriose.
La sua saluta peggiorava, a ciò di cui soffriva si
aggiunse l'ittero, una malattia che lo indebolì ulteriormente. Alla fine di
ottobre del 1822 interruppe il suo trattamento a Pavia e andò da sua madre a
Genova trattenendosi per cinque mesi. Nella sua città diede concerti e insegnò. Un
allievo, il futuro violinista e compositore Camillo Sivori, dichiarò
in seguito: "È probabilmente il peggior maestro di violino che sia mai
vissuto.... Ha detto che l'abilità non è necessaria, ciò che è richiesto è
la perseveranza e l'applicazione". Nonostante questa dichiarazione
Paganini dedicherà a Sivori una sua composizione.
Fu a Venezia che Niccolò incontrò Antonia Bianchi,
la donna che sarebbe diventata la madre del suo unico figlio, Achille.
Antonia era una ragazza affascinante, una ballerina che Paganini avrebbe
trasformato in una cantante. I due rimasero a
Venezia per quattro mesi nel 1824. Da lì trascorsero diverse
settimane a
Trieste prima di dirigersi verso sud alla fine di dicembre.
Intrapresero un viaggio attraverso il mare Adriatico: volevano cambiare
scenario. La relazione con Antonia si approfondì e lei divenne l'amante che
lo seguiva ovunque, con l'idea fissa di sposarlo. Soggiornarono poi Napoli,
con una tappa interlocutoria a Bologna, dove Paganini diede due concerti al
Teatro del Corso; quindi arrivarono a Roma dove il musicista diede diversi concerti al
Teatro Argentina.
Dopo questa parentesi la relazione del musicista con la Bianchi cominciò
a traballare, come sempre accadde nelle sue relazioni sentimentali. Paganini
cercò di rompere con donna ma la Bianchi non ne voleva sapere di lasciarlo e
annunciò di essere incinta. La donna era inoltre diventata la cantante
principale della compagnia; quando il Maestro seppe della gravidanza iniziò
a cercare un'altra cantante come sostituta, scegliendo Lucrezia Cortesi
di Firenze. Antonia tuttavia resistette al suo posto come cantante
principale.
Le voci della gravidanza dell'amante, insieme ad altre voci malevole,
oltre a vere e proprie calunnie sul conto di Paganini, raggiunsero i quattro
angoli d'Europa. Il 23 luglio 1825, Antonia diede alla luce suo figlio,
realizzando una delle sue più grandi ambizioni; lo chiamò orgogliosamente
come tre grandi eroi della storia, Achille Ciro Alessandro. A quanto
pare, con la nascita del bimbo, i legami tra Niccolò e Antonia si
rafforzarono, almeno nel breve periodo, rafforzati al punto che lui pensò
seriamente alla possibilità di legalizzare la relazione. Anche questa volta
fece marcia indietro e non pensò più a sposarsi.
Antonia Bianchi, per un certo tempo, sembrava soddisfare gli aspetti
passionali della sua natura, ma Paganini sembrava concentrato sulla visione
di una bellezza ideale. Questa ricerca era solo un altro aspetto della sua
ambizione. Desiderava anche acquisire ricchezza, posizione sociale e gloria.
La monogamia non era nelle sue corde. Era difficile immaginarlo come il
modello di un uomo che torna a casa dopo un concerto, in cerca di pace e
tranquillità con la propria moglie e la propria famiglia.
Partì quindi per una grande tournée in Europa, in compagnia di Antonia e
del piccolo Achille, ma si ammalò nuovamente di una grave bronchite che lo
lasciò stremato con attacchi soffocanti e una tosse profonda e dura. Si
riprese faticosamente, rimanendo però ancora più magro ed emaciato. La sua
figura assunse un'aria spettrale, diabolica si sarebbe detto in seguito.
Antonia assistette Paganini durante i problemi di salute del virtuoso,
non smettendo di credere che la fiamma della passione sarebbe rinata,
scontrandosi tuttavia con un muro insormontabile. Il suo carattere ferito la
fece diventare calcolatrice, avida e gelosa, a momenti auto-commiserante,
crudele, brusca e orgogliosa. La convivenza non era più possibile, ma
Antonia si rifiutò sempre di lasciarlo andare senza una rendita adeguata che gli
avrebbe permesso di vivere dignitosamente. Fu un periodo in cui Paganini non
sentì più il calore delle braccia di una donna, dovendo accontentarsi
dell'amore del suo piccolo Achille. Si rese conto che, nonostante tutto,
poteva fare da padre e da madre al bambino, e cercò, per questo, di
staccarsi dall'assillante presenza di Antonia. Dopo un concerto di
beneficenza a Milano e un altro a Pavia, mentre era pronto a partire per
Vienna, venne colpito da un altro attacco influenzale.
Paganini aveva promesso ad Antonia, ancora prima che il figlio Achille
nascesse, che l'avrebbe portata con sé a Vienna, e ora sembrava non pronto a
mantenere la parola data. Per la donna il nocciolo della questione era
quello di ottenere un sostentamento economico. Infine, dopo una continua pressione sul compositore,
la donna riuscì ad ottenere una rendita di 100 scudi milanesi.
Vienna
Paganini partì per Vienna, la capitale mondiale della musica, una mattina
di marzo del 1823, all'età di 41 anni.
Quando arrivò nella capitale austriaca, non era estraneo ai viennesi. Per
più di un decennio le notizie della sua straordinaria abilità avevano
attraversato le Alpi. Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte, Vienna fu
dominata dal gusto della classe media in ascesa. Paganini faceva parte
dell'immaginario di coloro che, staccati dalla nobiltà, erano capaci di
distinguersi per i propri meriti. Artisti, intellettuali e poeti parlavano
di questo nuovo tipo di personalità, non più dei membri della corte o
dell'alto clero; era necessario conoscerli, leggerli, ascoltarli. Arrivato
in città, la gente, con curiosità, cominciò a parlare di lui, tanto che
raggiunse presto una fama insolita, senza che avesse fatto il minimo sforzo.
I viennesi volevano vedere con i propri occhi tutto ciò che di meraviglioso
avevano sentito sul suo conto. Per competere con i virtuosi, locali, Hoffmann e
Kreisler, le malelingue dicevano che non bisognava essere un
essere umano. Vennero fuori altre dicerie, tra il serio e il pettegolezzo,
circa un fantomatico patto col diavolo; così la leggenda di Paganini si è
diffuse in lungo e in largo, toccando i sentieri oscuri che ancora oggi
seguono l'immagine del musicista. Nei teatri, nei caffè, nei saloni e nelle
sale da concerto, e persino nei negozi, Paganini era il tema.
 Il virtuoso suonò nelle sale del reale
Palazzo dell'Hofburg. Dopo aver vissuto in un hotel, si trasferì in
un lussuoso appartamento nel Trattnerhof, il complesso residenziale privato,
nel
Graben, una delle vie-piazze centrali più importanti di Vienna, che
aveva ospitato anni prima anche Mozart. Dopo una settimana di riposo, fissò
il suo primo concerto per il 28 marzo 1829; ma dovette spostarlo al giorno
successivo, perché quel giorno era un giorno di veglia. Tra il pubblico
c'erano i più importanti esponenti della società viennese, artisti e
letterati oltre ai membri influenti della colonia italiana in città e
critici professionisti. Quando il sipario cominciò ad aprirsi, apparve una
figura cadaverica, nell'ombra, vestita tutta di nero, che guardava il suo
pubblico a metà con paura e a metà con disprezzo. Non appena il sipario si
aprì completamente, il pubblico scoppiò in un lungo applauso. Il virtuoso suonò nelle sale del reale
Palazzo dell'Hofburg. Dopo aver vissuto in un hotel, si trasferì in
un lussuoso appartamento nel Trattnerhof, il complesso residenziale privato,
nel
Graben, una delle vie-piazze centrali più importanti di Vienna, che
aveva ospitato anni prima anche Mozart. Dopo una settimana di riposo, fissò
il suo primo concerto per il 28 marzo 1829; ma dovette spostarlo al giorno
successivo, perché quel giorno era un giorno di veglia. Tra il pubblico
c'erano i più importanti esponenti della società viennese, artisti e
letterati oltre ai membri influenti della colonia italiana in città e
critici professionisti. Quando il sipario cominciò ad aprirsi, apparve una
figura cadaverica, nell'ombra, vestita tutta di nero, che guardava il suo
pubblico a metà con paura e a metà con disprezzo. Non appena il sipario si
aprì completamente, il pubblico scoppiò in un lungo applauso.
Il suo viso rifletteva un'intensa sofferenza mentale, come fosse una
maschera, con un'espressione fastidiosa e cupa che contrastava con i suoi
occhi vivaci. Una volta iniziato a suonare, però, come succedeva sempre, una
forza interiore sembrava impossessarsi di lui. Tutte le membra del suo corpo
si animavano e i suoi occhi diventavano ancora più vivaci e i movimenti
divennero sicuri e definiti. La sua espressione sembrava il riflesso di un
conflitto interiore, la sofferenza più indicibile, il gesto più crudele, il
disprezzo più tagliente, tutti insieme, personificati. Il giorno dopo i
critici diedero notizie deliranti sulla sua esecuzione. Nella loro eloquenza
riuscirono solo a dire che ciò che avevano visto e sentito, era
indescrivibile. Per avere un'idea dell'atmosfera inquietante che aveva
provocato nella sala, si sarebbe dovuto - dicevano i critici - averla
vissuta di persona.
La sua musica non fu mai etichettata come italiana, né in Austria né in
Germania, anche da coloro che avevano forti sentimenti nazionalistici e
cercarono sempre di definirla geograficamente. E con una sola eccezione, non
fu accusato - come Liszt - di suonare musica economica e banale. Durante la
sua carriera mise Beethoven su un alto piedistallo; non c'era giorno in cui
non suonasse qualcosa di questo grande maestro. Nella maggior parte dei suoi
concerti, soprattutto nelle sue prime apparizioni, suonava invariabilmente
un suo pezzo, come se invocasse lo spirito del suo genio. In un'occasione,
assistette a un concerto in cui veniva eseguita la musica di Beethoven.
Quando ebbe finito, il suo accompagnatore si voltò verso di lui e rimase
stupito nel vedere lacrime dense che gli scorrevano sulle guance. "È morto",
fu tutto quello che riuscì a dire. Questo è stato forse uno degli omaggi più
sentiti alla memoria del grande compositore originario di
Bonn.
La moglie del principe Metternich, Maria Antonietta Leykam, una
bella viennese con un tocco di sangue italiano, chiese al maestro di suonare
ad un ricevimento, il 15 maggio 1828, in onore dello stesso principe per il suo
compleanno. Come ardente amante della musica, Metternich non avrebbe potuto
ricevere un regalo migliore. In questo stesso periodo diede un concerto di
beneficenza e ricevette come premio dalla città di Vienna la grande medaglia
Salvator, che gli fu conferita dal conte Rudolf von Czernin. Nonostante i
successi, la salute di Paganini continuava a peggiorare.
Malattie e salute
Non era ancora trascorso molto tempo a Vienna quando Antonia riprese le sue
pretese economiche. Arrivò a portare via con se il figlio Achille, tanto che
Paganini gli fece causa per recuperare la custodia del piccolo. Decise
quindi di pagare un'ultima somma alla donna quantificata in 3531 fiorini.
Riottenne di ricongiungersi al figlio e da quel momento fino alla sua morte,
si prese cura del bambino e lo educò.
In un concerto che diede alla fine di luglio del 1831, non incontrò
l'approvazione della critica, che vide la sua performance come un errore,
dipingendolo come un ubriacone inetto. Alla sua salute precaria si
aggiunsero seri problemi ai denti. Tutto era dovuto a una cura che gli era
stata prescritta dal medico italiano Borda a Pavia, che gli aveva
consigliato di assumere dosi eccessive di mercurio. Il medico che lo visitò
a Vienna, si allarmò dallo stato dei suoi denti; ne mancavano tanti e quelli
rimasti erano in uno stato drammatico. A quel tempo, l'odontoiatria era
ancora praticata in modo rudimentale, e non c'è da stupirsi che gli venne
consigliato di farsi operare alla mascella. Cosa che non fece, dopo altri
consulti che cercarono di tamponare in qualche modo la situazione.
 Cominciò quindi a fare i preparativi per un giro nelle province
austriache e tedesche, oltre a visitare
Praga. Arrivò a Carlsbad, dando un concerto nella Sachsische
Saal e ricevendo il notevole compenso di 860 fiorini. Decise quindi di dare
un secondo concerto, che gli portò tuttavia solo 495 fiorini, a causa
di una "svista" nella vendita dei biglietti da parte del suo nuovo
segretario Antonio Caccio. L'accaduto fece terminare bruscamente il
lavoro di quest'ultimo. Intanto la sofferenza per i problemi ai denti si
faceva sempre più forte e per questo motivo si recò a Praga il 4 ottobre
cercando di ottenere un altro consulto medico. Venne visitato all'ospedale
di Praga dal dottor Julius Vincenz Edler von Kromholz e da Franz Willibald
Nusshard, assistente della clinica chirurgica che, dopo averlo esaminato e
avere
appurato un pericolo infezioni in corso, ordinarono un'operazione immediata
alla mascella inferiore, che eseguirono il 10 ottobre. Trascorse i giorni
successivi in convalescenza al fianco del figlio. Subì quindi un'altra
operazione in cui vennero rimossi una serie di molari. In questo periodo
Paganini scrisse ad un amico: Cominciò quindi a fare i preparativi per un giro nelle province
austriache e tedesche, oltre a visitare
Praga. Arrivò a Carlsbad, dando un concerto nella Sachsische
Saal e ricevendo il notevole compenso di 860 fiorini. Decise quindi di dare
un secondo concerto, che gli portò tuttavia solo 495 fiorini, a causa
di una "svista" nella vendita dei biglietti da parte del suo nuovo
segretario Antonio Caccio. L'accaduto fece terminare bruscamente il
lavoro di quest'ultimo. Intanto la sofferenza per i problemi ai denti si
faceva sempre più forte e per questo motivo si recò a Praga il 4 ottobre
cercando di ottenere un altro consulto medico. Venne visitato all'ospedale
di Praga dal dottor Julius Vincenz Edler von Kromholz e da Franz Willibald
Nusshard, assistente della clinica chirurgica che, dopo averlo esaminato e
avere
appurato un pericolo infezioni in corso, ordinarono un'operazione immediata
alla mascella inferiore, che eseguirono il 10 ottobre. Trascorse i giorni
successivi in convalescenza al fianco del figlio. Subì quindi un'altra
operazione in cui vennero rimossi una serie di molari. In questo periodo
Paganini scrisse ad un amico:
"Se sapeste quanti nemici stanno incitando contro di me, non ci
credereste mai. Non ho mai fatto il minimo male a nessuno e anche chi non mi
conosce mi dipinge come la creatura più infame, avara, egoista, ecc... Ho
annunciato che raddoppierò il costo dell'ingresso al resto dei concerti che
darò in Europa. Non ho mai trovato utile che, mentre non sto cercando di
farmi pubblicità, circolino su di me tutte queste stupide sciocchezze. Se
faccio piacere alla gente come artista, possono credere a tutte le storie
romantiche che vogliono."
Le malelingue critiche sostenevano che "chiunque" poteva suonare come lui
da mancino, con un po' di pratica, e che la tecnica del "pizzicato" poteva
essere suonata dopo sei mesi. Quando Paganini sentì queste voci, si limitò a
sorridere e ad alzare le spalle. Mantenne la sua compostezza e non mostrò
segni di risentimento, ma è certo che il suo orgoglio artistico venne
ferito. Queste storie circolavano in Europa, soprattutto in Germania, un
paese che avrebbe visitato presto. La verità è che la sua abilità era
aumentata enormemente nel corso degli anni, al punto che conosceva tutti i
concerti a memoria.
In Germania
 Da quando si stabilì a
Francoforte, Paganini cominciò a dedicare più tempo al figlio; lo
portava ovunque andasse. Achille era un bambino di tre anni e mezzo che
cominciava a parlare tedesco con grande facilità, per la gioia del padre.
Quando gli fu chiesto se avrebbe fatto del ragazzo un altro violinista,
rispose: "Perché no? Se vuole imparare, glielo insegnerò volentieri".
Anni dopo sembrava aver cambiato idea: "Finché vivrò, mio figlio non
suonerà il violino. Farò quello che posso, per fare di lui un buon
contrappuntista, ma mai un violinista". Quello che è certo è che Achille
non fu costretto a fare qualcosa contro la sua volontà: fu educato a seguire
le proprie inclinazioni. Da quando si stabilì a
Francoforte, Paganini cominciò a dedicare più tempo al figlio; lo
portava ovunque andasse. Achille era un bambino di tre anni e mezzo che
cominciava a parlare tedesco con grande facilità, per la gioia del padre.
Quando gli fu chiesto se avrebbe fatto del ragazzo un altro violinista,
rispose: "Perché no? Se vuole imparare, glielo insegnerò volentieri".
Anni dopo sembrava aver cambiato idea: "Finché vivrò, mio figlio non
suonerà il violino. Farò quello che posso, per fare di lui un buon
contrappuntista, ma mai un violinista". Quello che è certo è che Achille
non fu costretto a fare qualcosa contro la sua volontà: fu educato a seguire
le proprie inclinazioni.
Paganini ricevette quindi un'offerta da
Berlino per tenere dei concerti, chiedendo un compenso di 24.000
scudi per sei esibizioni. Il grande violinista aveva anche una
reputazione di avarizia che era sicuramente infondata. Era certamente
attento al denaro e ai suoi averi, ma era sempre pronto ad aiutare le
persone meno fortunate di lui, come nel caso del giovane Hector Berlioz,
che aiutò con una notevole somma di denaro. Inoltre, non visse mai nel lusso
e non pensò mai alla ricchezza come motivo di gloria.
Dopo il suo ultimo concerto a Praga tentò quindi l'avventura in Germania,
rimandando tuttavia la data della partenza in attesa del suo amico e
segretario Lazzaro Rebizzo, che allora lo accompagnava nei suoi tour.
Alla Rebizzo tardò troppo e Paganini partì ugualmente la notte del 22
gennaio 1829 per
Dresda, cercando di cancellare dalla sua memoria l'ingratitudine
ricevuta a Praga. Da Dresda, si diresse verso Berlino. Qui venne accolto
alla corte del re di Prussia Federico Guglielmo III, che gli mise a
disposizione il Teatro Reale per i sei concerti precedentemente concordati.
Ancora una volta, la sua salute precaria si mise di traverso, impedendogli
di darne anche solo uno. Nonostante questo, si offrì di suonare alcuni
intermezzi all'Opera Reale tra gli
atti. Il re autorizzò la sua richiesta ed egli si dedicò a dare concerti di
beneficenza, per i quali era molto grato alla gente della città.
In Polonia
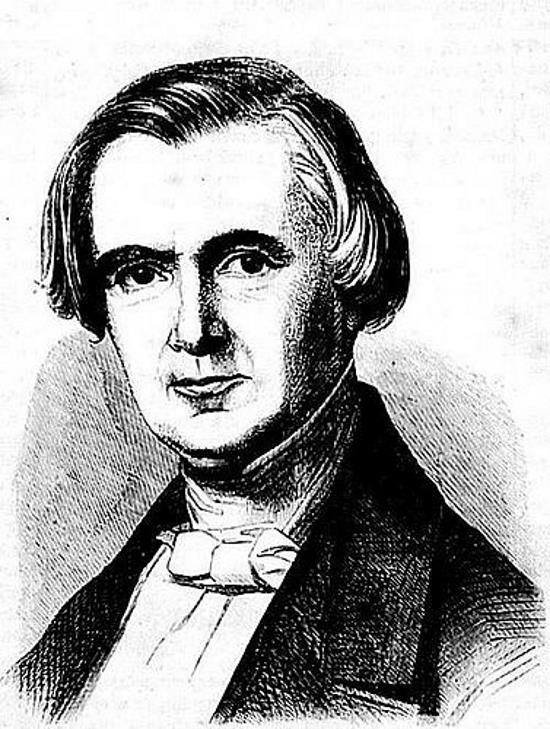 Paganini ricevette un invito anche da parte polacca per suonare
all'incoronazione dello zar Nicola come re di Polonia il 24 maggio e
ricevette anche alti onori prussiani e russi. Tutte queste attività e
riconoscimenti impliciti animavano il suo spirito più delle questioni
finanziarie, che pure lo attiravano molto. Prima di partire per Varsavia
ricevette una lettera dal re Federico Guglielmo di Prussia: "Ho deciso di
darvi, prima della vostra partenza dalla mia capitale, un segno della
soddisfazione che ho provato assistendo ai vostri concerti. La natura vi ha
dato un talento raro, che avete coltivato con uno spirito originale. I suoni
che producete arrivano all'anima ed eccitano nel cuore del pubblico le
emozioni più rare. Vi ho nominato mio Primo Maestro di Concerto Onorario e
vi autorizzo a usare questo titolo." Paganini ricevette un invito anche da parte polacca per suonare
all'incoronazione dello zar Nicola come re di Polonia il 24 maggio e
ricevette anche alti onori prussiani e russi. Tutte queste attività e
riconoscimenti impliciti animavano il suo spirito più delle questioni
finanziarie, che pure lo attiravano molto. Prima di partire per Varsavia
ricevette una lettera dal re Federico Guglielmo di Prussia: "Ho deciso di
darvi, prima della vostra partenza dalla mia capitale, un segno della
soddisfazione che ho provato assistendo ai vostri concerti. La natura vi ha
dato un talento raro, che avete coltivato con uno spirito originale. I suoni
che producete arrivano all'anima ed eccitano nel cuore del pubblico le
emozioni più rare. Vi ho nominato mio Primo Maestro di Concerto Onorario e
vi autorizzo a usare questo titolo."
In Polonia all'incoronazione dello zar russo a
Varsavia, divise gli onori con il compositore, violinista e
direttore d'orchestra Karol Lipinski, da tempo un altro virtuoso in
competizione con lui. Dopo l'incoronazione, cominciò a suonare nel palazzo
reale tra 130 ospiti illustri. Successivamente, eseguì le sue composizioni
in un concerto di beneficenza per le vedove e gli orfani di musicisti al
Teatro Nazionale, e terminò il suo soggiorno a Varsavia con due concerti
all'inizio di luglio.
La tecnica di Niccolò Paganini
 "Ho pianto solo due volte in vita mia: quando un tacchino farcito di
tartufi mi cadde nell'acqua e quando sentii suonare Paganini"
Gioacchino Rossini "Ho pianto solo due volte in vita mia: quando un tacchino farcito di
tartufi mi cadde nell'acqua e quando sentii suonare Paganini"
Gioacchino Rossini
Andando un po' sul tecnico, e ci scuserete per questo, secondo l'opinione
di uno dei suoi critici, i punti che distinguevano Paganini dagli altri
violinisti erano:
In primo luogo, il suo peculiare metodo di suonare, in cui il musicista
impiegava un sistema usato nella seconda metà del XVII secolo per produrre
effetti particolari, e che lo aiutavano a suonare o eseguire con facilità
passaggi che sarebbero stati impossibili da capire nella loro chiave
originale. Qui stava il segreto di molti dei suoi effetti, delle successioni
corali e così via. In secondo luogo, la serie di inchini che lo distingueva
dagli altri violinisti, facendone un uomo di spettacolo oltre che un
musicista. In terzo luogo, la combinazione dei pizzicati della mano sinistra
con i saluti. La scuola tedesca e anche quella francese avevano dimenticato
questa tecnica. Per eseguirla correttamente è necessario che il secondo,
terzo e quarto dito della mano sinistra tirino le corde in modo chiaro ed
esatto, il che è difficile sulla terza e quarta corda, soprattutto quando il
dito che preme la corda sul ponte è vicino al dito che tira fortemente la
corda. Un'ulteriore attenzione era rivolta al ponte, che era più basso del
solito, rendendo le posizioni più alte più facili per la mano e rendendo
possibile diteggiare tre corde allo stesso tempo. Le corde erano leggermente
più alte del ponte, il che permetteva di suonare passaggi forti senza i
rumori che di solito li accompagnano. Quarto, l'uso delle armonie molto
personale.
Molto è stato scritto all'epoca sulla tecnica che Paganini usava per
ottenere effetti musicali mai sentiti prima e per mostrare una così grande
abilità. Si parlava della tensione delle corde, del posizionamento delle
corde rispetto all'arco, della dimensione dell'arco, del suo incredibile
modo di armonizzare, che a volte dava l'impressione di ascoltare due violini
contemporaneamente, della sua memoria impressionante, eccetera.
Franz Liszt, uno dei grandi virtuosi del pianoforte, ascoltò attentamente
Paganini, lo memorizzò e poi trasferì il suo modo di fare musica dal violino
al pianoforte. Ma l'effetto non fu lo stesso. Solo chi lo ascoltava
direttamente godeva della magia delle sue interpretazioni. In gran parte la
sua tecnica era nelle sue mani e nel suo corpo, come diceva lui.
È un peccato, alla luce dei prodigiosi progressi tecnologici del XIX, XX
e finora XXI secolo, che le possibilità di eternare gli esecutori attraverso
la registrazione non siano esistite allora, come per i compositori
attraverso la scrittura. Le esecuzioni uniche di brillanti cantanti e
strumentisti di quel tempo sono state perse per sempre.
Prima di Paganini nessuno pensava che fosse possibile suonare non solo
armonie semplici ma anche armonie in terze, quinte e seste, e che le melodie
normali potessero essere combinate con armonie in ottave. Ma è riuscito a
farlo, in qualsiasi posizione, e con una facilità sorprendente. Il segreto
della sua diteggiatura nessuno è stato in grado di svelarlo; forse l'unica
delle sue composizioni che scrisse dove si possono intuire alcuni dei suoi segreti è il Cantabile
per violino per chitarra, dedicato
al violinista e compositore genovese Camillo Sivori, ora nella collezione
Reuther, lo stesso che lo giudicò un pessimo Maestro. Le sue diteggiature
sono alquanto eterodosse o, meglio ancora, indipendenti dalle leggi della
diteggiatura; il risultato di un metodo profondamente ragionato e non un
semplice capriccio. Usava nella diteggiatura un dito invece di un altro, ma
più spesso usava un dito per diverse note. A quanto pare, Paganini scopri le
sue diteggiature mentre suonava la chitarra, in cui lo scorrimento dei
semitoni è impossibile da tradurre dai ponti di metallo. Aveva bisogno di
dita diverse per ogni semitono.
Per quanto riguarda le dimensioni delle sue mani, un medico del suo tempo
che ebbe l'opportunità di esaminarle trovò che le dita della mano sinistra
erano leggermente più lunghe di quelle della destra, forse a causa di una
particolare disposizione dei muscoli della spalla destra. Inoltre, poteva
tenere il violino con il mento, il che dava grande libertà alla sua mano
sinistra.
La sua immaginazione era molto attiva, molto creativa, sia nel senso di
esprimere le proprie passioni ed emozioni, sia nel senso di fuggire da se
stesso e proteggersi in se stesso. Il musicista suonò anche molte
composizioni di Beethoven e Mozart, ma non soffrì mai di subalternità o
della perdita della propria personalità. Al contrario: in qualche modo
ci mise sempre la sua inconfondibile impronta personale.
Secondo l'opinione di uno dei suoi medici, il dottor Bennati, il nocciolo
della questione risiedeva nel fatto che la natura o l'esercizio intenso, o
entrambi insieme, avevano modellato il suo corpo per soddisfare le esigenze
specifiche dei suoi strumenti preferiti e in modo tale che nessuno poteva
imitarli, nel al tempo, ne dopo.
Helene von Feuerbach
Ritroviamo Paganini all'inizio degli anni 30' dell'800 in Germania a dare
concerti pubblici, alcuni dei quali per beneficenza. Rimase nel paese per
due anni. Le giovani signore della società tedesca impazzivano letteralmente
quando lo sentivano suonare ai suoi concerti. Con tante attenzioni, i
propositi di maritarsi tornarono a presentarsi. Non passava mese senza che nuove candidature fossero sottoposte al suo amico avvocato Luigi
Guglielmo Germi. Quest'ultimo nel gennaio 1831, mentre il figlio Achille
era a letto con la rosolia, gli comunicò che suo fratello Carlo era morto e
che anche sua madre era gravemente malata.
Si innamorò di nuovo, questa volta di una signora di Berlino, Helene
von Feuerbach, una baronessa figlia di un giurista e diplomatico, che
tre anni prima aveva sposato un uomo che non amava. Era andata a
Norimberga per ascoltarlo e aveva pregato suo marito di tornare per
sentire un secondo concerto. Dopo aver parlato con lui aveva ceduto alla
personalità del maestro e aveva giurato di morire se non fosse diventata sua
moglie.
Da una lettera all'avvocato Germi:
"Ella ha dichiarato di rinunziare a tutte le mie ricchezze, e di non
voler che la mia mano. Che ne dici di tutto questo? È molto difficile
trovare una donna che mi ami quanto Elena. È vero che quando sentono il mio
linguaggio musicale, l'oscillazione delle mie note le fa tutte piangere; ma
io non sono più giovane, né sono più bello; anzi sono diventato bruttissimo."
Helene era una donna di aspetto piacevole e di buona educazione, convinta
di divorziare per lui. Sembra che Paganini ricambiò il sentimento e si
innamorò di lei, poiché scrisse a un amico affermando il suo desiderio di
sposarla affinché potesse diventare la madre di Achille. Quando la
donna andò a trovarlo a
Francoforte, passarono diversi giorni insieme. Il Maestro non era
più giovane, aveva quarantotto anni e il suo aspetto era magro e molto
sciupato. Lui stesso era consapevole di essere diventato brutto e di non
poter aspirare al favore di una nobildonna con il suo aspetto. Tuttavia,
Helene, che era stata educata molto severamente, si era sposata per ordine
dei suoi genitori, e quando ebbe l'opportunità di sciogliere i legami che la
legavano, cadde nelle braccia di Paganini. Era civettuola e capricciosa, a
volte isterica. Ottenne il divorzio il 14 novembre 1830, dopo aver vissuto
quattro anni senza amore e con l'evidente aspettativa di diventare la moglie
di Paganini. Non si sa se lui l'abbia esortata a divorziare o se la stesse
solo usando come argine per soddisfare le sue richieste. Sembra che avesse
intenzione di portarla con sé a Parigi, città che intendeva visitare dopo i
suoi soggiorni in Germania e in Inghilterra.
L'elemento religioso avrebbe giocato un ruolo importante nella sua
relazione con Helene. La sua famiglia era protestante e ben nota per le sue
inclinazioni anti-cattoliche, quindi sarebbero stati dispiaciuti se si fosse
sposata con il rito cattolico.
Paganini voleva sposarla, ma le sue continue e tipiche titubanze, miste
al timore di nuovi scandali, sfociarono ancora una volta nel nulla. Il
Maestro chiese altro tempo, mentre lei, dopo un periodo in ritiro
spirituale, prese a viaggiare per l’Europa. È ciò che fece anche Paganini,
mai pago di nuovi trionfi. A Parigi fu un coro di lodi, neppure il raddoppio
dei prezzi sembrò spaventare i francesi.
Di nuovo, Paganini scomparve ed Helene cadde in uno stato di acuta
malinconia. I suoi genitori temettero che potesse tentare il suicidio come
aveva fatto suo fratello. Alla fine, andò a sua volta a vivere a Parigi,
studiò canto e restò lì per 10 anni, sperando di incontrare di nuovo il suo
amato, che non si fece mai più vivo.
Ultimi anni
Durante la sua vita Paganini soffrì di frequenti malattie croniche. Anche
se non esistono prove mediche certe, sembra che fosse affetto dalla
"sindrome di Marfan" o "sindrome di Ehlers-Danlos". La sindrome di
Marfan è una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo che causa
alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del
sistema nervoso centrale. Questa sindrome è causata da mutazioni del gene
che codifica per la proteina detta "fibrillina". I sintomi tipici possono
variare da lievi a gravi e includere braccia e dita lunghe, articolazioni
flessibili e problemi polmonari e cardiaci. Nel 1896, prese il nome di un
pediatra francese, Antoine Marfan, che per primo segnalò la malattia. Oltre
alla malattia, i frequenti concerti di Paganini e il suo stile di vita
stravagante e incontrollato influenzarono considerevolmente la sua salute.
All'inizio del 1822, a Paganini fu diagnosticata la sifilide, e le
terapie a base di oppio gli diedero gravi effetti collaterali fisici e
mentali. Nel 1834, quando soggiornò a Parigi, fu anche curato per la
tubercolosi. Si riprese abbastanza rapidamente ma dovette cancellare le sue
esibizioni a causa di vari problemi di salute che duravano da pochi giorni a
qualche mese, che andavano dal comune raffreddore alla depressione, e di conseguenza,
che di conseguenza danneggiarono la sua reputazione.
Nel settembre 1834, Paganini tornò a Genova dopo un giro di concerti, e
passò molto tempo a lavorare sulla pubblicazione delle sue opere e sulle
tecniche violinistiche. Nel 1835, tornò a Parma, e in questo periodo
l'arciduchessa Maria Luisa d'Austria, seconda moglie di Napoleone, lo
assunse. Cercò di riorganizzare l'orchestra di corte parmense, senza
tuttavia riuscirci per divergenze e veri e propri scontri con altri notabili
nella stessa corte. Dopo una parentesi a Torino, dove curò la pratica di
legittimazione del figlio (che gli verrà concessa del re Carlo Alberto), nel
1837 si recò a Nizza e a Marsiglia per dei concenti, quindi tornò a Genova
dove redisse il proprio testamento. Tornò infine a Torino per un concerto di
ringraziamento per la il "favore" concessogli dal re sabaudo.
Nel giugno del 1837 viaggiò a Parigi per partecipare alla fondazione di
un Casinò intitolato a suo nome, il Casinò Paganini, rischiando
nell'operazione buona parte dei suoi beni e sottoscrivendo un numero
cospicuo di azioni anche per conto dell’amico Lazzaro Rubizzo. Questa nuova
impresa non sarà fortunata e avrà seri strascichi finanziari. Mentre le sue
condizioni di salute peggiorano il maestro assistette a concerti di musiche di Berlioz.
Nel 1839, mentre si trovava a Marsiglia lo raggiunse la notizia di una
condanna pecuniaria inflittagli dal tribunale di Parigi per il fallimento
del "Casinò": in appello perderà la causa e sarà costretto a pagare una
cifra enormemente maggiorata. Per compensare queste perdite,
dovette consegnare gli oggetti personali, compresi i suoi strumenti,
all'asta. Non era più in grado di tenere concerti e si dedicò per questo al
commercio di strumenti ad arco, trattando l’acquisto con il violoncellista
Vincenzo Meriggi di Milano. Dopo Marsiglia si trasferì a Nizza, dove la sua
salute peggiorò ulteriormente in maniera irreparabile. Non era più in
grado di parlare. L'afonia era dovuta a "tisi laringea di origine
sifilitica" che gli era stata da tempo diagnosticata. Riusciva a comunicare
solo tramite biglietti e appunti.
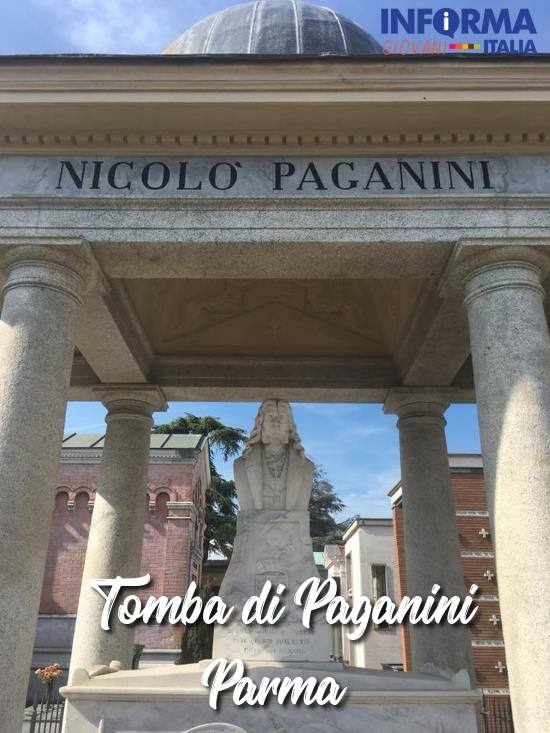 Il 20 maggio 1840, il vescovo di
Nizza inviò a
Paganini un parroco per eseguire l'estrema unzione, ma Paganini credeva che
sarebbe vissuto un po' di tempo e lo rifiutò, pensando che fosse
prematuro. Ma una settimana dopo, il 27 maggio 1840, l'artista morì
improvvisamente di emorragia interna senza ricevere l'ultimo sacramento. Il
Vescovo di Nizza, Monsignor Galvani, lo dichiarò empio, in base alla
testimonianza del Canonico Caffarelli, che era andato da Paganini per
confessarlo e che aveva apparentemente mal interpretato i gesti del musicista ormai del
tutto senza voce (e il rifiuto dello stesso Paganini di scrivere i suoi peccati su una
lavagnetta e, pare, di accettare l'accusa di coinvolgimento con il diavolo
tipica delle maldicenze che di dicevano sul suo conto). Il risultato di ciò
fu che Niccolò non ebbe né funerali né sepoltura in terra consacrata. Subito
dopo il decesso venne imbalsamato e in attesa di una sistemazione, rimase
due mesi a Nizza finché le autorità non ne ordinarono la rimozione. Dopo la
ripetuta richiesta di suo figlio Achille, i suoi resti furono trasferiti a
Genova quattro anni dopo, nella villa di Romairone, a San Biagio, in
Liguria, ma il suo corpo non poté essere sepolto nemmeno dopo il
trasferimento. Alla fine di questa vicenda incresciosa fu sepolto in un cimitero di Parma nel 1876.
Nel 1893, il violinista ceco František Ondří?ek convinse Attila, che era
nipote di Paganini, a vedere il corpo del virtuoso. Successivamente, nel
1896 la salma venne trasferita nel Cimitero della Villetta, un nuovo
cimitero di Parma, dove più tardi fu eretto un monumento dedicato al grande
virtuoso.
"Una sola cosa mi preoccupa", disse Paganini una volta in modo forse
profetico, "che dopo la mia morte sopravvivano le calunnie e che gli
invidiosi del mio successo non lascino in pace i miei resti." Il 20 maggio 1840, il vescovo di
Nizza inviò a
Paganini un parroco per eseguire l'estrema unzione, ma Paganini credeva che
sarebbe vissuto un po' di tempo e lo rifiutò, pensando che fosse
prematuro. Ma una settimana dopo, il 27 maggio 1840, l'artista morì
improvvisamente di emorragia interna senza ricevere l'ultimo sacramento. Il
Vescovo di Nizza, Monsignor Galvani, lo dichiarò empio, in base alla
testimonianza del Canonico Caffarelli, che era andato da Paganini per
confessarlo e che aveva apparentemente mal interpretato i gesti del musicista ormai del
tutto senza voce (e il rifiuto dello stesso Paganini di scrivere i suoi peccati su una
lavagnetta e, pare, di accettare l'accusa di coinvolgimento con il diavolo
tipica delle maldicenze che di dicevano sul suo conto). Il risultato di ciò
fu che Niccolò non ebbe né funerali né sepoltura in terra consacrata. Subito
dopo il decesso venne imbalsamato e in attesa di una sistemazione, rimase
due mesi a Nizza finché le autorità non ne ordinarono la rimozione. Dopo la
ripetuta richiesta di suo figlio Achille, i suoi resti furono trasferiti a
Genova quattro anni dopo, nella villa di Romairone, a San Biagio, in
Liguria, ma il suo corpo non poté essere sepolto nemmeno dopo il
trasferimento. Alla fine di questa vicenda incresciosa fu sepolto in un cimitero di Parma nel 1876.
Nel 1893, il violinista ceco František Ondří?ek convinse Attila, che era
nipote di Paganini, a vedere il corpo del virtuoso. Successivamente, nel
1896 la salma venne trasferita nel Cimitero della Villetta, un nuovo
cimitero di Parma, dove più tardi fu eretto un monumento dedicato al grande
virtuoso.
"Una sola cosa mi preoccupa", disse Paganini una volta in modo forse
profetico, "che dopo la mia morte sopravvivano le calunnie e che gli
invidiosi del mio successo non lascino in pace i miei resti."
Composizioni famose di Paganini
Paganini ha numerose composizioni a suo nome che sono considerate
fenomenali per il violino. Le più note sono i suoi 24 Capricci, una serie di
pezzi musicali per violino che furono probabilmente composti tra il 1805 e
il 1807.
Sono famosi anche il suo Ballo a Venezia, Il Fandango Spagnolo (con tutti
i tipi di suoni di animali), il 'Duetto Amoroso' e il Rondo à La
Clochette. L'opera musicale di Paganini include sei concerti per violino,
diversi pezzi da concerto per violino e orchestra, e dodici sonate per
violino e chitarra.
Riassumendo,
curiosità e leggende su Paganini
Niccolò Paganini è ben noto a chiunque abbia anche solo pensato di
prendere in mano un violino. Fu una figura che visse una vita straordinaria,
il cui catalogo di dettagli intriganti richiederebbe tante pagine e molto
tempo per essere raccontate. Possiamo tuttavia riassumerne alcuni.
1) Come
abbiamo visto il Virtuoso era piuttosto malaticcio fin da bambino. Per tutta
la sua vita Paganini fu afflitto da problemi di salute, a partire dalla sua
infanzia. Da piccolo, soffrì di un attacco di rosolia così grave, che la
leggenda vuole che i suoi genitori pensarono che fosse morto e quasi lo
seppellirono vivo. Fortunatamente, si è mosse all'ultimo momento, salvandosi
da una tomba prematura.
2) Suo
padre era incredibilmente severo con lui, questo pare essere certo. Sua
madre pregò Dio per un bambino virtuoso e sembra avesse abbia avuto una
visione al riguardo. Suo padre lo faceva esercitare il figlio
dall'alba al tramonto, lo picchiava e negava il cibo al giovane Niccolò se
non soddisfaceva le aspettative del padre. Paganini, forse anche per questo,
alla fine scelse di non insegnare a suo figlio a diventare un violinista.
3) Il
Virtuoso studiò con diversi maestri, ma dopo poco gli stessi avevano ben
poco da insegnargli.
4) Paganini
fu un contemporaneo di molti altri grandi compositori: Berlioz, Liszt,
Beethoven, Chopin, Schumann e Wagner. Paganini assistette ad un'esecuzione
della Symphonie Fantastique di Berlioz e fu così impressionato che
gli chiese di scrivere un assolo per lui. Come abbiamo visto gli prestò
anche dei soldi in un momento di bisogno. Fu sempre un grande ammiratore di
Beethoven e della sua musica. Quando Liszt passò un momento difficile a casa
di problemi sentimentali, Paganini lo aiutò ad uscire dalla depressione e a
tornare a scrivere musica.
5) Fu il
primo violinista a memorizzare quasi tutti i pezzi che eseguiva nei suoi
concerti. Prima di Paganini, era la norma per i solisti sedersi davanti al
palco ed esibirsi su spartiti. Questa, in seguito, sarebbe diventata una
pratica comune.
6) Quando
in uno dei suoi primi concerti a Livorno Paganini fu costretto a suonare e
intrattenere il pubblico da solo per tre ore, dopo che i musicisti che
dovevano accompagnarlo non si presentarono inventò, senza saperlo il
"recital". Liszt, diversi anni dopo, fu il primo ad usare il termine
"recital", quando pubblicizzò una performance nel 1840. Tuttavia, Paganini
lo aveva di fatto "inventato" prima.
7) Le
problematiche circa la sua sepoltura durarono, come abbiamo visto, molti
anni dopo la sua morte avvenuta il 27 maggio 1840. Non aveva ricevuto
l'estrema unzione e la chiesa dubitava della sua fede, il che significava
che non poteva essere sepolto su un terreno consacrato. I suoi amici si
appellarono direttamente Roma e fu avviata un'inchiesta sulla sua fede. Solo
dopo più di cinquant'anni Paganini venne sepolto definitivamente a Parma.
8) Molta
della sua musica è andata perduta. A partire dalla sonata per violino che
compose quando aveva 8 anni, molti delle composizioni di Paganini sono
andate perdute. Alcuni manoscritti sono tenuti da collezionisti privati e
non sono mai stati registrati. Molti altri sono semplicemente andati persi
nel tempo. Tra le opere mancanti ci sono sonate e quartetti, le uniche
registrazioni dei pezzi sono menzioni da Paganini stesso, registrazioni
dell'epoca, o una lista di pezzi che si dice siano
stati tenuti dal figlio di Paganini.
9)
Paganini non fu solo compositore e violinista, ma era anche un chitarrista.
Infatti, le sue radici musicali erano quelle di suonatore di mandolino (come suo
padre). Lasciò la vita pubblica per tre anni, a partire dal 1801. Si crede
che abbia trascorso quel periodo a casa di una nobildonna toscana che
preferiva che suonasse la chitarra. Anche dopo questo periodo, Paganini era
noto per suonare la chitarra per un pubblico privato, ma non pubblicamente.
Molte delle sue composizioni combinavano la chitarra con altri strumenti a
corda, come il duetto violino-chitarra, conosciute come Sonate di Lucca,
scritte durante il suo soggiorno nella città toscana.
10)
Paganini era un giocatore d'azzardo e al gioco perse il suo
violino della prestigiosa liuteria Amati. Gli fu poi prestato un
violino altrettanto importante di Giuseppe Guarnieri da un
violinista dilettante. Paganini avrebbe poi suonato solo un
Guarnieri, il più famoso è quello che ha chiamato "Cannone". Il
Cannone è ora in mostra al Museo di Palazzo Tursi, nella sua
città natale di Genova, Italia.
11)
Nonostante fosse un giocatore d'azzardo, e morì in ristrettezze
economico pur avendo guadagnato un grande patrimonio grazie alle
sue tournée, Paganini fu anche un mecenate di altri artisti.
Oltre a questo, verso la fine della sua carriera si esibì per
istituzioni caritatevoli e in concerti per sostenere artisti
indigenti.
12)
I disturbi fisici di Paganini gli permisero di suonare il
violino in quel modo giudicato unico? Le voci abbondano. Si
crede che possa aver avuto uno o due disturbi genetici. Il
primo, ne abbiamo già parlato, è la "sindrome di Marfan", un
disturbo che colpisce il tessuto connettivo del corpo, e che
spesso si manifesta con arti e dita estremamente lunghi.
Un'altra ipotesi era che Paganini avesse un'altra malattia
genetica chiamata "Ehlers-Danlos", che si manifesta nella
iper-mobilità delle articolazioni. Nessuno sa con precisione
quale sia la verità. Quello che è certo è che Paganini sviluppò
tecniche che nessun altro poteva eseguire e il suo modo di
suonare era straordinario e, ancora oggi, a detta di tutti,
inimitabile. Non c'è da meravigliarsi per questo, circa le
innumerevoli voci e dicerie che hanno cercato di spiegare in
qualche modo le sue impareggiabili abilità.
13)
Le dicerie paranormali. La teoria numero due per spiegare la sua
virtuosità era che lui (o sua madre) avessero fatto un patto con
il diavolo. A causa della sua inspiegabile destrezza e talento,
e del suo aspetto alto, magro e cadaverico, gli fu dato il
soprannome di "Der Hexensohn", o "Il figlio della strega". Era
anche chiamato in una variante simile, il "Figlio del Diavolo".
Questi soprannomi erano spesso presi alla lettera. Tanto che
quando morì, la chiesa, come abbiamo visto, si rifiutò di farlo
seppellire in terra consacrata e i suoi resti mortali ci misero
a trovare degna sepoltura
nel suo attuale luogo dell'ultimo riposo, il Cimitero della
Villetta a Parma.
14)
La famosa, unica immagine "fotografica" conosciuta di Paganini,
non è in realtà Paganini. Un suo "dagherrotipo", cioè il primo
procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini, quella che poteva essere una sua prima e unica fotografia fu
pubblicizzata nel 1900. Il liutaio Giuseppe Fiorini era la fonte
dell'immagine. Alla fine fu determinato che l'immagine era
dello stesso Fiorini, che in qualche modo l'aveva falsificata,
facendola passare per autentica per decenni. Poiché Paganini
morì nel 1840 e il processo del dagherrotipo era appena agli
inizi, essendo stato usato per la prima volta nel 1839.
15)
Una delle frasi più famose di tutte sul Virtuoso di Genova è
"Paganini non ripete": l'artista pronunciò questa frase solo una
volta nella vita, alla presenza di re Carlo di Savoia che gli
aveva chiesto un bis. L'unicità e l'irripetibilità delle sue
esecuzioni era dovuta al fatto che la maggior parte delle volte
Paganini improvvisava. Carlo Felice non la prese bene e annullò
tutti i concerti a seguire, e di certo Paganini dovette pensare
che una sola frase gli costò moltissimo, ma lui era fatto così,
era il simbolo stesso dell'artista romantico e un po' maledetto
e, a dir la verità, la sua frase si è rivelò assai fortunata.
Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.
Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:
Paypal
☕
Torna su
Ostelli Genova
Ostelli Italia
Auberges de Jeunesse Italie
Hotel Genova
Carte de Gênes
Karte von Genua
Mapa Génova
Map of Genoa
Carte de la Ligurie
Karte von Ligurien
Mapa Liguria
Map of Liguria
Carte d'Italie
Karte von Italien Mapa Italia Map of Italy |
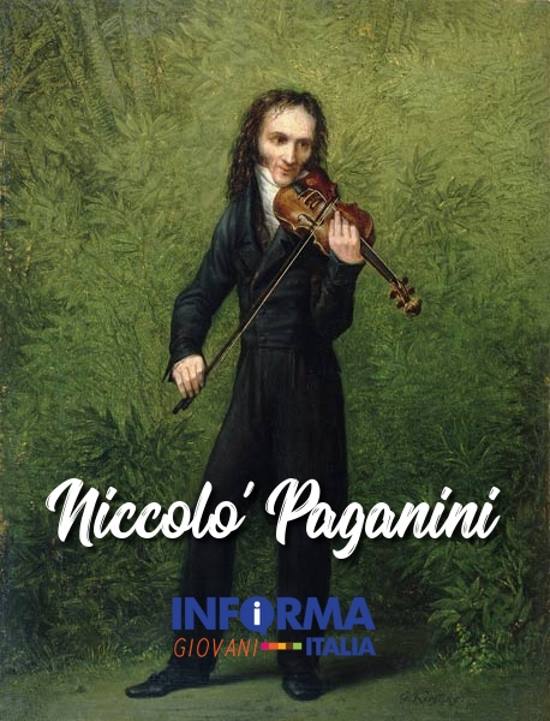

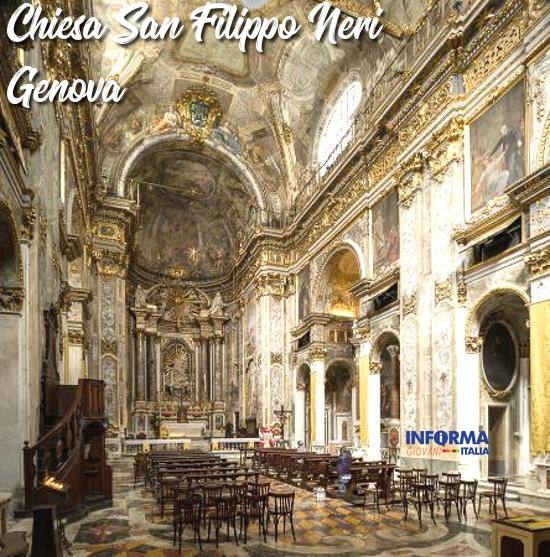 Una domenica sera, il 27 ottobre 1782, nacque in un'umile famiglia di
Una domenica sera, il 27 ottobre 1782, nacque in un'umile famiglia di  Nel 1795 Paganini aveva fatto così tanti progressi che
suo padre dovette trovare un maestro di maggior levatura, che lo aiutasse a
spiccare definitivamente in volo; oltre alla musica il nuovo tutore doveva
fare in modo di ampliare i suoi orizzonti valoriali e doveva aiutarlo a
imparare a distinguere tra idee estetiche buone e cattive. Questa figura
era, secondo lui, il Maestro Alessandro Rolla, primo violino della
Reale Orchestra di Parma.
Antonio Paganini per supportare le spese del figlio a
Nel 1795 Paganini aveva fatto così tanti progressi che
suo padre dovette trovare un maestro di maggior levatura, che lo aiutasse a
spiccare definitivamente in volo; oltre alla musica il nuovo tutore doveva
fare in modo di ampliare i suoi orizzonti valoriali e doveva aiutarlo a
imparare a distinguere tra idee estetiche buone e cattive. Questa figura
era, secondo lui, il Maestro Alessandro Rolla, primo violino della
Reale Orchestra di Parma.
Antonio Paganini per supportare le spese del figlio a
 Paganini si esibì con successo al Festa di Santa Croce di
Paganini si esibì con successo al Festa di Santa Croce di
 Negli anni successivi, Paganini si esibì in concerti nelle aree
circostanti Parma e Genova. Il 29 ottobre 1813, si esibì per la prima
volta in un concerto alla
Negli anni successivi, Paganini si esibì in concerti nelle aree
circostanti Parma e Genova. Il 29 ottobre 1813, si esibì per la prima
volta in un concerto alla
 Paganini chiesa ad Angelina di trasferirsi con lui a
Parma. Lei accettò con il consenso del padre e i due partirono per la città
emiliana. Nella città emiliana trascorsero diverse settimane di grande
romanticismo, finché un giorno, osservando le frequenti nausee che
presagivano la gravidanza, lui disse che sarebbe uscito in strada per bere
qualcosa. Passò tutto il giorno fuori. A quel punto anche gli accordi
precedenti vennero meno e i due "fidanzati" vissero a Parma per tre mesi
"more uxorio" fino a quando la ragazza si accorse di essere incinta.
Paganini chiesa ad Angelina di trasferirsi con lui a
Parma. Lei accettò con il consenso del padre e i due partirono per la città
emiliana. Nella città emiliana trascorsero diverse settimane di grande
romanticismo, finché un giorno, osservando le frequenti nausee che
presagivano la gravidanza, lui disse che sarebbe uscito in strada per bere
qualcosa. Passò tutto il giorno fuori. A quel punto anche gli accordi
precedenti vennero meno e i due "fidanzati" vissero a Parma per tre mesi
"more uxorio" fino a quando la ragazza si accorse di essere incinta.  Cambiò ancora una volta idea sulla sua amata e sul matrimonio e andò a
Cambiò ancora una volta idea sulla sua amata e sul matrimonio e andò a
 Il virtuoso suonò nelle sale del reale
Il virtuoso suonò nelle sale del reale
 Cominciò quindi a fare i preparativi per un giro nelle province
austriache e tedesche, oltre a visitare
Cominciò quindi a fare i preparativi per un giro nelle province
austriache e tedesche, oltre a visitare
 Da quando si stabilì a
Da quando si stabilì a
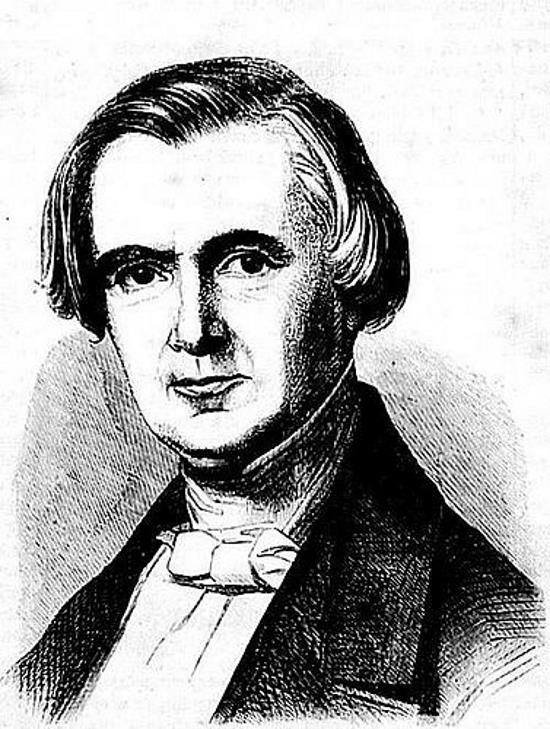 Paganini ricevette un invito anche da parte polacca per suonare
all'incoronazione dello zar Nicola come re di Polonia il 24 maggio e
ricevette anche alti onori prussiani e russi. Tutte queste attività e
riconoscimenti impliciti animavano il suo spirito più delle questioni
finanziarie, che pure lo attiravano molto. Prima di partire per Varsavia
ricevette una lettera dal re Federico Guglielmo di Prussia: "Ho deciso di
darvi, prima della vostra partenza dalla mia capitale, un segno della
soddisfazione che ho provato assistendo ai vostri concerti. La natura vi ha
dato un talento raro, che avete coltivato con uno spirito originale. I suoni
che producete arrivano all'anima ed eccitano nel cuore del pubblico le
emozioni più rare. Vi ho nominato mio Primo Maestro di Concerto Onorario e
vi autorizzo a usare questo titolo."
Paganini ricevette un invito anche da parte polacca per suonare
all'incoronazione dello zar Nicola come re di Polonia il 24 maggio e
ricevette anche alti onori prussiani e russi. Tutte queste attività e
riconoscimenti impliciti animavano il suo spirito più delle questioni
finanziarie, che pure lo attiravano molto. Prima di partire per Varsavia
ricevette una lettera dal re Federico Guglielmo di Prussia: "Ho deciso di
darvi, prima della vostra partenza dalla mia capitale, un segno della
soddisfazione che ho provato assistendo ai vostri concerti. La natura vi ha
dato un talento raro, che avete coltivato con uno spirito originale. I suoni
che producete arrivano all'anima ed eccitano nel cuore del pubblico le
emozioni più rare. Vi ho nominato mio Primo Maestro di Concerto Onorario e
vi autorizzo a usare questo titolo." "Ho pianto solo due volte in vita mia: quando un tacchino farcito di
tartufi mi cadde nell'acqua e quando sentii suonare Paganini"
Gioacchino Rossini
"Ho pianto solo due volte in vita mia: quando un tacchino farcito di
tartufi mi cadde nell'acqua e quando sentii suonare Paganini"
Gioacchino Rossini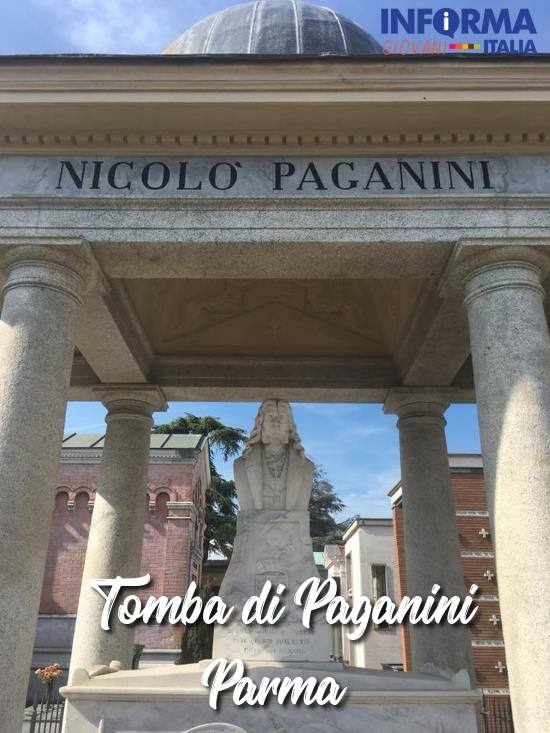 Il 20 maggio 1840, il vescovo di
Il 20 maggio 1840, il vescovo di